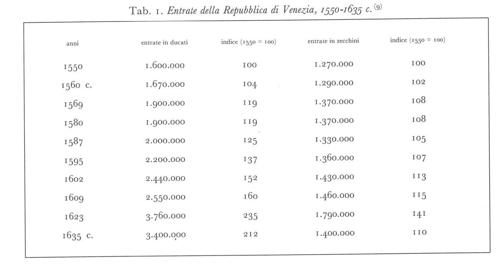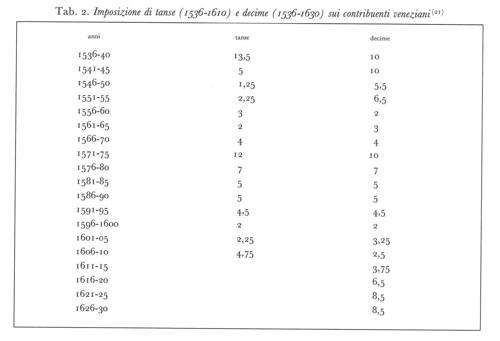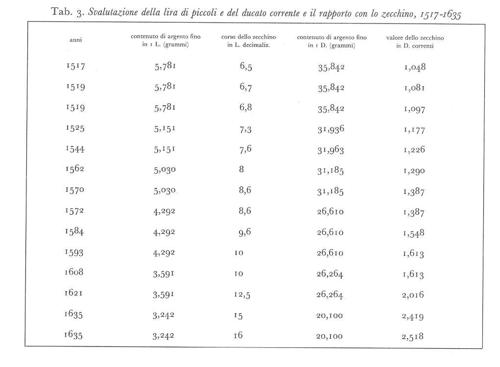La finanza pubblica
Storia di Venezia (1994)
La finanza pubblica
La capitale finanziaria
Nel 1587 Leonardo Donà - che in seguito avrebbe assunto la dignità dogale - stendendo alcuni appunti sulle entrate pubbliche di Venezia non sapeva trattenere un moto di compiaciuto stupore. I suoi calcoli dimostravano che Venezia rendeva all'erario oltre un milione di ducati all'anno: "Cosa veramente miracolosa d'una sola città in Italia" e addirittura "si potria dire unica nel mondo" (1).
Una lunga tradizione stava alla base di questo senso di superiorità del patriziato veneziano. Gli ambasciatori che tornavano dalle corti estere, riferendo sulle caratteristiche dei paesi appena lasciati tracciavano un sintetico quadro della finanza pubblica, e dalle cifre spesso emergeva, di converso, la potenza finanziaria di Venezia. Le stesse cronache facevano intendere la particolarità veneziana, almeno nella penisola.
Fra Quattro e Cinquecento il bilancio della Repubblica, con oltre un milione di ducati d'entrata annua, costituiva quasi il triplo di quello fiorentino, e circa la metà di quello del Regno di Napoli e dello Stato di Milano. E ancora a metà secolo, nonostante il coinvolgimento di vari Stati italiani nella politica imperiale degli Asburgo, con il conseguente inasprimento della pressione fiscale, Venezia manteneva ampi margini di vantaggio sulle altre finanze statali (2). Agli inizi del Seicento correva voce che le entrate raggiungessero addirittura i quattro milioni di ducati: "una somma stupefacente di denaro" - come ebbe modo di scrivere il viaggiatore inglese Thomas Coryat - che avrebbe superato del doppio i cespiti della monarchia inglese (3). Ma, al di là delle vere o false supposizioni, è significativo che l'erario desse un'impressione di floridezza; una floridezza che si associava alla prosperità dell'economia veneziana, ai suoi traffici e ai suoi mercanti.
Una prosperità che, agli occhi degli stranieri e degli stessi Veneziani, derivava anzitutto dalla città lagunare e dal suo ruolo nel sistema economico fra Occidente e Oriente. Tuttavia Venezia era anche la capitale di uno Stato che s'estendeva dalle coste di Cipro (perduta in seguito alla conquista turca nella guerra del 1570-73) alle terre d'Oltremincio, a Bergamo e a Crema. Era una vasta area da cui si traevano risorse e per cui occorreva spendere una gran quantità di denaro. Si trattava di un complesso circuito economico e finanziario che dalle estremità della Repubblica concentrava i suoi fili nella capitale. Qui giungeva gran parte del denaro riscosso nelle camere fiscali situate nei maggiori centri del Dominio di Terraferma, mentre, per quanto riguarda i territori dello Stato da mar, i proventi fiscali erano per lo più impiegati in loco. Le grandi distanze e le difficoltà di trasporto, come pure una costante tendenza deficitaria delle camere in Levante, non permettevano l'arrivo di grandi somme nelle casse veneziane.
A Venezia risiedevano gli organi di governo che avrebbero dovuto impostare la politica finanziaria della Repubblica: il senato, in primo luogo, e poi il consiglio dei dieci. Due organi che, almeno sino alla riforma del 1582-83, affiancavano e sovrapponevano le proprie competenze: debito pubblico, riscossione delle imposte, monete, sistema bancario; erano materie assai delicate e che talvolta rappresentavano il campo di scontro fra i senatori e i dieci. Durante la guerra turca del 1537-40, per esempio, entrambe le magistrature si occuparono dell'emissione dei titoli del debito pubblico (4). In seguito, comunque, la materia venne completamente avocata dai dieci, tanto che nel 1577 si poteva affermare che il consiglio dei dieci "è stà sempre supremo patron del denaro pubblico" (5). Con il ridimensionamento della sua sfera d'azione ad opera del maggior consiglio fra l'inverno del 1582 e la primavera del 1583, il controllo sulla normativa finanziaria e fiscale fu completamente assunto dal senato. Non si trattava solamente di un ritocco istituzionale nel quadro della lotta fra "vecchi" e "giovani" patrizi: il senato era un consesso dove trovavan posto circa duecento nobili; era un'assemblea eterogenea per le concezioni sulla guida dello Stato, per i fini e gli strumenti della politica fiscale. Le decisioni scaturite dal senato talvolta erano il frutto di aspri scontri e di traballanti compromessi. Nel consiglio dei dieci, viceversa, le diversità erano più sfumate; vi accedevano uomini che avevano molte cose in comune, uomini simili per ricchezza familiare, per opinioni e princìpi politici. Se i dieci si dimostravano un organo più agile, nondimeno il suo progressivo rafforzamento andava a cozzare contro la concezione allargata del governo della cosa pubblica, che costituiva uno dei pilastri della costituzione e del mito di Venezia. Il mantenimento del tradizionale sistema istituzionale, e soprattutto della sua immagine proiettata all'esterno, assicurava quei valori di stabilità dell'ordinamento politico incarnati dai grandi organi dello Stato, il maggior consiglio e soprattutto il senato. Il ceto dirigente, insomma, doveva ricomporre la propria immagine statica, che il gruppo legato al consiglio dei dieci stava incrinando, mettendo in discussione valori e regole che sino allora erano stati alla base dell'azione del patriziato. La correzione del 1582-83 può essere interpretata allora come un riassestamento degli equilibri istituzionali in funzione della continuità del sistema e dell'immagine del potere. Una sostanziale continuità che emerge anche nel settore finanziario e fiscale. Il passaggio al senato delle competenze assunte dai dieci infatti non sembra costituire, per quanto riguarda l'attività normativa e l'impostazione dei problemi, una drammatica cesura. Se il senato, una volta ridimensionato il ruolo del consiglio dei dieci, era l'organo che svolgeva il compito di tracciare e di coordinare le linee della politica finanziaria dello Stato, diverse altre magistrature minori si occupavano in concreto della materia fiscale. La moltitudine di uffici finanziari, con le loro giurisdizioni più o meno limitate e talvolta sovrapposte, non offriva certo l'immagine dell'amministrazione finanziaria come un insieme armonico ed efficiente. Ogni magistratura disponeva di una relativa cassa con cui gestiva la propria attività. Gli uffici delle rason vecchie, ad esempio, delle acque e dei provveditori di comun riscuotevano le loro entrate e le spendevano "senza darne altro conto via da loro" (6). Tuttavia occorre sottolineare che, almeno dalla metà del Cinquecento, per quanto riguarda il settore della spesa pubblica si tende ad accentuare la funzione della Zecca come organo d'erogazione. È in Zecca che affluisce la gran parte degli introiti fiscali raccolti dai diversi uffici, ed è la Zecca che, in seguito agli ordini del senato, distribuisce il denaro occorrente ai vari settori dell'amministrazione e dell'apparato statale.
La tendenza verso una centralizzazione del controllo finanziario implica altresì il problema del bilancio statale come strumento di questa stessa esigenza di vigilanza. È necessario sottolineare, ad ogni modo, che in genere non è dato rilevare nel patriziato il concetto di bilancio come strumento della politica finanziaria, tanto più che difficoltà oggettive rendevano assai ardua una esatta stesura dei rendiconti finanziari. Certo, talvolta si leva qualche voce che chiede una maggior razionalizzazione del sistema amministrativo della finanza pubblica: nella sua relazione del 1586 sul Regno di Candia, il provveditore generale Alvise Grimani non perdeva l'occasione di auspicare la messa in atto di una efficace contabilità che distinguesse "le cose del Regno", da quelle del Levante, di Venezia e della Terraferma (7). E nel giugno 1615 il senato deliberava che, in occasione dei "presenti motti d'Italia", fosse istituita in Zecca una cassa unica in cui dovessero "capitare tutte le intrade della Signoria Nostra". Nondimeno, nell'ottobre successivo, superato il momento di crisi, si tornò rapidamente al sistema di casse diversificate (8). Una cassa centrale che raccogliesse l'intero ammontare delle rendite statali avrebbe comportato in effetti la conseguenza di assegnare ad un'unica magistratura la responsabilità di uno dei settori nevralgici dell'attività statale. Era una propensione, questa, che per un certo momento venne sostenuta dal consiglio dei dieci e che, come si è già accennato, fu vanificata dall'opposizione della maggior parte del patriziato. La finanza statale rappresentava una materia troppo importante e delicata perché ricadesse sotto il controllo di un numero ristretto di nobili. La pluralità e la sovrapposizione di giurisdizioni e di reciproci controlli costituivano i cardini del sistema costituzionale veneziano; questo meccanismo doveva essere sostenuto anche a rischio di creare e avallare carenze e confusioni nell'apparato dell'amministrazione finanziaria. Oltre che centro di raccolta e di redistribuzione del prodotto fiscale, Venezia era anche la sede decisionale delle numerose vertenze e suppliche che coinvolgevano i contribuenti, le autorità e i corpi locali così come gli appaltatori dei dazi. Le corti della capitale dovevano decidere delle aspre controversie fra i sudditi e le autorità periferiche, dei dazieri che chiedevano proroghe dei pagamenti dovuti alle camere fiscali, dei singoli contribuenti e delle comunità che sollecitavano sgravi fiscali per indigenza o per calamità naturali. Ciò implica da parte del governo un'acquisizione di conoscenze ed un'elaborazione d'interventi nei confronti dei territori soggetti, e in particolare sugli strumenti fiscali locali, sull'amministrazione finanziaria delle comunità, sugli assetti del potere periferico. Dal centro, dunque, si dipartono stimoli - spesso legittimati da richieste particolari - che operano a formare col tempo una geografia fiscale meno disorganica di quanto fosse nel primo secolo della dominazione veneziana. Una centralità, quella di Venezia, che si manifesta tanto sul piano politico-istituzionale quanto su quello economico, e di riflesso su quello della finanza pubblica. A Venezia arrivano le navi e le merci dall'Oriente dirette verso l'entroterra e al di là delle Alpi; dalla Terraferma giungono grani e materie prime; attorno a Rialto si muovono con frenesia mercanti e banchieri, si stipulano contratti e si maneggiano quantità enormi di denaro. Questo ruolo nell'ambito dell'economia mediterranea, e specificamente nel quadro del vasto Stato territoriale, risalta allorché si analizzi l'ammontare delle entrate fiscali della Repubblica, alle quali la capitale partecipa con una porzione assai rilevante. Tra la metà del Cinque e il primo trentennio del Seicento le rendite globali dello Stato registrarono un notevole incremento.
Nonostante queste cifre debbano essere considerate con una certa cautela, a causa dei diversi criteri di compilazione e della incompletezza delle fonti, emerge chiaramente la progressione delle entrate statali. La stasi che si nota negli anni Settanta è probabilmente dovuta alla brusca diminuzione delle rendite provenienti dalle camere del Levante in seguito alla guerra e alla perdita di Cipro. Dagli anni Ottanta il livello delle entrate riprende l'ascesa in modo abbastanza costante sino ai primi del Seicento, per poi impennarsi negli anni che precedono la grande peste del 1630. In effetti gli impegni militari del primo trentennio del secolo (mobilitazione per l'Interdetto, guerra di Gradisca, coinvolgimento nel conflitto per Mantova e il Monferrato) avevano condotto ad una maggior richiesta fiscale dello Stato. Cosicché nell'arco di ottant'anni le rendite della Serenissima erano sostanzialmente raddoppiate in termini nominali. Tuttavia, se trasformiamo la valuta corrente in ducati d'oro (che per tutto il periodo considerato mantennero un intrinseco di 3,49 grammi d'oro), il tasso d'incremento si ridimensiona notevolmente. In ogni caso, conviene ricordare che lo Stato si cautelava pretendendo dai contribuenti e dagli appaltatori dei dazi un'addizionale sui versamenti effettuati in valuta corrente, che registrava una progressiva svalutazione rispetto alla buona valuta (10).
Le rendite fiscali che si ricavavano da Venezia costituivano una quota rilevante dell'intero bilancio. Verso la metà del Cinquecento la Dominante contribuiva all'incirca per la metà delle entrate, la Terraferma con il 40%, e le terre dello Stato da mar con il 10-12%. Nel secondo decennio del Seicento la percentuale di Venezia scendeva attorno al 45%, e ad un valore analogo si portava il Dominio di terra, mentre le colonie del Levante si mantenevano su un quinto delle entrate, nonostante la perdita di Cipro (11). L'importanza di Venezia, dunque, veniva confermata dalle entrate fiscali e ciò destava - come già si è accennato - stupore e meraviglia. A ben vedere, però, questi sentimenti non erano del tutto giustificati. Certo, la capitale, con i suoi 150.000 abitanti, appariva dare alle casse dello Stato un contributo sproporzionato rispetto al resto dei territori, popolati da circa due milioni di persone; nondimeno Venezia accentrava in sé - in maniera più o meno coatta - numerosi fili commerciali sia interni alla Repubblica che internazionali, oltre che un enorme potenziale di beni e servizi, degni di una capitale di uno Stato territoriale e di uno dei maggiori centri economici d'Europa. E non è un caso che le imposte sul commercio costituissero una parte rilevante delle entrate. I soli dazi veneziani sull'entrata e sull'uscita delle merci coprivano tra il 10 e il 15% delle rendite statali tra la metà del Cinque e gli inizi del Seicento; e l'imposta sul vino rappresentava un altro 10% (12). Inoltrandosi nel Seicento la percentuale assegnata a questi dazi diminuisce sino al 15% nel ventennio attorno alla peste. Si tratta forse di una flessione dell'attività commerciale di Venezia? I dati fiscali possono solamente suggerire il problema, non certo offrire una risposta. Le imposte sul commercio, ad esempio, non possono essere distinte chiaramente da quelle gravanti sul consumo; il calo di alcune entrate daziarie, inoltre, non implica un'analoga tendenza per altre gabelle che colpiscono taluni settori commerciali e produttivi. Un elemento comunque sembra emergere in modo abbastanza netto: la quota fiscale del Dominio da terra tende a crescere verso gli inizi del Seicento a fronte di un leggero regresso del contributo veneziano, che nondimeno rimane su livelli elevati.
Se Venezia ricopre un ruolo assai importante nel settore delle entrate pubbliche è opportuno analizzare altresì il versante della spesa per meglio comprendere il circuito finanziario che vede la capitale al centro del sistema. Il principale stimolo che spingeva il governo ad aumentare le entrate era il costante crescere delle spese, soprattutto per sostenere gli impegni militari. L'andamento delle uscite della Repubblica, così, segue abbastanza da vicino quello delle rendite fiscali. A metà Cinquecento il bilancio registra una spesa di circa 1.700.000 ducati; a fine secolo si arrivava attorno ai due milioni; nel primo trentennio del Seicento le uscite ordinarie ammontavano a quasi due milioni e mezzo di ducati, accanto ad uscite straordinarie per oltre un milione (13). La maggior parte del denaro era destinata alla difesa navale e alle truppe stanziate entro i confini della Terraferma e nelle guarnigioni d'oltremare. In tempo di pace, come negli anni centrali del XVI secolo, la Serenissima Signoria spendeva tra il 30 e il 40% del proprio bilancio; nell'ultimo ventennio del secolo la percentuale si portò sul 40-45%. Alle soglie del Seicento le tensioni con gli Stati vicini e la lotta contro i pirati nell'Adriatico condussero il governo a profondere sempre più denaro in vascelli e soldati: nel primo decennio i costi militari si aggirarono attorno al 60% delle uscite complessive; nel 1618 - in un particolare momento di attrito con gli Spagnoli la spesa per la difesa raggiunse i 2.700.000 ducati, vale a dire circa i tre quarti delle uscite globali dello Stato. Ed un'analoga quota si registrò anche negli anni Venti, caratterizzati dalla crisi della Valtellina e chiusi dalla sfortunata partecipazione veneziana alla guerra di Mantova nel 1630 contro gli Imperiali (14).
Nel quadro di queste spese per la macchina militare, il denaro redistribuito tramite le casse statali arrivava in gran parte nelle aree interessate dalla presenza di soldati. Tuttavia sarebbe un errore ritenere che Venezia non godesse, almeno in una certa misura, di un tale flusso di denaro. Anzitutto occorre considerare che dietro la poderosa flotta di San Marco vi era tutta un'attività lavorativa che si accentrava nell'Arsenale. Durante la guerra contro il Turco del 1537-40 il cantiere statale assorbì circa 660.000 ducati, destinati per lo più alle paghe degli operai e all'acquisto di materiale per le costruzioni navali (15). Nel 1574, all'indomani della guerra di Cipro, il bilancio assegnava all'Arsenale quasi 240.000 ducati; e dopo una diminuzione delle spese negli anni successivi, nel primo Seicento l'ammontare per l'Arsenale si stabilizzò attorno ai 200.000 ducati (16). Si trattava di denaro che in parte prendeva la via dell'entroterra, per procurarsi legname dai boschi dello Stato, canapa da Montagnana e da Bologna (17), ma che rimaneva altresì a Venezia, sotto forma di salari e di contratti d'appalto per le forniture. È presumibile che anche una quota cospicua delle paghe assegnate agli equipaggi e agli ufficiali della marina si disperdesse nella città lagunare. Era uno spettacolo abituale per i Veneziani vedere i marinai gettarsi verso i piaceri che offriva la città e sperperare il denaro appena ricevuto. E scene analoghe avevano per protagonisti i soldati in procinto d'imbarcarsi per le guarnigioni del Levante.
Se gran parte delle spese militari si disperdeva nei Domini i costi sostenuti dallo Stato per il proprio apparato amministrativo tendevano a concentrarsi nella capitale. Le cifre che saranno proposte ovviamente vanno valutate con beneficio d'inventario.
È noto, infatti, che le retribuzioni degli officiali erano costituite solo in parte - e spesso la meno rilevante - dallo stipendio erogato dallo Stato: alle entrate dell'officiale concorrevano quelle "utilità" che - più o meno legalmente - venivano richieste agli utenti. Non sorprende dunque che i costi amministrativi che compaiono nei bilanci statali siano così contenuti; l'adeguamento dei salari al costo della vita - in notevole crescita proprio nel periodo qui considerato - s'effettuava di fatto tramite le "onoranze" dovute all'officiale piuttosto che con l'aumento del salario. C'è da osservare, inoltre, che una parte significativa dei costi amministrativi veniva demandata alle istituzioni periferiche: città e comuni rurali mantenevano il proprio apparato burocratico in completa autonomia rispetto alla finanza centrale. Nel 1582 l'esborso dello Stato per pagare i vari officiali e magistrati della Repubblica ammontava a circa 131.000 ducati, vale a dire a quasi il 6% della spesa totale di quell'anno (18). Una percentuale, questa, che in effetti si allinea ad analoghi casi per altri Stati. Di questi 131.000 ducati quasi 60.000 erano sborsati ad uffici e istituzioni della capitale. Del resto molte cariche erano considerate apertamente come un mezzo per sostenere i patrizi meno agiati, le cui file si stavano ingrossando proprio in questi anni, in seguito, fra l'altro, al restringersi delle possibilità di sicuri profitti nel commercio. I posti nell'apparato pubblico - da quelli di rettore nei piccoli centri dei Domini agli uffici minori nella capitale - costituivano una prerogativa del patriziato indigente, che così si sosteneva grazie agli stretti legami tra ceto dirigente veneziano e gestione della spesa pubblica.
La domanda fiscale
La gran parte delle entrate statali, e della stessa Venezia, era costituita dai dazi che gravavano sulla produzione e sul commercio dei beni. Le imposte indirette contribuivano per circa i quattro quinti delle rendite ordinarie complessive. La tassazione indiretta rispecchiava fra l'altro la vocazione commerciale della città: dazi sul vino, sui grani, sulle merci in transito, sugli affari, sulla produzione tessile, e via dicendo, formavano una congerie di diritti e di esazioni il cui gettito rappresentava la spina dorsale della finanza pubblica veneziana. Secondo un documento del 1555 i dazi imposti a Venezia raggiungevano il 70% del denaro riscosso nell'ambito lagunare (19); e pressappoco (74%) un'analoga proporzione si riscontra nel bilancio del 1621 relativo alle entrate ordinarie della capitale (20). Trovava certo un concreto fondamento l'asserzione che i dazi fossero "il nervo principale del Stato nostro", come ebbe ad affermare il senato nel giugno del 1551.
Se l'imposizione indiretta era il pilastro delle rendite statali una pari importanza era attribuita - più in un'ottica politica che strettamente finanziaria - alle imposte dirette, le cosiddette angarie o gravezze. Anzi, a ben vedere gli animi dei senatori s'infiammavano assai più facilmente allorché si discutesse sulle angarie che sui dazi. Il patriziato veneziano, così come gli altri ceti dirigenti della penisola, era particolarmente refrattario al prelievo diretto. Un atteggiamento, questo, che affondava le radici nella storia e nella cultura della città-stato medievale. Tuttavia i tempi erano drammaticamente mutati; da tempo era emersa l'inevitabile esigenza di ricorrere con regolarità ai tributi diretti. Le emergenze belliche della Serenissima, dalle spossanti guerre col Turco ai conflitti italiani, avevano impresso un'accelerazione alle richieste fiscali dello Stato; un'accelerazione che aveva provocato un nuovo assetto della domanda tributaria, caratterizzata oramai nel pieno Cinquecento dal regolare prelievo diretto anche per i contribuenti veneziani.
Le due principali tasse che colpivano i Veneziani erano la decima e la tansa. La prima, come evidenzia il nome stesso, prelevava un decimo dell'ammontare dei redditi da beni immobili dichiarati; la seconda invece colpiva gli altri tipi di reddito accertato da una commissione di estimatori. La decima, inoltre, si basava sulla dichiarazione volontaria dei contribuenti, mentre la tansa costituiva sostanzialmente una somma forfettaria decisa dai "tansadori" in base ad un'indagine fiscale. Solitamente queste imposte venivano riscosse ad anni alterni; tuttavia nei particolari momenti d'emergenza finanziaria la prassi veniva superata in nome della necessità. Occorre altresì osservare che nel settore dei tributi diretti permangono taluni retaggi della fiscalità medievale. Accanto alla tansa e alla decima cosiddette perse vi era anche la possibilità - attuata in talune circostanze - che questi tributi prendessero la forma dei classici prestiti forzosi: vale a dire che i contribuenti veneziani pagassero la decima e la tansa ottenendo un interesse annuo che lo Stato s'impegnava a corrispondere sino alla restituzione del capitale. Questo sistema, usuale sino all'alba del Cinquecento, coesisteva con il nuovo principio dell'imposta a perdere, che stava vieppiù prendendo piede nella concezione della fiscalità statale. Tra il 1536 e il 1593 furono decretate dal senato almeno 36 tanse e decime "a restituir" contro 95 a perdere; dal '94 al 1630 su almeno 36 decime solamente otto vennero considerate alla stregua di un prestito. È opportuno comunque delineare l'andamento della richiesta fiscale mediante le tanse e le decime nell'arco di anni tra il 1536 e il 1630, avvertendo che i dati riguardo la tansa s'interrompono al 1610.
I dati della tabella 2 ci offrono una base per delineare l'andamento della pressione fiscale sui contribuenti veneziani.
Il periodo si apre con la guerra turca che impegnò la Serenissima tra la primavera del 1537 e l'autunno 1540.
Il conflitto vide un'offensiva della Sublime Porta condotta su vari fronti, dalle isole mediterranee in mano a Venezia sino ad arrivare in Dalmazia. Lo sforzo finanziario veneziano fu senz'altro notevole, poiché i costi della guerra raggiunsero l'ammontare di almeno un milione e mezzo di ducati all'anno, a fronte di un'entrata che probabilmente si aggirava attorno ad una cifra, seppur di poco, inferiore (22). Tanto più che le difficoltà nei commerci marittimi, in seguito all'incrociare delle flotte militari e all'incremento dei costi assicurativi, facevano calare le entrate daziarie. Le 19 tanse e decime (di cui 15 "a restituire") certo non bastavano a far fronte alle necessità; la riscossione del denaro, inoltre, era lenta e contrastava con l'assillante urgenza del pagamento delle truppe. Si fece ricorso allora alle imposte indirette: il 15 settembre 1537 il dazio della macina di Venezia e del Dogado fu portato da quattro a dieci soldi per staro, con un aumento della tariffa quindi del 150%. Il decreto del senato specificava che tale maggiorazione sarebbe durata per dieci anni. Il 3 novembre il dazio - previsto per i tre anni successivi - veniva esteso anche alla Terraferma, incluse quelle zone che sino allora non erano state sottoposte a questo tipo di tassa (23). I patrizi si potevano aspettare che l'aumento del dazio su un genere di consumo così popolare come la farina sarebbe stato probabilmente accolto con un moto di collera. L'atmosfera di emergenza, comunque, giustificava, agli occhi del ceto dirigente, il ricorso a questa tassa impopolare. Occorre altresì notare che dapprima l'aumento tariffario venne decretato per Venezia, e solo in un secondo tempo per il Dominio da terra. Forse vi erano più remore a colpire la Terraferma, che presentava aree dove addirittura questo genere di tributo non veniva riscosso; tuttavia il fatto che fosse stata la capitale stessa ad aver subìto l'aumento del dazio rafforzava le ragioni del senato di fronte alle proteste dei sudditi ad estenderlo, seppur con un'aliquota minore, al resto dello Stato. Un analogo aumento tariffario venne deciso nel 1539 per il dazio che concerneva la produzione dei pannilana (24). Questo aumento non sembra aver colpito in maniera sensibile, almeno a Venezia, la capacità produttiva: rispetto all'anno precedente, infatti, nel 1540 la produzione dei panni alti registrò un incremento del 28% (25), nonostante il trattato di pace venisse firmato solamente ad ottobre. Nuovi dazi furono decretati anche sul commercio delle berrette e dei cappelli a Venezia, oltre che sulla produzione dei bozzoli (le gallette) dei bachi da seta in tutto lo Stato (26). Nel consesso dei senatori le opinioni circa queste nuove gabelle non erano affatto unanimi: il primo dazio fu approvato con 135 voti favorevoli e 30 contrari, mentre la parte (legge) circa la seconda imposta vide un patrizio avverso contro quattro favorevoli.
Occorreva nondimeno ricorrere ad altre misure per fronteggiare una guerra lunga e dispendiosa: il denaro che si poteva raccogliere con la fiscalità ordinaria non bastava; premeva avere denaro "prestissimo et pronto". I limiti erano dati soprattutto dalla limitata capacità coercitiva dello Stato sui contribuenti e dai timori di superare il livello di sopportazione dei sudditi pressati dalla fiscalità di guerra. Occorreva dunque incentivare il flusso del denaro dai privati allo Stato. La via classica era rappresentata dal debito pubblico, e in particolare dai depositi in Zecca, che sostanzialmente costituivano dei titoli di stato. Tutta la questione, ad ogni modo, sarà affrontata in un'altra parte di questo contributo. Ancora legato al debito pubblico era il sistema della concessione ad un patrizio della carica di procuratore di S. Marco in cambio di un consistente prestito. Si era già fatto ricorso a quest'espediente in occasione delle guerre d'Italia all'inizio del secolo; e allora le perplessità e i mugugni non avevano risparmiato il corpo aristocratico. Ora il senato, sollecitato dai dieci, riprendeva in esame la questione. Il 4 giugno 1537 decretava che si eleggessero tre procuratori di S. Marco "cum oblation de danari" in prestito per una somma minima di 12.000 ducati. Due giorni dopo il maggior consiglio sanciva la decisione a stragrande maggioranza. Nel giro del mese vennero messi a disposizione altri quattro posti della dignità procuratoria, sempre in seguito ad un prestito fra i 12 e 14.000 ducati (27); e l'anno successivo ne furono concessi altri due per una cifra di 10.000 ducati. Si trattava certo di somme ingenti, che potevano essere sborsate soltanto da quei patrizi che appartenevano alle fasce agiate della nobiltà lagunare. Se consideriamo che nella Venezia cinquecentesca un reddito annuo di 10.000 ducati permetteva di reputarsi effettivamente ricco (28), è facile immaginare il significato che il prestito assumeva per la maggior parte delle famiglie patrizie. Del resto l'importanza della carica esigeva un tale sforzo: i procuratori di S. Marco, oltre a svolgere il ruolo di amministratori di varie eredità, erano secondi per dignità solamente al doge, e inoltre potevano accedere al consiglio dei dieci e alla sua zonta. E non a caso conseguirono il titolo i componenti delle famiglie più cospicue del patriziato; i 119.000 ducati furono sborsati dai Corner, Contarini, Grimani (29). Nomi altisonanti, ai quali la carica di procuratore conferiva ancor più prestigio e potere. Zuanne da Lezze, ad esempio, che approfittò del provvedimento, era figlio del procuratore Priamo, all'epoca uno dei tre capi del consiglio dei dieci, e personaggio assai influente nell'ambiente patrizio.
Erano ancora i dieci che nel febbraio del 1538, al culmine del conflitto, decidevano di concedere la possibilità ai giovani nobili di entrare nel maggior consiglio, pur non avendo l'età prescritta, dietro un versamento di cento ducati a titolo di prestito. La legge fu approvata a grande maggioranza. E si prevedeva inoltre, per i venticinquenni che avessero sborsato 500 ducati, l'occasione di accedere al senato, dopo che ogni candidato fosse stato vagliato dai dieci stessi. A fine maggio 159 giovani appartenenti alla nobiltà avevano guadagnato il diritto di sedere fra i banchi del senato (30). Ciò significa, al di là dei risvolti sugli equilibri politici che ebbe il provvedimento, che i giovani - o più probabilmente le loro famiglie - avevano versato nelle casse dello Stato 79.500 ducati. Una somma, questa, che corrispondeva sostanzialmente al gettito annuale del sussidio ordinario, una delle principali imposte pagate dalla Terraferma.
Oltre alla dignità procuratoria e al diritto di sedere nel maggior consiglio e in senato si decideva altresì di vendere numerose cariche della struttura amministrativa dello Stato. Anche questa delibera non era una novità; già in precedenza, pressato dall'emergenza bellica, il governo aveva fatto ricorso alla vendita degli uffici. Il 19 febbraio 1539 nel consiglio dei dieci veniva proposto che i savi del collegio presentassero al senato e poi nel maggior consiglio il progetto d'alienare le cariche dietro versamento di denaro. La parte tuttavia non passò, trovando ben 16 voti contrari contro 11 favorevoli. Tre giorni dopo, comunque, la legge veniva ripresentata e quindi approvata da 21 consiglieri su 28 votanti (31).
Un ulteriore sistema per rimpinguare le casse statali fu trovato nell'alienazione del diritto di riscuotere la dadia delle lance, ossia la più antica imposta diretta gravante sulla Terraferma. In effetti si era già fatto ricorso a questo espediente, comune ad altri Stati della penisola, durante il periodo successivo alla crisi di Cambrai. Nell'ottobre del 1538 il senato offriva la possibilità ai contribuenti veneziani che pagavano la dadia per i propri beni in Terraferma di versare cento ducati ogni sette d'imposta, liberandosi così in perpetuo da tale onere. Si prevedeva altresì l'opportunità di acquistare il diritto di riscossione sugli altri contribuenti. Tra ottobre 1538 e febbraio dell'anno successivo la quota di dadia alienata ammontò a 13.000 ducati. Ciò significa che nel giro di pochi mesi i Veneziani avevano versato all'erario 185.714 ducati sonanti; una cifra, questa, che superava di oltre quattro volte il gettito netto di una decima (32). Talvolta si specificava che l'operazione di affrancamento riguardava particolari province, come il Padovano, il Vicentino e il Veronese, che avevano conosciuto o stavano per sopportare la massiccia penetrazione fondiaria dei Veneziani. Se il sistema della vendita della dadia era particolarmente gradito ai contribuenti che ne avevano sopportato l'onere, non è nemmeno da sottovalutare la possibilità offerta di riscuotere l'imposta sui beni altrui. L'acquirente della dadia, ora divenuto esattore, godeva di un notevole strumento per controllare chi doveva versargli l'imposta, fosse un semplice contadino, una comunità o un ente ecclesiastico.
Per quanto riguarda il debito pubblico, questi anni videro il deciso passaggio dal sistema basato sui prestiti forzosi a quello incentrato sui versamenti volontari. Già nel 1528 era stato aperto un deposito in Zecca che assicurava un pro (interesse) del 16% a coloro che avessero versato oro, argento o contanti (33). Fu comunque durante la successiva crisi turca che i depositi in Zecca conobbero un notevole sviluppo. Tra marzo e aprile del 1537 il consiglio dei dieci autorizzò i provveditori in Zecca ad accettare denaro a prestito - per un ammontare di 124.000 ducati - a un tasso del 6% (34). Nei mesi seguenti, parallelamente al crescere dei bisogni della guerra i provvedimenti per la raccolta dei prestiti si resero più insistenti; il tasso d'interesse, inoltre, fu aumentato al 7,5% e, a partire dall'inverno del 1538, all'8%, al fine di invogliare i sottoscrittori a depositare il loro denaro presso la Zecca. Nel 1538 il senato prima, e i dieci poi, decretarono l'emissione di una serie di titoli vitalizi al 14% (35). Il denaro raccolto tramite i depositi in Zecca raggiunse una cifra notevole: nel 1537 affluirono nei forzieri dei provveditori in Zecca 424.000 ducati; l'anno successivo fu raggiunto il primato di 655.000 ducati; nel 1539 si toccò la soglia di almeno 525.000 ducati; nell'ultimo anno di guerra la somma scese a 207.110 ducati. Negli anni del conflitto, dunque, la Signoria raccolse per lo meno 1.811.110 ducati: vale a dire una media di oltre 450.000 ducati all'anno.
L'atteggiamento dei Veneziani e di coloro che erano in grado di prestare denaro al governo rifletteva le oscillazioni della congiuntura politica e militare e del mercato. Se nell'inverno fra il 1538 e il '39 l'emissione di una serie per 100.000 ducati all'8% per vent'anni aveva trovato una facile e veloce accoglienza, pochi giorni prima un prestito vitalizio al 14% aveva incontrato delle difficoltà. Infatti si erano diffuse delle voci in città che il provvedimento, preso il 26 settembre, sarebbe stato modificato, probabilmente a svantaggio dei sottoscrittori. Il 4 novembre i dieci si erano affrettati ad assicurare che la parte non sarebbe stata modificata in alcun suo elemento. È lecito chiedersi se, nel momento in cui il governo decideva l'emissione di un prestito, tenesse conto anche dell'andamento del mercato monetario e dei flussi di moneta legati al ciclo commerciale. Con l'inizio della primavera e sino al termine dell'estate la piazza veneziana registrava una vera e propria fame di specie monetarie pregiate da caricare sulle galee dirette in Levante. Negli anni di guerra, tuttavia, gli scambi con i porti levantini, pur non cessando completamente, subivano delle drastiche riduzioni; e quindi probabilmente vi era maggior disponibilità di denaro contante in città. Del resto occorre considerare altresì che le operazioni navali, limitate nel periodo invernale, riprendevano con l'arrivo del bel tempo: pertanto aumentavano le necessità di equipaggiare e armare le galee da guerra (36).
Inasprimento delle imposte, alienazioni della dadia, concessioni di prestigiose cariche e di anonimi uffici, emissioni di annualità del debito pubblico: erano strumenti e stratagemmi che mettevano a dura prova la tenuta della finanza statale e, di conseguenza, la gran parte dei contribuenti. Negli anni del conflitto furono imposte dieci decime - per non dire delle nove tanse -: in teoria i Veneziani avrebbero dovuto versare l'intero reddito stimato di un anno. Tuttavia il quadro risulta meno drammatico di quanto possa sembrare a prima vista. Anzitutto occorre rilevare che il fenomeno dell'evasione fiscale, sia all'atto della denuncia dell'imponibile che al momento dell'esborso, era assai diffuso. Che il senato decretasse nell'arco di pochi anni un numero consistente di decime e tanse sta a dimostrare, peraltro, che gli stessi governanti conoscevano i margini d'evasione che il sistema fiscale permetteva. Per far fronte alle angarie, inoltre, il contribuente veneziano poteva scegliere di pagare mediante i propri crediti che vantava sul debito pubblico consolidato. Si trattava, insomma, di depennare un credito presso la camera d'imprestiti - l'organo che gestiva la corresponsione degli interessi dei Monti - e di convertirlo come pagamento d'imposta presso i governatori delle entrate. L'entità dei versamenti d'imposta in denaro contante, dunque, dovrebbe essere ridimensionata tenendo conto sia dell'accumulo dei crediti statali inesatti che del meccanismo di pagamento delle angarie.
La conclusione del conflitto condusse ad un allentamento della tensione fiscale, che comunque caratterizzò ancora in una certa misura i primi anni Quaranta. L'ammontare del debito pubblico aveva infatti raggiunto dei considerevoli livelli; numerose entrate daziarie erano state obbligate al pagamento degli interessi concernenti i titoli dei Monti e le serie aperte in Zecca. Nel 1544 i dieci autorizzarono prestiti pubblici per 204.000 ducati; l'anno successivo l'emissione di titoli raggiunse un valore di 246.000 ducati; nel '46 furono richiesti altri 202.000 ducati e il tasso d'interesse si stabilizzò sul 5% (37). Furono imposte in media due decime e una tansa all'anno fra il 1541 e il '45; e nel 1544 il senato decretò un aumento di tre soldi per lira (15%) su quasi tutti i dazi riscossi nello Stato (38). È interessante notare che, se per quanto riguarda le imposte dirette decretate a Venezia gli anni immediatamente successivi alla guerra registrarono una certa pressione, nella Terraferma qualche indizio lascia supporre che l'atmosfera fiscale fosse meno tesa. Le spese sostenute dalla comunità di Pescantina, situata all'imbocco della Valpolicella, diminuirono quasi repentinamente, portandosi da una media di 1.664 lire veronesi nel triennio 1536-38, a 1.353 negli anni 1539-41, e infine a 981 lire nel periodo 1542-44 (39). Con gli anni Cinquanta, comunque, i contribuenti veneziani iniziarono a ritrovare quella tranquillità che sembrava oramai perduta. Le spese militari furono ridotte e il passivo del debito pubblico venne ricondotto ad un livello sopportabile, grazie alle operazioni di restituzione dei capitali e alla riconversione dei depositi in Zecca ad un interesse minore. Varie entrate daziarie, così, poterono essere utilizzate per le spese correnti, essendo state affrancate dal servizio del debito pubblico (40).
Gli anni Sessanta videro i Veneziani rispondere ad una richiesta fiscale dello Stato assai sopportabile: una tansa ed una decima venivano imposte ad anni alterni; mentre, sul versante dell'imposizione indiretta, nel 1560 si decretava un'ulteriore addizionale del 15% sui dazi, e poco tempo dopo si riorganizzava la riscossione di una serie di dazi sul commercio (41). Gli impegni finanziari, ad ogni modo, non costringevano ad attuare clamorosi inasprimenti tributari sui sudditi. Il bilancio dello Stato, sebbene non fosse proprio in condizioni floride, consentiva di ricorrere in misura limitata al debito pubblico. Anzi, la Signoria si permetteva di concedere al re di Francia un prestito di 100.000 ducati sia nel 1562 che nel '68. In verità fra i senatori erano sorte voci di dissenso, soprattutto da parte di chi aveva a cuore i conti dello Stato, e vedeva con preoccupazione un credito ad un sovrano che versava in notevoli difficoltà finanziarie. Ma forse non si trattava solamente di un mero calcolo economico: il prestito al Cristianissimo avrebbe rappresentato un chiaro segno di appoggio alla corona francese, in contrapposizione alla Spagna, che proprio in quegli anni aveva ormai consolidato il suo dominio su gran parte della penisola italiana. Gli Spagnoli si trovavano a ridosso dei confini occidentali della Repubblica, nello Stato di Milano, e gli Imperiali, alleati del Cattolico, minacciavano il Friuli. Erano timori legittimi. Tuttavia si decise di concedere il prestito; e nel febbraio del 1569 si stilò il contratto che concedeva al Cristianissimo una somma di centomila scudi d'oro, da restituire in sei anni assieme agli altri centomila versati nel 1562 (42).
In effetti il denaro avrebbe anche potuto servire per sostenere le sorti della corona, in una Francia dilaniata dalle guerre civili, dove gli Ugonotti minacciavano seriamente le basi della religione cattolica. Quest'aiuto, poi, non sarebbe nemmeno spiaciuto alla Santa Sede, verso cui una parte della nobiltà veneziana guardava come un imprescindibile punto di riferimento ideale e politico (43).
La discreta congiuntura della finanza pubblica veneziana venne bruscamente interrotta dalla guerra contro il Turco, che impegnò la Serenissima fra il 1570 e il '73 nel tentativo di difendere Cipro e i possedimenti nel Mediterraneo orientale. Fu una guerra assai dispendiosa, che richiese un ingente sforzo in uomini e mezzi. Fu allestita una poderosa flotta, si reclutarono migliaia di soldati e di rematori, ingenti quantità di denaro vennero profuse per allestire i mezzi e le armi, per pagare, vestire e nutrire gli uomini. Durante la guerra Venezia riuscì a schierare oltre un centinaio di vascelli e fra i 33 e 35.000 soldati, nonché circa 10.000 rematori. Lo sforzo per mantenere un tale apparato fu enorme; la macchina bellica ingoiava almeno tre milioni di ducati all'anno, di cui più di un milione e mezzo era destinato alla flotta delle galee sottili (44): e se consideriamo che le entrate ordinarie dello Stato si aggiravano attorno ai due milioni di ducati si può ben immaginare l'atmosfera di emergenza che pervase la città lagunare.
"Le eccessive spese nelle quali si convien continuar per tutto il tempo della presente importantissima guerra" affermava il senato, apprestandosi ad istituire un'imposta straordinaria, "ricercano che si faccia quella più certa et presta provisione di danari che sia possibile". Dapprima si ricorse agli strumenti fiscali già sperimentati. Nell'aprile del 1570, all'inizio della guerra, il dazio della macina per Venezia e il Dogado venne portato da 10 a 16 soldi per staro, mentre nella Terraferma fu esteso anche alle località che sin allora non lo pagavano. Esattamente un anno dopo il dazio sul vino in entrata e uscita da Venezia fu accresciuto di mezzo ducato per anfora (45). Questi inasprimenti tributari si collocavano in un quadro assai difficile, sia per la carestia che aveva colpito i territori della Repubblica, come pure per i commerci che, a causa della guerra, versavano in notevoli difficoltà. Inoltre erano due prodotti - la farina e il vino - che costituivano due elementi fondamentali nella vita e nel commercio quotidiani della città. Probabilmente i dirigenti veneziani vollero colpirli poiché, malgrado le difficoltà, si trattava di beni di largo uso, che non avrebbero scoraggiato le speranze degli appaltatori delle imposte.
Per ciò che riguarda le imposte dirette, i contribuenti si videro richiesti di numerose decime e tanse, perse o "a restituir": due decime e due tanse nel 1570; una decima e tre tanse l'anno seguente; tre decime e mezzo e tre tanse nel '72; e infine una decima e due tanse nell'ultimo anno del conflitto. Nei quattro anni della crisi di Cipro, dunque, i Veneziani dovettero versare sette decime e mezzo e dieci tanse. La pressione fiscale sembrerebbe perciò rilevante; tuttavia la domanda dello Stato non pareva certo più gravosa rispetto alla guerra precedente o addirittura a tempi più remoti, allorché tra il 1509 e il '14 erano state decretate in media otto decime e tre tanse e mezzo all'anno. In effetti si erano cercate altre vie per mantenere la richiesta tributaria relativamente sopportabile. Alla Terraferma, per esempio, in sostituzione - di un campatico temuto sia dai proprietari sudditi che dai Veneziani - venne imposto un sussidio straordinario di 300.000 ducati all'anno durante bello. Fu istituita inoltre una decima sui salari degli officiali che, nonostante le dichiarazioni che assicuravano la straordinarietà della tassa, assunse i caratteri di un'imposta ordinaria. Il prelievo diretto, insomma, aumentò probabilmente del triplo, tra angarie, decime sui salari e sussidi straordinari; ma il loro gettito non era ancora sufficiente per fronteggiare l'emergenza.
Si ricorse allora ad altri espedienti, già attuati nel conflitto precedente. Nel gennaio del 1571 si decise di concedere la dignità di procuratore di S. Marco dietro versamento di denaro a titolo di prestito. Tredici nobili approfitteranno dell'occasione, con un esborso globale di poco inferiore ai 260.000 ducati. Nel medesimo mese il consiglio dei dieci offriva ancora una volta l'accesso in maggior consiglio ai giovani nobili che avessero prestato duecento ducati o che ne avessero donati cento. La risposta non si fece attendere: nel giro di un mese furono raccolti circa 40.000 ducati. E il nunzio apostolico a Venezia prevedeva che se ne potesse tirar su il doppio. Nello stesso tempo s'alienava ancora una volta la dadia delle lance, dapprima ad un tasso del 7% e successivamente, dal febbraio del 1573, all'8%. La possibilità di affrancarsi da quest'imposta venne estesa anche ai proprietari del Dominio. Nel gennaio del '73 il senato decretava inoltre la vendita di tutti gli offici di "nodarie, cogitarie, scrivanie, massarie, fantarie, contestabellarie" e altre cariche concesse dai vari consigli veneziani e dai rettori nel Dominio. Il provvedimento era riservato ai sudditi e a coloro che vivevano nello Stato da almeno dieci anni (46).
Si trattava di provvedimenti - quelli circa la nomina a procuratori e a senatori, l'affrancazione dalla dadia delle lance, la vendita delle cariche - che sottolineavano una certa difficoltà a reperire denaro sonante attraverso i tradizionali canali fiscali. Occorreva concedere qualcosa, insomma, per allettare ed attirare i sudditi nel versare il proprio denaro allo Stato. Questa politica, almeno inizialmente, tendeva senz'altro a favorire il patriziato che disponeva di ampie possibilità economiche. Non era certo semplice trovare in poco tempo dai 16 ai 25.000 ducati per ottenere il titolo di procuratore di S. Marco; e, analogamente, l'acquisto della dadia ad un tasso del 7 e 8% rappresentava in genere un impegno oneroso per molti contribuenti. Anzi, talvolta i nobili più ricchi acquisirono il diritto di riscossione sui sudditi e su quegli enti che non erano stati in grado di cogliere la possibilità di liberarsi, almeno inizialmente, dall'imposta. Il nobile Giacomo Foscarini riscuoteva ogni anno 450 ducati da Padova e 50 dal clero di quella città a titolo di dadia. Ciò significa che il patrizio veneziano aveva sborsato fra i 6.250 e i 7.142 ducati per acquisire il diritto di riscossione (47). Ed era un esborso, questo, che veniva ammortizzato nel breve giro di pochi anni. Chi disponeva di molto denaro sonante, insomma, poteva trarre notevoli vantaggi dai provvedimenti finanziari messi in atto dal gruppo dirigente marciano. Non solo si trattava di attutire la domanda fiscale dello Stato trovando una buona collocazione del proprio denaro, ma si aprivano le strade dell'ascesa politica all'interno delle istituzioni. È una politica che tende a privilegiare un gruppo ristretto del patriziato, che emerge sia per dovizia che per prestigio politico; un gruppo che si potrebbe individuare in quella ristretta cerchia che s'identifica, sul piano istituzionale, nel consiglio dei dieci e nella sua zonta. Tuttavia sarebbe un errore proporre una stretta identificazione tra la politica finanziaria del ceto dirigente veneziano e il gruppo che orbitava attorno ai dieci. Taluni patrizi, pur legati a questa magistratura, ritenevano che si fosse raggiunto il limite; che cioè la finanza pubblica non dovesse più sostenere le finanze private delle casate più eminenti.
Lo stretto rapporto era determinato dal debito pubblico, e in particolare dai depositi volontari in Zecca, che proprio durante gli anni del conflitto avevano sostenuto le sorti della finanza di guerra. Circa cinque milioni e mezzo di ducati erano stati rastrellati sul mercato nel giro di pochi anni: una somma che corrispondeva al doppio delle entrate annue dello Stato; una somma che probabilmente aveva coperto la metà dei costi bellici sostenuti da Venezia. Tanto denaro era stato raccolto con una relativa facilità, grazie alla risposta del mercato. Ora, giunta la pace, si trattava di continuare a sopportare i costi di questo prodigioso sforzo finanziario.
Interessi pubblici e benefici privati
Al termine di "quella voracissima guerra" lo Stato si era trovato a sostenere un debito pubblico rilevante: gli interessi annui sui Monti assommavano a 179.800 ducati, mentre le serie dei depositi in Zecca comportavano un esborso di ben 522.647 ducati. Era una somma enorme: oltre 700.000 ducati assorbivano circa un terzo delle entrate; e occorreva poi pagare i soldati, i marinai, gli officiali, innalzare fortezze, acquistare grano... La finanza pubblica non poteva sopportare oltre una tale tensione, tanto più che i denari assegnati al pagamento dei pro andavano a finire nelle tasche dei "particolari", dei cittadini e dei "nobili principali della nostra Repubblica", come avrà modo di rimarcare il nobile Zuan Francesco Priuli, "tra quali vi sono molte case che scuodono quattro et sei et fino a dieci et più mille ducati all'anno di pro della sua Cecca senza pagar alcuna sorte di gravezze" (48). Il mantenimento di un così elevato debito non appariva certo giustificato, oramai, dall'emergenza politica. Occorreva ridurre il carico, anche al fine di alleggerire la pressione fiscale sui sudditi. Nell'inverno fra il 1574 e '75 Zuan Francesco Priuli, un "senator vecchio", come ebbe a definirlo Nicolò Contarini nelle sue Historie venetiane, "molto versato nella pratica delle rendite publiche et de computi fiscali", presentò un progetto per ammortizzare il debito basato sui depositi in Zecca (49). Egli godeva di un certo prestigio fra i patrizi; un prestigio e una considerazione che lo avevano portato nell'ottobre del 1574 alla nomina di provveditore sopra i beni comunali, una nuova magistratura che aveva la responsabilità sui beni appartenenti alla Signoria e concessi in uso alle comunità (50). L'analisi di Priuli sulla finanza pubblica delineava un quadro fosco: le entrate ordinarie erano quasi tutte obbligate ai vari pagamenti; le scritture contabili si trovavano in disordine, e specie quelle relative alla Zecca, alle sue entrate e alle sue uscite. La difesa dello Stato da mar - tenuto in continua tensione dalla minaccia turca - necessitava di un milione di ducati all'anno; per far fronte al fabbisogno si doveva ricorrere all'imposizione diretta, alle decime sul clero, al sussidio della Terraferma, alle decime e tanse perse di Venezia. Tuttavia il gettito di queste tasse, stimato in 340.000 ducati, non era sufficiente; né l'inasprimento delle tariffe daziarie sembrava il rimedio più opportuno, poiché s'incentivavano i "negozi" dei porti concorrenti di Ancona e Marsiglia; e neppure l'istituzione di nuovi dazi in Terraferma era la via migliore, in quanto a "travagliarla ogni giorno a questo modo" si correvano seri rischi per l'ordine pubblico. Bisognava allora trovare una "provvisione grande", "sola" e "generale", "giusta et ragionevole", che colpisse "quelli che hanno" e risparmiasse "quelli che non hanno", e che, soprattutto, dovesse "abbracciar tutto il suo stato". Certo, ricorda il nobile veneziano, vari tentativi si erano susseguiti nel passato per attuare questa "provvisione": nella guerra del 1537-40 era stata decretata una decima in Terraferma in base agli estimi, ma la ferma opposizione delle città aveva fatto naufragare il progetto; e un analogo tentativo per una decima in campagna non aveva sortito miglior risultato. Durante il recente conflitto, poi, era sorta l'idea d'imporre un campatico; ma le resistenze dei consigli cittadini avevano ancora una volta impedito la realizzazione del nuovo aggravio. Le comunità soggette avevano preferito pagare un sussidio straordinario di 300.000 ducati piuttosto che sottostare all'imposta fondiaria. I vari tentativi di trovar "gran summa de danaro ", insomma, erano naufragati, secondo Priuli, "per li molti rispetti che si sono havuti alli sudditi". Troppo cauta e timorosa era stata la politica fiscale della Serenissima Signoria nei confronti della Terraferma; era tempo di pensare a "conservar la libertà, et non haver quel solo pensiero di gratificare sudditi" per tenerli "bene edificati", accontentandosi solamente di accettare "quel tanto che si sono offerti di dare".
A tal scopo il nobile Priuli proponeva l'imposizione di una tassa su ogni abitante di Venezia e del Dominio. Ogni suddito della Terraferma avrebbe versato mezzo ducato, mentre ogni veneziano ne avrebbe pagato uno. Il gettito era previsto in un milione di ducati d'oro all'anno; e la durata della gravezza si sarebbe limitata a tre anni. Una descrizione generale delle "teste" in tutte le città, "castelle, comuni et ville, a loco per loco separatamente et distintamente" avrebbe permesso d'istituire il testatico. Coloro ritenuti poveri non sarebbero stati sottoposti alla tassazione, e la quota loro attribuita sarebbe stata ripartita in base alle entrate della comunità e del resto dei contribuenti. La responsabilità della descrizione come pure i criteri dell'esazione venivano assunti dalle singole comunità. Esse dovevano inoltre rispondere in solido agli eventuali debiti d'imposta contratti dai propri abitanti. Secondo il patrizio l'imposta sarebbe stata accettata di buon grado dai sudditi, poiché non si sarebbero attuate nuove catastazioni, con il conseguente accertamento delle ricchezze tassabili, e solo le autorità locali avrebbero avuto la responsabilità della ripartizione del tributo. Priuli in effetti coglieva uno dei nodi più delicati dei rapporti fiscali nella Repubblica veneta: i consigli cittadini avevano sempre osteggiato fermamente l'introduzione di nuove imposte temendo una ridiscussione dei carichi fiscali tra le città e i contadi, nonché un adeguamento dei carichi stessi alla reale consistenza della proprietà fondiaria cittadina. Del resto anche fra i patrizi veneziani i progetti di nuove gravezze sui terreni non riscuotevano il consenso generale. Nel 1539 l'idea d'imporre una decima sulle rendite agrarie di tutto lo Stato aveva trovato una dura opposizione all'interno del senato, che annoverava un gran numero di nobili con interessi fondiari nella Terraferma (51). E analogamente le varie proposte d'istituire un campatico alla vigilia e durante la guerra di Cipro si erano risolte in un nulla di fatto. Nel 1568, nonostante una decisione presa a larga maggioranza in senato, il campatico non trovò realizzazione; e tre anni dopo, nel pieno del conflitto, la proposta dei capi della quarantia riguardo una decima generale si scontrò contro l'opposizione di almeno metà del senato (52). L'altra questione, tenuta ben presente da Priuli, concerneva gli spazi di gestione del meccanismo fiscale attribuiti ai corpi locali della Terraferma. Uno degli elementi fondamentali che regolavano i rapporti tra la Dominante e il Dominio stava in una sorta di compromesso - o forse meglio, di bilanciamento - tra le esigenze particolari dei corpi locali e la sovranità veneziana. Il settore tributario, assieme a quello giudiziario, costituiva un campo di prova fra i più impegnativi: qui si dovevano incontrare i bisogni della finanza pubblica e del controllo statale, da una parte, con le resistenze e le necessità politiche dall'altra.
Sinora le esigenze del bilancio statale erano state sacrificate - secondo Priuli - in nome dei buoni rapporti con i sudditi; tuttavia era lo stesso Priuli che, allorché sottolineava la necessità di lasciare l'autonomia di riscossione del testatico alle comunità, accoglieva in qualche modo la preoccupazione di evitare tensioni con i contribuenti del Dominio. L'imposta riscuoterà una "universal satisfattione", proclama il nobile veneziano, "perché il Principe no farà catasticar su li beni, non vederà le sue intrate, né saperà quello che paga, et non farà niuno di quelli effetti che tanto dispiaceno a tutte le città; et li sudditi veniranno a restar patroni della distributione della gravezza, come è sta sempre et secondo il suo desiderio". E c'è da chiedersi se egli, nel momento in cui esponeva il progetto, pensasse solamente alle prevedibili resistenze dei consigli cittadini oppure se si preoccupasse di rassicurare i numerosi proprietari fondiari che sedevano fra i banchi del senato.
Occorre inoltre sottolineare ulteriori elementi che rendono il progetto di Zuan Francesco Priuli una testimonianza assai interessante della - per così dire - filosofia fiscale del patriziato veneziano, o almeno di alcuni suoi esponenti. Priuli non faceva alcuna distinzione all'interno del corpo tassabile; l'unica differenza doveva riguardare l'importo attribuito ad ogni veneziano (un ducato), che costituiva il doppio della quota assegnata ai sudditi della Terraferma. Non si dovevano distinguere, in sostanza, i contribuenti della Dominante da quelli del Dominio, i nobili e i cittadini dai distrettuali, i privilegiati e gli esenti da quelli che non lo erano. Era una concezione, questa, che in parte apparteneva ad una consolidata politica tributaria di Venezia. Il sistema fiscale non distingueva, come in altri paesi, il ceto nobile dai contribuenti del terzo stato. I privilegi fiscali nobiliari, che altrove traevano origine dalla funzione militare dell'aristocrazia al servizio del principe, non potevano essere sostenuti dalla nobiltà veneta; una nobiltà per lo più di origine urbana e mercantile, i cui avi avevano atteso alle faccende della mercatura, preferendo il tintinnio delle monete sonanti e le sommesse mediazioni commerciali al cozzo delle spade e degli scudi e al chiassoso fragore delle battaglie. Certo, vi erano parecchi nobili del Dominio che godevano di prerogative particolari, tuttavia i loro privilegi derivavano dalle concessioni per meriti conseguiti al servizio di Venezia. La stessa aristocrazia veneziana, il gruppo che si trovava al vertice della gerarchia politica e sociale della Repubblica, poteva vantare alcuni privilegi riguardo unicamente il foro giudiziario e l'attività commerciale. D'altra parte gli appartenenti al patriziato marciano controllavano mediante le proprie magistrature i meccanismi dell'apparato tributario, dall'accertamento dell'imponibile alla riscossione dell'imposta; e probabilmente nell'ottica dei ceti formalmente esclusi dalla gestione del potere i patrizi venivano considerati un gruppo che di fatto godeva di maggiori possibilità per attenuare il carico tributario. In effetti pare che verso la metà del secolo i Veneziani facoltosi pagassero una somma minore in imposte dirette di quanto ricevessero in pro sui titoli dei Monti (53).
Zuan Francesco Priuli includeva fra le "teste" tassabili, senza operare alcuna distinzione, anche gli ecclesiastici, sia i secolari che i regolari. La posizione fiscale dei chierici e dei loro beni costituiva da lungo tempo un nodo delicato dei rapporti fra la Serenissima e la Santa Sede. Durante il Quattrocento la Repubblica era riuscita a tassare in una certa misura gli ecclesiastici, facendo leva sul suo ruolo di difesa della cristianità nel Mediterraneo orientale. Tuttavia, dopo la crisi di Cambrai, il papato aveva messo in discussione talune prerogative del governo marciano, limitando in linea di diritto le pretese veneziane alla nomina dei propri vescovi, e altresì riservandosi di concedere allo Stato d'imporre le decime sui chierici veneti (54). Lungo il Cinquecento la tendenza del corpo ecclesiastico a distinguersi dal resto dei contribuenti si era fatta vieppiù marcata. Non solo si metteva in discussione il diritto statale a colpire i sudditi ecclesiastici, le loro istituzioni e i loro beni, ma, una volta accettata l'imposizione, dovevano essere gli organi della Chiesa veneta a controllare i meccanismi di riscossione. Era, questo, uno dei nodi più importanti dei rapporti fiscali fra Stato e Chiesa. Zuan Francesco Priuli in effetti non pare aver tenuto conto di questo delicato aspetto; e proprio su questo punto s'incentrarono efficacemente le critiche degli oppositori del suo progetto, e specie quelle del savio del consiglio Alvise Zorzi q. Benedetto (55). Egli si mostrava assai perplesso riguardo la possibilità che il pontefice permettesse l'imposizione del testatico sul clero: si pensi alle enormi difficoltà per ottenere le "giustissime decime" che, in fin dei conti, gravavano su beni che un tempo erano appartenuti ai laici - rimarcava il patrizio -; come si può credere di poter tassare impunemente "la testa ecclesiastica sacra et religiosa?". E ancora: i chierici come avrebbero potuto ammettere che gli stessi contadini potessero catasticare e tassare i loro beni, oltre che gravarli anche per le "teste" povere? Era un'idea, insomma, "veramente lontana da ogni ragionevole credenza". Zorzi poneva inoltre il problema della differenziazione fra le diverse categorie di contribuenti; un problema che affrontava in maniera molto più realistica di quanto avesse fatto Priuli. Troppi erano gli ostacoli che si frapponevano ad una realizzazione di un'imposta che non tenesse conto delle suddivisioni fra i sudditi: fra i cittadini, i distrettuali, i poveri e i benestanti; si rischiava - a vedere di Zorzi - di introdurre una "mala semenza" che innescasse un'aspra conflittualità fra i sudditi. I cittadini mai avrebbero sopportato che i distrettuali estimassero le loro terre e riscuotessero l'imposta; e poi chi avrebbe deciso quali e quante persone dovessero essere esentate? Era meglio pertanto mantenere nel Dominio le gravezze già esistenti, senza introdurre "cose spaventevoli, nove, che possono generar moto, et tirar seco gran consequentie". Zorzi quindi concludeva lodando la tradizionale "moderatione et destrezza" seguita dai padri della Repubblica, che hanno sempre evitato di seguire le vie "incerte" a scapito di quelle "certe". Era una visione, quella del savio Alvise Zorzi, che probabilmente era accolta da gran parte dell'aristocrazia veneziana, legata ad una concezione tradizionale della politica e della funzione del gruppo dirigente. La proposta di Zuan Francesco Priuli postulava invece un'azione energica dello Stato, le cui esigenze finanziarie dovevano prevalere sulla "prudenza" verso i sudditi. Tuttavia il suo progetto d'imposta era destinato ad una sconfitta già in sede di discussione preparatoria per il senato. Sul piano operativo il testatico, così com'era stato concepito da Priuli, poteva costituire un'occasione di conflittualità fra i corpi locali. Era dunque auspicabile mantenere il vigente sistema impositivo che, pur tra mille difetti, assicurava un certo gettito e, soprattutto, non forniva pretesti per contrasti fra i contribuenti e fra questi e i governanti veneziani.
Gli anni successivi al conflitto di Cipro registrarono un assestamento della fiscalità di guerra: per fronteggiare il pesante passivo finanziario si mantennero in vigore il dazio della macina e l'imposizione regolare della decima e della tansa, oltre che la decima sui salari degli officiali. A gravare gli impegni finanziari dello Stato giunse anche la peste, che colpì quasi tutti i territori della Repubblica fra l'estate del 1575 e la primavera del 1577. Nelle città della Terraferma i consigli fecero ricorso alle casse dei locali Monti di Pietà e a provvedimenti tributari, mentre anche a Venezia i contribuenti furono chiamati a versare decime e tanse straordinarie (56). Non appena il morbo si placò la domanda fiscale sui sudditi diminuì. Tuttavia rimaneva l'annosa questione degli interessi sul debito pubblico, che nel 1577 avevano raggiunto la somma di 514.983 ducati annui per i depositi in Zecca, e di quasi 200.000 ducati per il debito consolidato nei Monti. Vale a dire che all'incirca un terzo delle rendite nette dello Stato entrava direttamente nelle tasche dei creditori. La pesante situazione finanziaria, che si protraeva ormai dalla fine della guerra, non poteva essere sopportata ulteriormente.
Nel 1577 fu nuovamente Zuan Francesco Priuli a farsi portavoce delle ragioni della finanza pubblica, proponendo ancora una volta un progetto d'ammortamento dei debiti in Zecca. Ora però l'anziano patrizio non ventilava imposte difficilmente realizzabili, ma trovava all'interno delle stesse fonti finanziarie già esistenti la soluzione per i problemi della tesoreria. Le ragioni che spingevano Priuli a proporre la francazione dei depositi in Zecca non traevano origine unicamente dalle difficoltà del bilancio; egli si preoccupava di "levar le occasioni delli ragionamenti che si va facendo così in questa città come per tutto il suo stado con tanta indignità del governo publico" (57). I mugugni riguardavano ovviamente il passivo statale e i vantaggi che ne conseguivano i privati, e specie il ceto dirigente veneziano. Erano in gioco, insomma, non solo la salute finanziaria della Repubblica, la "dignità" e la "conservatione" dello Stato, ma altresì l'immagine stessa del patriziato veneziano di fronte ai sudditi, il suo prestigio e la sua autorevolezza, che derivavano fra l'altro - sul piano dell'autorappresentazione - dal principio della separazione fra l'interesse pubblico e l'utile privato.
La soluzione proposta da Priuli era abbastanza semplice. In base al gettito della decima e della tansa destinato alla restituzione dei capitali, e tenendo conto degli interessi stornati a mano a mano che si procedeva all'operazione di ammortamento, nel giro di vent'anni la Signoria si sarebbe liberata dal fardello del debito in Zecca (58). Il denaro allora tornerà a rifluire nella città, prevedeva Priuli, e verrà reinvestito nel commercio; ma soprattutto l'affrancazione darà "consolatione" a tutti i sudditi e "leverà quella mala impressione che è in molti", vale a dire che "li principali nobili di questa città" divengano "patroni" delle entrate pubbliche, e che se le godano "senza pagar gravezza di alcuna sorte". Il piano dapprima non trovò certo fra i patrizi una calda accoglienza. Chi non riusciva a comprendere la "sottilissima" "calculatione"; chi forse nutriva invidia nei confronti del suo ideatore; chi infine temeva per il "particular commodo" delle proprie rendite; chi addirittura imputava a Priuli di aver rivelato gli "arcani" della finanza pubblica: di fronte a tante perplessità e "passioni aliene" il progetto inizialmente venne respinto (59). Priuli tuttavia non si perse d'animo, e poco dopo tornò alla carica, ripresentando il progetto in modo più chiaro, e probabilmente facendo opera di convincimento fra i patrizi indecisi e perplessi. Finalmente il 21 giugno 1577 il consiglio dei dieci approvava il piano e poco dopo dava inizio all'operazione di ammortamento dei depositi in Zecca, nonostante gli "interessati particolari" si fossero risentiti, strepitando che la fede pubblica fosse stata "maculata" (60). Si trattava di una vittoria personale di Priuli e del gruppo di patrizi che l'aveva sostenuto nei corridoi del palazzo Ducale, durante le riunioni del collegio e dei dieci; ma si trattava altresì del prevalere di una particolare concezione della finanza pubblica. Si metteva in discussione la gestione del debito pubblico indirizzata a sostenere le rendite patrizie, i cui costi ricadevano sui contribuenti tramite una fiscalità gravosa e in continuo stato d'emergenza. E nello stesso tempo si accettava completamente il principio della tassazione diretta riscossa regolarmente anche in periodo di pace; tassazione che oramai nel pieno Cinquecento aveva sostituito il sistema basato prevalentemente sui prestiti coatti.
L'affrancazione delle serie dei titoli in Zecca procedette più speditamente di quanto avesse previsto Priuli. Il gettito delle decime e delle tanse, il recupero di crediti d'imposta, la vendita di beni appartenenti allo Stato ed un riordino contabile effettuato nel 1579 consentirono alla Signoria di restituire i capitali ai prestatori nel giro di soli sette anni. Infatti il 15 giugno 1584 il senato, che nel frattempo aveva assunto il governo della materia finanziaria, dichiarava con soddisfazione che era avvenuta la completa restituzione dei debiti aperti in Zecca (61). Rimane aperta la questione dell'uso che i Veneziani fecero di quest'ondata di denaro che si abbatté in città. Erano soldi che, in fin dei conti, erano stati investiti nel debito pubblico per trovare una certa sicurezza; nei depositi in Zecca erano affluite le doti delle mogli e si erano costituite quelle delle figlie. Ora tutto questo denaro doveva trovare una nuova collocazione, che assicurasse un rendimento soddisfacente e, soprattutto, una sicurezza di stabilità della rendita. Era una preoccupazione, questa, che nel Cinquecento assillava i Veneziani; e anche coloro che investivano ancora i propri capitali nei sempre più rischiosi traffici mercantili, giunti al tramonto della loro vita preferivano riporre i propri guadagni nei titoli di stato o nei prestiti livellari piuttosto che continuare a sottoporli ai capricci della fortuna. Giacomo Foscarini, per esempio, che da giovane aveva praticato assiduamente i fondaci dei mercanti, nel 1599 dichiarava di non avere oramai alcun denaro impiegato in operazioni mercantili (62). E Marc'Antonio Grimani nel 1558 aveva avvertito i suoi esecutori testamentari che, nel caso il governo avesse provveduto ad affrancarsi dai debiti del Monte del Sussidio, il capitale doveva essere investito in un fondo "cauto, suficiente et sichuro" (63). La previsione di Zuan Francesco Priuli che il denaro restituito ai creditori dello Stato avrebbe ravvivato e tonificato i commerci della Serenissima non sembrava trovare rispondenza nella propensione economica dei Veneziani. È lecito ritenere infatti che una buona parte dei capitali liberati dalla Zecca abbia preso la via degli investimenti in Terraferma, e in particolare nell'acquisto di fondi rurali e nel prestito ipotecario. Proprio al tramonto del Cinquecento sembra riprendere il sensibile processo d'investimento dei capitali veneziani verso il Dominio (64). Si potrebbe assumere ad esempio di tale fenomeno lo stampatore Luc'Antonio Giunti, il quale se negli anni Sessanta e Settanta non manifestò particolari propensioni verso gli acquisti fondiari, fra il 1585 e il 1601 entrò in possesso di almeno 225 campi e di alcuni immobili urbani, tanto da raddoppiare - giunto al termine della sua vita - il patrimonio fondiario che egli aveva ereditato dai familiari (65). Erano forme d'impiego del denaro, queste, che appagavano il bisogno di sicurezza che pervadeva i Veneziani in quel periodo. Nel 1579 i 4.000 ducati che Nicolò Vendramin si vide restituire dai provveditori in Zecca furono tramutati in un livello concesso al procuratore Lorenzo Correr (66); e molti testatori indicavano nei livelli l'alternativa ai titoli del debito pubblico, oramai in fase di affrancamento.
Sarebbe un errore tuttavia enfatizzare oltre modo la spasmodica propensione dei Veneziani verso la rendita parassitaria. Gli acquisti fondiari in Terraferma implicano, per molti aspetti, un investimento di capitali in funzione del mercato, e specie nel caso della risicoltura, che richiedeva un ingente esborso iniziale di denaro. La stessa produzione laniera, che caratterizzerà l'industria veneziana sino all'aprirsi del Seicento, sottintende un coinvolgimento di numerosi imprenditori locali, patrizi e borghesi. Certo, i circuiti finanziari che creano e moltiplicano la ricchezza nella Venezia di fine Cinquecento sembrano essersi assottigliati rispetto al secolo precedente. Si fa strada l'interesse nei confronti del mercato dei cambi, delle assicurazioni - forse in connessione con la passione per il gioco che pare colpire la città. È la stagione dei Fiorentini e soprattutto dei Genovesi, che controllano il sistema creditizio basato sulle fiere dei cambi. Sono loro che, forti dell'esperienza e della pratica acquisita in decenni al servizio dei vari sovrani europei - e in particolare degli Asburgo -, riescono a rastrellare parecchio denaro dai Veneziani, e specie dai patrizi (67). Il già menzionato Giacomo Foscarini, per esempio, nel 1602 ricordava di avere 12.000 ducati "sopra li cambii" (68). Si trattava di operazioni che, sostanzialmente, assicuravano un certo profitto, la cui entità dipendeva dal gioco delle variazioni dei cambi, ma che comunque appariva abbastanza sicuro. Ad ogni modo, i pochi dati che conosciamo lasciano ritenere che i margini di guadagno fossero apprezzabili. L'utile lordo annuo del 12% che si ricavò in circa sei anni da un'operazione cambiaria effettuata agli inizi del Seicento a nome del conte Francesco Martinengo costituiva un risultato allettante. E ottimi esiti furono conseguiti anche in altri casi (69). Non è il caso tuttavia di generalizzare, poiché qualche sporadico elemento non può indurre a proporre facili modelli. Quel che preme sottolineare è la ricerca dei Veneziani di una relativa sicurezza della rendita; una sicurezza che il mercato creditizio - strutturato nei vari livelli - pare offrire più di altri settori. Occorre tener altresì conto delle eventuali prospettive di collocazione del denaro nel debito pubblico di altri Stati. Nonostante non si conoscano ancora dati precisi sull'entità di tali investimenti è presumibile che vi sia stato un movimento di capitali oltreconfine, verso le altre tesorerie. Nel 1595, ad esempio, Paolo Antonio Labia acquistava ottanta luoghi del Monte d'Ungheria in Roma; e altri 53 risultava possederne nel febbraio 1609 (70). Usura e commercio comunque continuano a convivere in laguna, sebbene il "negotio" della mercatura abbia perso in qualche misura quell'attrattiva - specie nell'ambito del patriziato - che aveva tradizionalmente esercitato per secoli.
Gli oltre cinque milioni dei depositi in Zecca dunque trovarono la città in una fase delicata: una fase in cui le opzioni economiche e il sistema di valori registravano dei mutamenti strutturali. Ed è ancor più sorprendente, al di là degli aspetti strettamente finanziari dell'operazione, vedere come il patriziato veneziano - o meglio, una sua parte - abbia deciso di eliminare una delle più attraenti fonti di rendita, quali erano i titoli del debito in Zecca. Certo Zuan Francesco Priuli nel momento in cui proponeva l'affrancamento di una gran parte del debito statale era ben conscio di attirarsi le ire di molti patrizi; tuttavia occorre dar atto al ceto dirigente marciano di aver imboccato una strada che privilegiava la buona salute della finanza statale piuttosto che il consolidamento delle rendite private. Del resto è probabile che il piano di Priuli sia stato finalmente accettato anche per la possibilità d'impiego che i capitali privati avrebbero trovato sul mercato creditizio non solo della città ma anche in Terraferma.
Il nobile Priuli non si accontentò che la sua proposta circa i depositi in Zecca avesse trovato realizzazione. Nel marzo del 1579, nel pieno del programma di restituzione dei prestiti, presentò un altro piano per affrancare la Repubblica dal fardello dei debiti appoggiati alle serie dei Monti (71). Secondo Priuli la finanza statale, a patto che si riscuotessero regolarmente le angarie e che si assegnassero sempre le quote destinate all'affrancazione, era in grado di restituire i capitali ai creditori nei Monti. Il sistema era sostanzialmente analogo a quello che era stato messo in atto per i depositi in Zecca. Nel giro di otto anni la Signoria avrebbe reso circa quattro milioni di ducati, risparmiando una spesa annua di interessi di 200.000 ducati. La realizzazione dell'operazione - sosteneva Priuli - avrebbe permesso allo Stato di abolire le decime e le tanse a perdere a Venezia, nonché il sussidio e il dazio macina in Terraferma. "Queste sono quelle gravezze", affermava il patrizio veneziano, "che per giustitia a sollevamento de sudditi deveno esser levate, quando bene dovessero apportar qualche incommodo alla Serenità Vostra, importando molto più al governo della Repubblica il rispetto della giustitia et gratitudine de popoli che lo accrescimento de entrate". In questo caso il pensiero di Priuli sembra aver conosciuto un'evoluzione rispetto a qualche anno prima, all'epoca della prima proposta per l'ammortamento dei debiti in Zecca. Allora egli si era scagliato contro l'eccessiva prudenza del governo nel tassare i sudditi del Dominio; adesso invece le esigenze politiche del "quieto vivere" prevalgono sulle necessità di cassa. Necessità che del resto si stavano rendendo meno pressanti grazie all'alleggerimento dell'onere passivo del debito pubblico. Conviene altresì rilevare che Priuli non sembra aver accettato il principio dell'imposizione diretta regolare; egli considera le angarie e il sussidio ordinario come gravezze legate alle congiunture militari, con caratteristiche di straordinarietà. Una concezione, questa, che oramai non trovava un riscontro effettivo nella realtà delle vicende statali veneziane ed europee. La proposta comunque non venne accettata. Priuli probabilmente aveva già provocato la suscettibilità di molti patrizi, che si erano visti loro malgrado diminuire le rendite sui titoli di stato; e probabilmente le voci contrarie avevano avuto gioco facile sottolineando gli impegni finanziari che richiedeva l'affrancazione dei depositi in Zecca. Si continuò pertanto a restituire i soli capitali depositati in Zecca.
Non appena l'affrancazione terminò il senato decise, pur diminuendo la richiesta fiscale statale, di continuare ad imporre regolarmente una decima e una tansa sui contribuenti veneziani. I denari precedentemente assegnati all'affrancazione vennero destinati alla costituzione di un "deposito grande", che doveva rappresentare una riserva finanziaria da impiegare in caso di bisogno (72). La propensione ad accumulare delle riserve era una caratteristica delle politiche finanziarie degli Stati dell'epoca, salvo poi realizzarla tenendo conto dei bisogni del bilancio. Durante il papato di Sisto V, per esempio, a Castel Sant'Angelo fu accumulato un consistente "tesoro sacro" a cui i papi potevano ricorrere unicamente per occasioni eccezionali (73). E un'analoga riserva, sebbene meno vincolata dai motivi di prelievo, venne creata negli anni Sessanta e Settanta dalla tesoreria inglese (74). Chi può, insomma, cerca di metter da parte il surplus di bilancio per le eventuali emergenze future. Tuttavia il tesoreggiamento delle eccedenze poteva avere delle ripercussioni sulla piazza finanziaria. A Firenze, pare che l'accumulo delle rimanenze finanziarie nelle casse statali sia stata una delle cause principali delle difficoltà della piazza, rimasta "eshaustissima di danari" a metà degli anni Settanta (75). Per quanto riguarda Venezia non si registrano voci che, tenendo presente la situazione del mercato monetario, si levino contro l'istituzione del tesoro (76). In effetti mezzo milione di ducati all'anno non era cosa da poco: ciò rappresentava circa un quarto delle entrate nette dello Stato. Altri ordini di grandezza possono offrire qualche ulteriore confronto. Nel 1584 corse voce che la causa del fallimento del Banco Pisani-Tiepolo stesse nella perdita della nave Nana, proveniente dal Levante, che trasportava merci per un valore di 400.000 ducati (77). Un danno, questo, la cui entità era stata ritenuta sufficiente per incidere sugli equilibri della piazza veneziana. È stato calcolato che nel medesimo periodo si sottoscrivessero polizze assicurative per un importo che superasse i tre milioni e mezzo di ducati in un anno (78). Nel 1591 il capitale investito in livelli registrato da 39 notai veneziani si aggirò sui 280.000 ducati (79). E considerando la particolare predisposizione verso questo tipo d'investimento c'è da credere che la somma fosse considerevole. Il tesoro di riserva, ad ogni modo, continuò ad essere accumulato negli anni: nel 1597 la cassa del Deposito grande conteneva oltre 6.400.000 ducati; e nel 1609 se ne contavano più di nove milioni (80). Era tutto denaro, questo, che si sarebbe rivelato assai utile negli anni a venire.
L'imposizione delle angarie proseguì regolarmente, a cadenza annuale, sino al 1593, allorché vennero imposte mezza decima e mezza tansa straordinarie in occasione dell'erezione della fortezza di Palma. Dall'anno successivo però si riprese l'uso d'intervallare la riscossione di una decima a quella di una tansa. Era il segno di una finanza pubblica che godeva di buona salute: sembrava di essere tornati ai felici anni che avevano preceduto la guerra di Cipro, quando il peso delle imposte certo non assillava i cittadini veneziani.
Il particolare momento dell'erario consigliò di por mano all'ammortamento del debito pubblico basato sui Monti Novissimo e Sussidio; ammortamento che - come si ricorderà - era stato proposto da Zuan Francesco Priuli, senza peraltro ottenere il successo auspicato. Nel 1595 il progetto di affrancazione venne ripresentato da Giacomo Foscarini q. Alvise, che ottenne il consenso del senato. Patrizio fra i più prestigiosi, Foscarini aveva frequentato come mercante i fondaci di Londra e in seguito aveva ricoperto alte cariche nel governo della Repubblica: provveditore generale a Creta, e poi in Dalmazia, savio del consiglio, ambasciatore a Parigi, procuratore di S. Marco... Nel 1585 aveva sollecitato, assieme al nobile Antonio Bragadin, un accordo fra Venezia e la Spagna circa la concessione alla Signoria del monopolio del traffico delle spezie indiane (81). La proposta, respinta dal senato, costituiva l'affermazione degli ideali filo-spagnoli di Foscarini - legato al gruppo dei patrizi "vecchi" -; ideali che propugnavano inoltre il trionfo della Chiesa controriformista appoggiata dallo Stato. E non a caso durante il suo provveditorato a Candia, tra il 1574 e il '77, Foscarini si era atteggiato ad energico sostenitore di una riforma dei costumi (82). Aveva altresì riorganizzato l'apparato burocratico e la tenuta dell'amministrazione finanziaria, suscitando peraltro qualche perplessità tra alcuni patrizi (83). Perplessità che derivavano forse dal carattere talvolta intransigente del nobile Foscarini che, comunque, dimostrerà in varie occasioni di anteporre il bene pubblico all'interesse privato. E proprio la ricerca del "beneficio della Patria" l'aveva spinto a presentare il piano d'ammortamento dei capitali nei Monti. Ovviamente, come nel caso dei debiti in Zecca, furono innalzate notevoli difficoltà: "quelli li quali riscuotevano questo denaro", spiega il biografo di Contarini, "erano per la maggior parte gentil'huomini vinetiani li quali, preferendo per aventura il proprio al publico interesse, potevano impedirglielo, e render vana ogni sua fatica, quindi ne conseguiva appresso un degno timore, che mentr'egli procurar voleva il beneficio della Patria, non concitasse a suoi danni l'odio de molti" (84). La responsabilità che Foscarini si stava assumendo era pesante. Tuttavia, nonostante i malcelati mugugni, s'iniziarono le operazioni d'ammortamento. Giova notare che, pressappoco nel medesimo lasso d'anni, a Genova si parlava di liberare lo Stato dal pesante fardello del debito pubblico. Tuttavia prevalse l'opinione di non toccare il sistema del debito, che faceva perno attorno alla Casa di S. Giorgio (85). Qui, a differenza di Venezia, le ragioni dei privati s'imposero su quelle dello Stato, inteso come organismo impersonale e superiore.
Nell'ottobre del 1595 furono eletti tre provveditori all'affrancazione dei Monti Novissimo e Sussidio, e l'anno successivo si avviò la restituzione dei capitali, che ammontavano a circa 2.400.000 ducati, di cui 1.200.000 appartenenti alla serie del Monte Novissimo (86). Il denaro occorrente provenne, oltre che dai normali cespiti dell'erario, dalla riscossione di crediti d'imposte e dalla vendita di beni demaniali in città. I creditori privati furono progressivamente rimborsati in base ad un'estrazione a sorte, ad eccezione dei monasteri e dei luoghi pii, i cui capitali (circa 340.000 ducati) vennero restituiti solamente al termine dell'affrancazione (87). Nel 1600 si dette inizio - non senza qualche titubanza - anche alla restituzione dei crediti nel Monte Vecchio, vale a dire i titoli più vecchi dell'intero sistema del debito pubblico veneziano (88). L'affrancazione di questo debito fu facilitata dal fatto che lo Stato acquistò le "partide de capitali" al prezzo medio corrente (fra il 2,5 e il 5%) emerso da una rilevazione sul mercato dei titoli dal 1521 (89). I titoli "vergini" - cioè quelli rimasti in mano al sottoscrittore o ai suoi eredi - furono invece liquidati al doppio del prezzo decretato per gli altri titoli. Pare che verso il 1620 la restituzione di questi capitali fosse terminata (90). Agli inizi del Seicento, così, la Repubblica aveva virtualmente estinto i propri debiti, salvo qualche somma depositata in Zecca a beneficio di qualche ente o privato (91).
All'incirca quattro milioni e mezzo di ducati finirono nelle tasche dei titolari dei crediti nei Monti. Quest'operazione fu senz'altro positiva nell'ottica della finanza statale, "oppressa" - come ebbe a scrivere Nicolò Contarini - da più di settecento anni dal debito; ma per gli ex creditori sorsero notevoli complicazioni. Ai Veneziani si presentarono i medesimi problemi di impiego del denaro che erano sorti in precedenza durante l'affrancazione dei capitali in Zecca. Ora si trattava di rendite che costituivano talvolta da generazioni i pilastri delle finanze familiari. Analogamente, gli enti ecclesiastici e i luoghi pii denunciarono preoccupanti difficoltà, proprio in seguito alla restituzione dei capitali prestati allo Stato negli anni precedenti. In effetti la rendita sui titoli non implicava alcuna spesa da parte dei creditori, mentre gli altri settori d'investimento comportavano maggiori preoccupazioni, impegni e spese. Ad accrescere le difficoltà del clero concorreva la legislazione, che nel 1605 estendeva a tutto lo Stato i limiti riguardo l'acquisto di beni fondiari da parte degli enti ecclesiastici. La possibilità d'investimento nella terra e nel debito pubblico, dunque, si era ristretta tanto da preoccupare seriamente gli ecclesiastici. E non è certo un caso se tra le clausole dell'accordo che pose fine alla vicenda dell'Interdetto fu prevista l'emissione di una serie di titoli in Zecca per un ammontare di 600.000 ducati al 4% di pro (92).
La domanda fiscale nel primo '600
Il ristabilirsi delle normali relazioni fra Venezia e la Santa Sede aveva riportato una condizione di allentamento delle tensioni politiche e militari; un allentamento che si riflette altresì nella pressione fiscale attuata mediante l'imposizione diretta. L'ammassamento del tesoro di riserva nel Deposito grande, nonostante qualche interruzione, continuò con una certa sistematicità; né il governo fu costretto a ricorrere al prestito pubblico. Anzi, nel marzo del 1614 il senato decideva di affrancare il deposito in Zecca che era stato aperto nel 1607 - probabilmente quello stesso contemplato negli accordi dopo l'Interdetto -, e a tal fine venivano impiegati denari destinati al tesoro di riserva (93). La particolare atmosfera finanziaria tuttavia venne offuscata dalle stringenti necessità dettate dal conflitto che impegnò Venezia e gli Arciducali fra l'autunno del 1615 e il settembre del 1617. In questo periodo la macchina militare divorò almeno 4.750.000 ducati (94). Un ulteriore impegno finanziario fu rivolto a favore del duca di Savoia, in quegli stessi anni impegnato contro la Spagna, il quale ricevette fra il 1616 e il 1617 poco meno di 1.750.000 ducati a titolo di sovvenzione per la continuazione del conflitto. Numerose lettere di credito vennero sottoscritte dall'ambasciatore veneziano a Torino, che non ebbe gran difficoltà a trovare i finanziatori che anticipassero i contanti a favore dei fornitori e dei soldati del duca (95). La somma necessaria per la guerra in Friuli e per la politica di aiuti ai Savoia, seppur rilevante, venne raccolta, comunque, senza richiedere sforzi eccessivi, almeno nei primi tempi, ai contribuenti.
Nella fase iniziale della guerra, infatti, il denaro riposto nel Deposito grande consentì di fronteggiare il grave momento. Zecchini e scudi d'argento vennero prelevati dalla cassa di riserva e inviati direttamente alle truppe e alla flotta. Dapprima i vari provvedimenti fiscali furono attuati per reintegrare le somme prelevate dalla riserva. Così nel marzo del 1616 il senato decretava un aumento del dazio della macina di Venezia e Dogado di 12 soldi per staro; e nello stesso tempo imponeva, in aggiunta alle altre angarie, mezza decima e mezza tansa all'anno per i successivi otto anni, il cui importo veniva destinato al Deposito grande (96). A metà settembre, ad un anno esatto dall'inizio delle ostilità, il governo iniziò a far ricorso al prestito pubblico. Il senato autorizzava per i successivi due mesi i provveditori in Zecca ad accettare in deposito 300.000 ducati contanti e in buona valuta assicurando un pro del 5% per un periodo di otto anni ed esente da imposte. Erano delle condizioni soddisfacenti per i prestatori, che finalmente vedevano riaprirsi la possibilità di collocare il proprio denaro in un fondo sicuro e relativamente vantaggioso. Dopo due mesi si ordinò un'analoga operazione per altri 300.000 ducati, a riprova che il primo deposito in Zecca aveva trovato dei solleciti prestatori. E a dicembre, ancor prima che scadesse il termine per il prestito di novembre, i senatori autorizzarono un'ulteriore emissione di altri 300.000 ducati (97). Tra settembre e dicembre, dunque, la Signoria chiese a prestito 900.000 ducati in buona valuta; tutto il denaro venne presumibilmente raccolto entro i primi mesi dell'anno successivo, vale a dire in un tempo abbastanza breve. A titolo di riferimento, la somma prestata non era di molto inferiore all'entrata netta annua delle camere di Terraferma che giungeva nelle casse veneziane in quel periodo (98). Nel 1617 le emissioni di titoli furono assai limitate: a maggio s'istituiva un deposito in Zecca al 10%, con la clausola che il debito si estinguesse con la morte del titolare del prestito. Ad ottobre, all'indomani della pace, fu emessa un'altra serie di titoli per l'ammontare di 100.000 ducati al 5%, per soddisfare le richieste di "diversi particolari" che premevano per versare i propri denari nei depositi in Zecca (99).
Le ragioni che stavano alla base di questa "corsa al prestito" non erano diverse da quelle che avevano spinto i Veneziani di due generazioni precedenti ad investire nel debito pubblico. I titoli di stato assicuravano una rendita sicura e, specie in quegli anni, non affatto disprezzabile. Non appena il senato autorizzò la prima emissione la risposta dei Veneziani non si fece attendere. Ad una settimana dall'apertura del primo deposito in Zecca, per esempio, 14.000 ducati vennero depositati a nome di Zuan Francesco Labia - la cui casata avrebbe conseguito la nobiltà nel 1646 -; e altri 8.000 ne furono aggiunti nel novembre del '17. La madre di Zuan Francesco, Leonora Baglioni, vedova di Paolo Antonio Labia, versò in un anno esatto (novembre 1616 - novembre 1617) ben 96.060 ducati e 12 grossi nelle mani degli scrivani del deposito in Zecca al 5% (100). Madre e figlio, insomma, da soli avevano partecipato con un decimo dell'intero ammontare del prestito decretato per la serie al 5%. I depositi in Zecca al 5% costituivano la principale serie del prestito, che pertanto può essere presa come punto di riferimento. Nel secondo decennio del Seicento un tasso d'interesse netto del 5% poteva essere considerato soddisfacente. A Milano il denaro rendeva pressappoco in un'analoga percentuale; e a Roma i luoghi dei Monti vacabili (vale a dire i titoli vitalizi) assicuravano il 6% d'interesse nominale; a Genova addirittura, probabilmente a motivo della particolare posizione della piazza nel quadro del mercato finanziario europeo, il saggio d'interesse sul debito pubblico era assai minore; in Francia le rentes assicuravano il 6,25%, mentre in Inghilterra le difficoltà della Corona costringevano ad offrire un interesse sino al 10% (101). Certo, i Veneziani che avevano prestato alla Signoria durante la guerra di Cipro avevano spuntato un tasso superiore; tuttavia la situazione del mercato finanziario all'alba del Seicento presentava notevoli differenze rispetto ai decenni precedenti. In questo lasso d'anni ebbe inizio la tendenziale diminuzione del tasso d'interesse; diminuzione che si registra un po' ovunque, e che caratterizza tutto il secolo. Malgrado nel secondo decennio del Seicento la congiuntura dei prezzi mantenesse una notevole tensione inflattiva, il saggio d'interesse sui titoli offerti dallo Stato veneziano non pare seguire l'analoga tendenza. Probabilmente l'elemento che spiega l'apparente incongruenza del fenomeno è da ricercarsi nella presenza di ingenti capitali sulla piazza veneziana, che concorreva a limitare il costo del denaro. Il risparmio, in un particolare momento di difficoltà dei commerci, probabilmente aveva raggiunto tali livelli da incidere sensibilmente sugli equilibri finanziari; e del resto l'emissione di titoli al 5% indicherebbe che il governo sapeva di poter soddisfare il proprio bisogno di denaro nonostante l'interesse promesso fosse minore rispetto agli anni addietro. Il caso dei Labia, in effetti, fa supporre che molte persone a Venezia aspirassero a collocare i propri denari in una misura che, forse, la ricettività del mercato non consentiva.
Molte persone anche al di fuori di Venezia condividevano la medesima aspirazione. Fra queste certamente i Genovesi costituivano il gruppo più agguerrito. I sudditi della Superba già da un certo tempo operavano sulla piazza veneziana: gli Spinola, i Centurione, i Sivori, i Doria e i loro agenti erano ben conosciuti nel mondo delle assicurazioni marittime, dei cambi e dei commerci (102). All'epoca della guerra con gli Arciducali risale probabilmente l'interesse genovese per i titoli di stato emessi dalla Signoria (103). Un interesse che in verità si rivelò alquanto considerevole. I depositi vitalizi aperti fra il 1617 e il '25 registrarono un afflusso di denaro genovese pari al 46,3% del capitale complessivo (1.008.648 ducati su un totale di 2.1 77.796 ducati) (104). Nel gennaio del 1623 il senato, a riprova dell'importanza assunta dai prestatori genovesi e della preoccupazione che alimentavano in seno al governo veneziano, ordinò la compilazione di un elenco dei Genovesi che avessero investito nei titoli vitalizi (105). Fra il 1618 e il '33 almeno 270 Genovesi sottoscrissero prestiti nel deposito vitalizio al 12% (106). Il debito pubblico veneziano dunque stava attirando le attenzioni di un gruppo - quello genovese - che in quanto ad esperienza e capacità aveva dato eccellenti prove nel mercato finanziario europeo. Occorre comunque dire che un elemento che potrebbe aver influito nell'attrarre i capitali genovesi verso la laguna sta nelle crescenti difficoltà che i finanzieri di Genova incontravano con la corona spagnola, il loro tradizionale cliente. Le bancarotte durante il regno di Filippo II e nel 1607 avevano costretto i banchieri genovesi ad una maggior cautela e a cercare nuove destinazioni per i loro investimenti finanziari; Venezia si prospettava una piazza accogliente.
Il governo non operò unicamente sul versante del credito: nel periodo conclusivo del conflitto e nei mesi successivi decretò alcune imposte assai significative. Le pesanti spese di guerra e la necessità di reintegrare la riserva finanziaria condussero a cercare nuovi cespiti. Il 6 maggio 1617 il senato decretava d'imporre un campatico sui beni fondiari dei Veneziani in Terraferma, una tassa di due grossi (8,33%) per ciascun ducato pagato di affitto sulle case a Venezia, da versare equamente fra il conduttore e il locatario, nonché una decima sui livelli. Si trattava di provvedimenti per taluni aspetti innovativi; e il gran numero di astensioni (sessantanove, a fronte di novanta-cinque favorevoli e sette contrari) lascia supporre che le discussioni e i sotterranei malumori abbiano lacerato il consesso dei senatori (107). In effetti la parte, oltre che istituire il tanto avversato campatico limitato - comunque solo ai Veneziani - e a rispolverare la tradizionale imposta sugli affitti, andava a colpire per la prima volta la forma di reddito basata sul prestito ipotecario. Già nel 1604 era stata presa in esame la possibilità di tassare l'attività creditizia svolta tramite i cambi, tuttavia non se n'era fatto nulla, a causa dei timori di toccare i delicati meccanismi del mercato cambiario, e quindi delle attività commerciali (108). Ciò significava che, al di là delle titubanze d'ordine economico, una parte del gruppo dirigente marciano guardava con particolare attenzione, e preoccupazione, alle dinamiche del mercato creditizio. Fra il 1610 e il 1630, ha scritto Gigi Corazzol, "una parte consistente del ceto di governo della Repubblica maturò la convinzione che era necessario, nell'interesse generale, ridurre la stretta che la rendita usuraria esercitava sulle attività produttive" (109). I patrizi, insomma, manifestavano chiaramente la volontà di trovare una via complementare all'imposizione fiscale sugli immobili; una via che incidesse, per quanto possibile, su certe scelte economiche che consideravano per taluni versi poco consone alla vocazione e all'interesse di Venezia. Circa 1.930 contribuenti presentarono le dichiarazioni fiscali per sottostare alla decima; pressappoco un veneziano ogni cinquanta adulti risultò usufruire di un reddito da livello. L'imponibile globale venne accertato in 280.000 ducati (110); una media di 145 ducati per ogni dichiarante. Non si tratta certo di una somma insignificante. Nella Venezia di quegli anni un mastro muratore, ammesso che potesse lavorare per 250 giornate all'anno, riusciva a guadagnare 120 ducati, e poco più ne riceveva un sergente di una compagnia di centocinquanta fanti (111). La nuova imposta, nonostante le oggettive difficoltà per l'accertamento, fece affluire nelle casse statali circa 20.000 ducati durante gli anni in cui venne decretata (112).
La fine delle ostilità nel Friuli orientale non comportò un conseguente alleggerimento della tensione finanziaria. Nel 1618 i costi dell'esercito e della marina assorbivano oltre 2.700.000 ducati, di cui circa due milioni erano rappresentati da spese di carattere straordinario (113). Nel 1619, oltre alle imposte ordinarie il senato decise di decretare le medesime tasse istituite nel '17, ma per un importo dimezzato (114). Sino al 1621 i contribuenti veneziani versarono una decima all'anno; l'anno successivo furono richiesti di due decime e almeno una tansa; e nel 1623 si tornò ad una decima. Anche nel settore dell'imposizione indiretta il secondo decennio del secolo vide la comparsa di nuovi dazi: rispetto al 1608 il bilancio del 1623 fece registrare un incremento di quasi mezzo milione di ducati grazie alle nuove imposte ordinarie, e altrettanti provenirono allo stesso titolo dalle camere della Terraferma (115). Gli anni a cavallo del 162o in effetti rappresentarono un momento assai delicato, soprattutto dal punto di vista economico e politico. Se erano sorte tensioni ai confini con lo Stato di Milano, costringendo la Signoria a mantenere all'erta l'apparato militare, assai più gravi apparivano le vicende legate ai commerci, alle manifatture e alla finanza. Proprio in quegli anni la produzione laniera a Venezia stava denunciando pesanti difficoltà; il numero dei telai che lavoravano ormesini bassi era passato da oltre 300 nel 1616-17 a 140 nel 1620 e addirittura a 80 nel '22, le importazioni della seta greggia dalla Siria che giungevano nel porto stavano calando; e lo stesso volume del naviglio che attraccava nel bacino di San Marco era in evidente calo (116). Anche nel Dominio i segni della grave congiuntura si facevano inquietanti. A Verona, uno dei centri più importanti della Terraferma, il dazio sulla seta era calato da 57.694 ducati nel 1617 a 46.000 nel 1626. L'ex capitano della città atesina, il nobile Michele Priuli, indicava proprio nell'eccessivo carico fiscale una delle cause principali della crisi dell'attività serica (117). La stessa imposizione tributaria sull'olio importato a Venezia stava provocando fenomeni quali un accresciuto contrabbando ed una contrazione del consumo del prodotto fra i ceti popolari, come pure delle difficoltà nel saponificio e nell'industria laniera (118). In questa situazione, assai delicata per l'economia veneziana e veneta, che proprio in questo periodo stavano manifestando i segni di una ristrutturazione interna al fine di cercare nuove vie per il proprio sistema economico urbano, la mano del fisco si fece indubbiamente più pesante. Nel 1621 le imposte dirette straordinarie sulle proprietà dei contribuenti veneziani avrebbero fornito un gettito di 264.000 ducati correnti, contro un'entrata ordinaria della decima e tansa di circa 85.000 ducati (119). I fratelli Marino e Sebastiano Badoer q. Barbaro sborsarono una media annua di 44 ducati a titolo di decime nel triennio 1617-19; nel periodo 1620-22 la quota diminuì a 38 ducati, mentre nei tre anni successivi i due patrizi versarono ben 62 ducati all'anno (120). Del resto sullo scorcio del secondo decennio l'importanza oramai assunta dagli investimenti fondiari e dal prestito ipotecario, e la parallela - ma non automatica - difficoltà nei commerci tradizionali costringevano il gruppo dirigente veneziano ad adottare misure tributarie che riequilibrassero, in una certa misura, un sistema economico in profondo mutamento. D'altra parte occorre tener presente l'effetto pernicioso prodotto da una pressione tributaria che si era fatta più accentuata, e che sembrava incidere sulle scelte operate dal mercato e dai contribuenti.
Il coinvolgimento nelle questioni della Valtellina e la guerra di Mantova chiusero il terzo decennio del Seicento provocando una tensione fiscale che si assestò su livelli elevati. Altre decime straordinarie sui livelli furono imposte nel 1624, nel 1625 e nel 1629 (121), estendendole anche alla Terraferma; tanse e decime colpirono sistematicamente i contribuenti ogni anno. Il primo maggio 163o il senato ordinò la riscossione di due decime e due tanse "a restituire" (122). Se i già citati fratelli Badoer pagarono una cinquantina di ducati per le decime decretate nel 1626, negli ultimi tre anni del decennio la quota superò i sessanta ducati (123). Tra il 1629 e il 163o il senato prese tre provvedimenti che aumentarono del 15% le tariffe daziarie (124), con una conseguente ripercussione sui prezzi. L'ultimo di questi aumenti - quello deciso nell'agosto del 1630 - non ebbe certo un cammino facile. La prima votazione - svoltasi il 3 agosto 1630 - ebbe solamente 78 patrizi favorevoli, contro 21, e ben 55 "non sinceri": poiché la maggioranza richiesta era stata superata per soli due voti la parte venne rinviata. Tre giorni dopo l'aumento veniva approvato con 88 voti a favore, 13 contrari e 37 astenuti. Una cinquantina di senatori pertanto, più o meno palesemente, mostrava qualche dubbio sull'opportunità del provvedimento. Vi era tensione in città e in tutto lo Stato: la guerra stava imperversando ai confini con Mantova, e le truppe veneziane non davano certo segnali di affidabilità; il morbo poi si era insinuato a Venezia a giugno, seminando la morte e accentuando le apprensioni fra la popolazione; la carestia, determinata da una drammatica sequenza di cattivi raccolti, stava infierendo su un tessuto sociale ed economico ai limiti della rottura. Occorreva denaro: denaro non solo per pagare i soldati che minacciavano l'ammutinamento, ma anche per sfamare la popolazione della Terraferma che si dibatteva tra la peste e la fame (125). La serie di addizionali si poneva dunque in una situazione carica di attriti e di difficoltà che, comunque, non impedirono ai senatori di decretare gli incrementi tariffari.
Nel settore delle imposte dirette, oltre alle tradizionali angarie, emerse fra il gruppo dirigente veneziano l'intenzione di cercare qualche altro strumento tributario. Il 4 agosto 1629 veniva presentata una parte in senato che prevedeva una tansa straordinaria da imporre su ogni "capo di casa" di Venezia e del Dogado. I più facoltosi avrebbero dovuto versare un ammontare sino a 240 ducati, mentre la soglia minima era fissata a mezzo ducato. Per l'accertamento dell'imponibile si sarebbero eletti sedici "sogeti de principali et più prestanti" fra i nobili (126). Dopo qualche aggiustamento il decreto venne pubblicato il 15 agosto. I nobili, cittadini e mercanti, "capi di casa o separati in fraterna" che pagassero d'affitto una somma superiore ai 12 ducati dovevano presentare entro 15 giorni la propria dichiarazione fiscale, "nella quale siano descrite particolarmente", intimava la legge "le facoltà che al presente possede di ogni sorte di beni, livelli, cavedali, industrie, mercantie, offitii, dinari in contanti, dinari dati a cambio", insomma tutti i capitali ad esclusione dei titoli del debito pubblico in Zecca. I ritardatari sarebbero stati colpiti con il massimo dell'imposta prevista (127). La concezione sottesa al provvedimento implicava la diversificazione all'interno del corpo dei contribuenti. Una distinzione che favoriva soprattutto gli strati meno agiati della popolazione, nonché quelle larghe fasce del patriziato povero che proprio in questi anni denunciava moti d'insofferenza e di avversione nei confronti del gruppo patrizio più eminente, per dovizia di ricchezze e per posizione di potere. La tansa straordinaria comunque, se in un primo momento sembrò assumere una particolare connotazione, più tardi si sarebbe rivelata un'imposta che, in ultima analisi, andava a favorire i maggiori contribuenti. Il denaro versato infatti sarebbe confluito nei depositi in Zecca al 7 e al 14% (128). L'imposta dunque si configurava come un ulteriore prestito obbligatorio, che certamente avrebbe inciso più sulle traballanti finanze delle famiglie meno agiate che su quelle delle grandi casate.
Assieme alla leva fiscale il governo agì anche sul versante del debito pubblico. A metà degli anni Venti la situazione debitoria dello Stato appariva accettabile. Nell'agosto del 1624 in senato si parlava di affrancarsi dal deposito al 5% con toni che lasciano intendere una relativa tranquillità finanziaria (129). Già a dicembre del medesimo anno, tuttavia, i provveditori in Zecca ebbero il mandato di emettere una serie di titoli per un valore di 200.000 ducati con un pro del 5 o 10%. L'anno successivo, "dovendosi insister in estraordinarie provisioni di denari per le presenti estraordinarie importantissime occorrenze", venivano aperti nuovi depositi vitalizi che avrebbero dato un interesse del 10% ai sottoscrittori al di sotto dei trent'anni, del 12% dai trenta ai cinquant'anni, e di un buon 14% a favore delle persone al di là dei cinquant'anni (130). Le condizioni erano assai favorevoli per i depositanti. Nel novembre del 1626 questo tipo di prestito allo Stato si sarebbe reso ancor più allettante. Ai depositanti non ancora diciottenni veniva offerto un tasso d'interesse del 12%, mentre il 14 sarebbe stato assicurato ai sottoscrittori più anziani (131). Tuttavia il senato respinse la proposta. Queste emissioni destano un certo interesse poiché, oltre al tasso d'interesse elevato, per la prima volta i senatori fanno un esplicito riferimento all'area dei potenziali sottoscrittori cui i provvedimenti si rivolgono. La Zecca infatti poteva ricevere denaro - si affermava nell'aprile del 1625 - "da quelli d'ogni conditione et tanto di questa città et del stato nostro quanto de stati alieni". E nel 1626 si indicavano ancora gli abitanti "nello stato nostro". Come si è già accennato in precedenza, i Genovesi risposero all'appello sollecitamente e con dovizia di capitali. Per quanto riguarda i sudditi del Dominio la scarsità della documentazione non consente di fornire dati ancorché indicativi. È opportuno comunque rilevare la novità, pur formale, introdotta nel consueto linguaggio che accompagnava le parti circa l'emissione di prestiti pubblici. La palese apertura dei depositi ai sudditi della Repubblica se da un lato era un sintomo delle drammatiche necessità che stringevano la finanza pubblica veneziana, dall'altro può essere intesa come il mutamento di un'ottica in seno al gruppo dirigente marciano. Si chiamavano all'appello, o meglio, si coinvolgevano tramite la sottoscrizione dei titoli di stato anche quei contribuenti che nei termini amministrativi veneziani erano definiti "fuochi esteri", a sottolineare la netta separazione fra la capitale e il Dominio. Forse, insomma, nell'ambito dei dirigenti veneziani si stava insinuando una concezione allargata della res publica; una concezione che stava comprendendo altresì il mondo della Terraferma, con le sue istanze, le sue attività economiche, i suoi valori.
Occorre comunque aggiungere che i provvedimenti sul debito pubblico fanno seguito ad una serie di inasprimenti tributari che toccano dapprima Venezia per interessare poi anche il Dominio da terra. Il dazio sulla macina venne decretato nel 1618 come un'imposta che dovesse colpire tutti i sudditi di Venezia e del Dominio; la decima sui livelli, seppur duramente contrastata dai consigli cittadini, gravò successivamente anche sui contribuenti della Terraferma; e il campatico avrebbe interessato i "fuochi esteri" all'indomani della scomparsa del contagio. Le pressanti esigenze finanziarie dunque costringevano il governo ad appesantire la mano del fisco, sia sui cittadini della capitale che sugli abitanti del Dominio. Il prezzo di questa maggiore pressione fiscale venne pagato accentuando le tensioni sociali all'interno dello Stato, mettendo in ginocchio le finanze di molte comunità, creando ulteriori difficoltà a diversi settori economici che stavano da tempo scricchiolando sotto il peso della congiuntura sfavorevole. Nello stesso tempo occorreva diminuire la distanza che separava la laguna dalla Terraferma: il problema che una parte del patriziato si era posto era quello di creare dei sudditi consapevoli di condividere le sorti di uno Stato che non s'identificasse unicamente nella capitale. Venezia, insomma, e il suo patriziato dovevano scendere di qualche gradino, sfumare quel distacco fatto d'orgoglio e di superiorità che distingueva la città di San Marco dal resto dello Stato. L'estensione ai sudditi del Dominio della possibilità di sottoscrivere il debito veneziano può essere interpretato come un segnale di questa volontà.
L'imposta
Il denaro delle imposte che affluiva nei forzieri della Serenissima era il risultato di un complesso iter, che prendeva avvio dalle sale del palazzo Ducale, dove le più alte magistrature della Repubblica discutevano sull'opportunità delle tasse, sugli strumenti d'attuazione, sulle eventuali resistenze dei contribuenti; una volta decretata l'imposta, ai sudditi sarebbe spettato il dovere di pagarla. Ciò tuttavia non significa che costoro non avessero i mezzi, più o meno legittimi, di dimostrare la propria avversione, di opporre ostacoli, allo scopo di modificare le opzioni di politica tributaria attuate dal governo. L'imposta così si trova al centro dei rapporti fra governati e governanti, è la testimonianza tangibile della legittimazione del potere statale, di come viene recepito dal basso, di come viene manifestato dal gruppo dirigente. La nozione di consenso implica da un lato un problema d'ordine giuridico, di quali organi costituzionali cioè possano esercitare il diritto di tassare (accettazione dell'imposta); dall'altro si fa riferimento alla sfera sociologica dell'accettazione all'imposta, vale a dire al consenso individuale e volontario all'obbligo fiscale (132).
"Nelle occasioni estraordinarie, come sono le presenti, et in tempi travagliosi della Republica", si affermava nell'incipit della deliberazione del maggio 1617 che istituiva il campatico, l'imposta sugli affitti e la decima sui livelli, "conviene con provisioni proportionate oltre le ordinarie corrisponder alli instanti bisogni per soccorrer a quelle spese che necessariamente sono da ogn'uno conosciute, et se bene con qualche aggravio proprio e de' proprij sudditi, deve esser con sodisfatione tolerato e prontamente contribuito" (133). Il brano appena citato può fornirci qualche utile indicazione per tentare di capire come il governo marciano ponesse la questione della tassazione sui sudditi, e quali concezioni stessero alla base della tradizione tributaria veneziana.
Anzitutto conviene rilevare come venga sottolineato il particolare momento di bisogno straordinario: l'esercito sta combattendo una defatigante guerra nel Friuli orientale contro gli Arciducali, e dunque occorre ricorrere a "provisioni proportionate" per far fronte alla drammatica contingenza. I bisogni della guerra, in effetti, costituivano la principale leva che permettesse allo Stato di ricorrere all'imposizione fiscale senza tener conto di questioni giuridiche e di legittimità. La guerra rappresentava il pericolo esterno, contro il quale si potevano - e si dovevano - mobilitare le risorse della Repubblica. Tanto più che l'idea che sosteneva il ricorso alle armi - specie nel caso contro il Turco - si legava all'ideale di crociata a difesa della cristianità, ancora assai diffuso nelle coscienze del Cinque e Seicento (134). Non era forse riuscita Venezia ad ottenere sin dal Quattrocento il diritto dal pontefice di tassare il proprio clero grazie al ruolo generalmente riconosciuto di baluardo contro l'aggressività della Sublime Porta? Analogamente, allorché si stava discutendo sull'imposizione di un testatico sugli abitanti della Repubblica nel pieno del conflitto turco nel 1539, si giustificò il provvedimento "per universale beneficio et salute di tutta la christianitade" (135). Lo sforzo bellico e finanziario di Venezia assumeva così un carattere quasi sacrale; un carattere che pervadeva l'immagine dello Stato, e che rafforzava la legittimità delle richieste tributarie. "Essendo il denaro una delle principal cose che conservano li stati", si affermava in una delibera del senato circa i debitori d'imposta, "è necessario trovar modo che li debitori, quali dalla pietà et carità che cadauno è tenuto portar alla patria sua, non si moveno a far il debito loro siano astretti farlo" (136): dovere di ogni cittadino era, dunque, versare regolarmente il contributo fiscale in nome della "pietà et carità" verso la propria patria. La liceità della domanda fiscale dello Stato oramai non si appoggiava più solamente sulla necessità della difesa della comunità cristiana, ma ad essa si stava sovrapponendo sempre più una concezione diversa, che sostituiva l'elemento laico, statale, a quello religioso (137).
Il dovere verso la Serenissima era uno degli ideali indiscutibili di Giacomo Foscarini, che abbiamo già visto impegnato nella vicenda dell'ammortamento del debito pubblico. Un dovere che si esprimeva anche nel pagamento delle imposte. Dettando le sue ultime volontà nel marzo del 1595 l'anziano ed esperto patrizio veneziano, pur rammaricandosi della "grave mano" che era stata impiegata dagli estimatori per valutare le sue facoltà, ricordava di aver sempre versato regolarmente le imposte, e esortava i figli Alvise e Zuan Battista a fare altrettanto. Anzi, il padre ordinava che essi avrebbero potuto riscuotere gli interessi sulle somme depositate presso il Monte Vecchio solamente dopo aver presentato una fede dell'ufficio competente che dimostrasse il regolare pagamento delle decime e delle tanse (138). La decisione di Giacomo potrebbe comunque essere interpretata in un'altra ottica. Foscarini era un patrizio che conosceva assai bene l'ambiente della nobiltà veneziana, attraversato da invidie, da fazioni, da sospetti, da aspri antagonismi. Non pagare le imposte significava, per un uomo della sua posizione, offrire un facile pretesto agli attacchi dei suoi avversari. Evadere il fisco certo era considerato un segno di disaffezione alla Repubblica. Una delle accuse che Renier Zeno aveva scagliato contro i segretari del consiglio dei dieci nel 1628, in una violenta arringa che mirava a ridimensionare ancora una volta il ruolo istituzionale dei dieci, era proprio che sfuggivano a taluni tributi facendone ricadere il peso su altri (139). Anni addietro, nel 1580, l'avogador di comun Marco Venier poteva ordinare la persecuzione del vescovo di Spalato, accusato d'insolvenza fiscale (140). In qualche occasione i debiti d'imposta impedivano inoltre ai patrizi morosi di essere eletti alle varie cariche (141).
Un ulteriore elemento che spingeva i Veneziani a soddisfare le richieste del fisco era rappresentato dalla minaccia di sequestro dei beni dei debitori. Nel 1568, dettando al notaio le sue volontà, Nicolò Carlo q. Alvise esortava i figli a vivere "morigeratamente et cautamente" conservando quel poco di patrimonio che restava, ma "sopra il tutto" dovevano aver cura di pagare le imposte, "acciò la pena non manzi el cavedale et sia venduto quel che vale cento per cinquanta, et quel pocco gli haverò lassato non vadi in perdicione [...]. Onde prego miei carissimi comissarii et figlioli", concludeva il testatore, "vogliano attendere a questa buona opera alla quale mai gli ho mancato et ho pagato il tutto che è fino a questo tempo, come nelli libri dell'officio di Signori Governatori et mio appar" (142). Un timore, quello di Nicolò Carlo, condiviso anche da Giulia di Franceschi, vedova di messer Matteo, che imponeva all'erede di pagare le tanse e le decime "acciò li beni non ghe siano venduti" (143). E simili timori venivano manifestati da Cesare Gentili nel 1599 riguardo ad alcuni beni posseduti nel Padovano (144). Assai severa si mostrò la nobildonna Giulia Barbo, vedova di Nicolò Salamon, che nel 1595 minacciò gli eredi che si fossero mostrati fiscalmente inadempienti di perdere ogni diritto sui beni loro spettanti. Un'analoga disposizione riguardava gli enti pii beneficiati dal testamento di Zuanne da Palazzo nel 1600, i quali non avrebbero potuto usufruire dei fondi ereditati se non avessero versato regolarmente le imposte.
Paure di sequestri, timori di accuse: erano preoccupazioni legittime, condivise sia dai ceti popolari che dal patriziato. Nondimeno ulteriori elementi spingevano i testatori a preoccuparsi del dovere fiscale dei propri eredi, e quindi della tutela dei beni lasciati alle spalle. Nel 1562 il nobile Antonio Morosini q. Vido ingiungeva al fratello Nicolò, al quale sarebbero andati 400 ducati in eredità, di pagare su quella somma ogni sorta d'imposta, poiché - afferma Antonio - "mi par il dover habiando la intrada habia la sua gravezza". Erano affermazioni che riecheggiavano i solenni princìpi proclamati nelle grandi aule di palazzo Ducale: gli accertamenti tributari decisi nel 1537 - si legge in una delibera del senato - hanno il fine che "ogniuno senti il iusto peso che raggionevolmente li tocca" (145). Era sacrosanto che una parte del proprio reddito dovesse essere devoluta alla Repubblica. Era un obbligo morale, che veniva ribadito con forza nel momento in cui i contribuenti affrontavano il problema della morte e delle eventuali pendenze che rimanevano in sospeso. Allora si esprime il desiderio che i propri debiti siano assolti, e viceversa si è disposti a rinunciare ai piccoli crediti; affiorano, lì di fronte al notaio e soprattutto di fronte a se stessi e al proprio passato, ai valori morali e sociali che ne hanno intriso lo scorrere, affiorano anche sentimenti quali il dovere fiscale verso la Serenissima.
Un dovere, quello di versare una parte del proprio denaro agli esattori fiscali, che comunque non postulava la piena accettazione e sottomissione al fisco da parte dei Veneziani, e in genere dei sudditi di San Marco. La legittimità impositiva dello Stato veneziano non era ostacolata da particolari concezioni fiscali risalenti per lo più alla dottrina medievale, come in Francia e in Inghilterra per esempio, dove il sovrano doveva anzitutto trarre le risorse dal patrimonio personale e solamente in casi eccezionali poteva tassare gli abitanti del regno (146). Anche a Venezia, tuttavia, la corrente concezione tributaria poneva dei limiti all'indiscriminato ricorso a certe forme di prelievo. Nel suo trattato sulla costituzione veneziana - redatto tra gli anni Venti e Trenta del Cinquecento - il nobile Gasparo Contarini lasciava intendere che il nerbo delle rendite della Serenissima dovesse essere costituito dalle imposte daziarie, mentre solo in caso di bisogno si dovevano decretare le decime e le tanse (147). E le ritrosie del gruppo dirigente marciano ad impiegare in modo massiccio l'imposizione diretta - almeno sino all'epoca in cui scriveva Contarini - testimoniano che si trattava di un'opinione diffusa fra i patrizi.
Da parte dei sudditi emergevano ovviamente con reiterata tenacia proteste e suppliche contro eventuali nuove imposte. Il già ricordato Zuan Francesco Priuli ricordava come i decreti di nuove gravezze innescassero la ferma opposizione di tutte le città: "Et tanto è il poner gravezza con contese" rimarcava, "quanto è l'invitar ambasciatori che si vengano à opponer" (148). Il principale timore riguardava il carattere ordinario che il tributo potesse assumere una volta terminata l'occasione dell'imposizione. In una scrittura rivolta al governo Vicenza, opponendosi all'istituzione della decima sui livelli nel 1625, enumerava una lugubre serie di tasse concepite in tempo di guerra e successivamente "nella pace partorite" (149). Il dazio sulle eredità "arreca afflittione sopra afflittione nel cuore dei popoli" lamenta Brescia nei primi anni Venti del Seicento, "et fa temere che per essere posto in perpetuo la Repubblica miri più oltre che a sovvenire le presenti occorrenze" (150). Nuovi dazi e gravezze offrivano l'opportunità ai sudditi di rievocare i tempi passati, allorché l'aggravio fiscale pareva assai leggero e oggetto di trattative con Venezia. Era un ritornello, quello dei tempi andati, che veniva impiegato per contrastare le "novità" fiscali che andavano a sconvolgere la tradizione; un'idea, quella della consuetudine, che forniva ai sudditi un'indiscutibile argomento per tentare di incidere sulle decisioni governative. Al di là del carattere strumentale, tuttavia, il principio della tradizione permeava altresì gli atteggiamenti dei governanti veneziani. Il fatto che nei proemi dei decreti istitutivi di nuove imposte si sottolineasse il carattere provvisorio del tributo rifletteva, oltre che la preoccupazione di far accettare il provvedimento ai contribuenti, anche una più vasta concezione tributaria del gruppo di governo; un gruppo che, per certi versi, condivideva coi governati la medesima visione delle "novità" fiscali.
Non bisogna dimenticare, inoltre, che fra i banchi del senato sedevano numerosi patrizi che avevano investito ingenti somme nelle campagne della Terraferma, nei campi e nelle bonifiche di vaste aree, nelle manifatture e nei prestiti, concessi sia ai piccoli contadini che agli orgogliosi nobili del Dominio. Le resistenze ad un certo tipo d'imposta, dunque, emergevano anzitutto nell'ambito del ceto dirigente veneziano. La vicenda del campatico è esemplare. Il Cinquecento si era aperto con l'imposizione di un campatico nel 1501. Un provvedimento, questo, che aveva suscitato le ire e i contrasti dei nobili sudditi. Contrasti che, di fatto, avevano notevolmente ridimensionato l'efficacia del tributo (151). Durante la guerra turca del 1537-40 - come abbiamo visto - si era riaffacciata la proposta di una nuova imposizione sulla proprietà fondiaria in Terraferma, ma il vivo ricordo del fallimento del precedente campatico aveva consigliato di desistere dall'intento. E ancora nel 1568 un ulteriore tentativo era sfumato. L'anno dopo il provvedimento sembrava finalmente aver superato la fase propositiva in senato. A luglio i pregadi decidevano l'istituzione della gravezza "sopra tutte le terre del Dominio nostro": tuttavia il provvedimento non ebbe effetto. Il decreto infatti era passato con uno scarto di appena nove voti: troppo pochi, come ebbe a rilevare il nunzio apostolico, perché il campatico potesse essere realizzato (152). Nel pieno della guerra di Cipro riaffiorò la proposta: tuttavia le resistenze di una parte del patriziato e la manifesta ostilità delle città soggette fecero in modo che il campatico venisse commutato in un sussidio straordinario di 300.000 ducati sulla Terraferma. È il caso di domandarsi se i dirigenti veneziani credessero realmente nell'attuazione del campatico: l'esperienza del 1501 era stata fallimentare, ed aveva innescato pericolose tensioni fra il governo e le élites del Dominio. Si potrebbe ritenere allora che il campatico, o un'analoga forma di prelievo tributario, costituisse una sorta di minaccia da porre sul piatto della bilancia dell'aspra contrattazione fra il governo e i contribuenti. Si giocherebbe, insomma, una specie di commedia - per usare un termine di Jean Meuvret (153) - che vede come protagonisti il governo da una parte, che chiede molto più di quel che sa di poter ottenere, e i corpi locali dall'altra, che offrono assai meno di quel che potrebbero. Alla fine domanda e offerta s'incontrano in un compromesso, che soddisfa entrambi i contendenti. Il sussidio straordinario, in questo caso, era il frutto di queste aspre contrattazioni: un tributo che assicurava un notevole gettito alle casse statali e che, soprattutto, non andava ad incidere sui rapporti fiscali fra città e contadi, fra proprietari fondiari - sudditi e Veneziani - e contadini.
Nel 1617, come abbiamo visto, il campatico venne imposto sui contribuenti veneziani, e negli anni a seguire venne decretato in varie occasioni - mezzo nel 1619, e ancora un altro nel 1626 - sinché nel 1636 fu esteso anche ai proprietari della Terraferma (154). Nonostante l'avversione suscitata da questo tipo di tassa, il denaro riscosso fu relativamente considerevole. Su un gettito teorico di circa 144.000 ducati valutato nel 1617 la somma raccolta raggiunse i 101.047 ducati, vale a dire il 70% dell'intero ammontare. Il mezzo campatico del 1619 assicurò un'entrata di 41.026 ducati (57% del totale); e nel 1626 il denaro versato a titolo del campatico costituì il 61% della cifra globale (92.512 ducati su 151.622) (155). Si tratta di percentuali che sostanzialmente non si discostano da altre riguardanti le gravezze imposte ai Veneziani. Fra il 1555 e il '62, per esempio, i governatori alle entrate riscossero il 56% e il 66,5% del denaro previsto rispettivamente per le decime e le tanse (156). Dal 1555 al 1605 i cittadini veronesi contribuirono alla quasi totalità del sussidio ordinario nel giro di due anni dalla data di ogni imposizione (157). Il campatico, dunque, sembrerebbe essere stato accettato dai proprietari veneziani: un'accettazione che anzitutto si era manifestata in seno al gruppo dirigente, che era riuscito a far approvare il provvedimento e in seguito a renderlo attuabile. Un'attuazione che peraltro forse si basava anche su un peso tributario che appariva abbastanza sopportabile. Il campatico esteso alla Terraferma rappresenta un ulteriore passo in avanti verso un nuovo sistema fiscale integrato fra la capitale e il Dominio di terra. Occorre sottolineare che dapprima il campatico venne imposto sui "fuochi veneti" e poi successivamente decretato sui contribuenti della Terraferma. Sembrerebbe emergere una concezione fiscale che vedeva Venezia giocare quel ruolo che nelle monarchie era attribuito al patrimonio del re. Se il sovrano, infatti, doveva prima di tutto attingere alle risorse del demanio, nel caso veneziano si potrebbe ipotizzare un'analogia con la capitale, i cui contribuenti solitamente sperimentano in anticipo nuove tassazioni, in seguito allargate alla Terraferma. Ciò legittimava il governo a chiedere ai sudditi del Dominio il loro contributo fiscale ed offriva una valida risposta alle proteste dei corpi locali. Un'ulteriore considerazione sollecitata dal campatico del 1636 riguarda in generale i rapporti tra Venezia e il suo Dominio. L'estensione di questa gravezza ai contribuenti "esteri" implicava una maggior partecipazione di questi al sostentamento della cosa pubblica; un segno simbolicamente importante dell'accresciuto coinvolgimento della Terraferma. Un coinvolgimento che, certo, significava un aumento dell'onere finanziario, una maggior pressione fiscale, ma che sottintendeva un diverso rapporto con Venezia. La crescente quantità di denaro del Dominio che affluiva nei forzieri dello Stato costringeva il governo a prestar particolare orecchio alle voci che si levavano dai territori soggetti, e nello stesso tempo rafforzava le richieste provenienti dalle città e dalle comunità rurali della Repubblica. Stavano emergendo segni, sia in campo tributario (campatico) che finanziario (debito pubblico), che testimoniavano dello svolgersi di profondi mutamenti all'interno della Repubblica di Venezia: mutamenti che coinvolgevano il gruppo dirigente e le scelte di politica fiscale, gli equilibri politici ed economici fra la capitale e il Dominio, alla ricerca di una sofferta e difficile ristrutturazione delle svariate componenti economiche e sociali dello Stato veneziano nel primo Seicento.
Dal banco privato al banco pubblico
Nella Venezia rinascimentale i banchi locali erano visti come strumenti per agevolare le operazioni di pagamento nella piazza mercantile. In un periodo in cui le monete metalliche non facilitavano certamente le transazioni, i servizi offerti dai banchieri offrivano l'opportunità di effettuare rapidi e comodi pagamenti. Il meccanismo era assai semplice. Il banchiere accettava in deposito una certa somma di denaro da un mercante, così da costituire un vero e proprio conto corrente; all'occorrenza il depositante o un suo agente si presentava presso il banchiere e gli ordinava di trasferire, tramite una semplice operazione di girata, una quota del deposito a favore del conto di un altro mercante. Versamenti e riscossioni, dunque, si effettuavano a Venezia per mezzo di agevoli trasferimenti contabili in assenza di ingenti quantità di moneta. Questi banchi di scritta - così denominati poiché avevano la funzione specifica di registrare il movimento di denaro nei registri - erano gestiti da banchieri privati, e costituivano uno dei cardini dei meccanismi finanziari della piazza veneziana. Infatti questi banchi, oltre ad accettare i depositi esercitavano una funzione di controllo sulla circolazione monetaria. Le numerose specie monetarie che circolavano a Rialto, d'oro, d'argento, di rame, monete veneziane e straniere, corrotte e di giusto peso, nonché le oscillazioni del rapporto fra oro e argento rendevano il mercato estremamente instabile. Attraverso le operazioni effettuate nei banchi di scritta le diverse valute trovavano una comune espressione nel ducato di banco, un'unità di conto che rappresentava un ideale comun denominatore fra le varie valute (158).
In linea teorica, dunque, i banchi di scritta avrebbero dovuto limitare le proprie operazioni alle girate e alla valutazione delle specie monetarie: tuttavia spesso i banchieri oltrepassavano i limiti imposti dalla normativa, e lo stesso governo, in particolari momenti, richiedeva loro servizi di credito. In effetti, sebbene dovesse sussistere un'esatta equivalenza tra il denaro depositato e il valore delle transazioni registrate presso i banchi, era usuale che il banchiere approfittasse della disponibilità di denaro per effettuare investimenti per conto proprio, contando sul fatto che i depositanti non avrebbero richiesto i loro denari. Ma bastava la voce che il banchiere fosse stato colpito da qualche evento sfortunato (perdita di merci, fallimento di compagnie mercantili a lui vicine, decesso di qualche protettore) perché una moltitudine di creditori si accalcasse davanti alla sua tavola reclamando a gran voce i propri depositi. Nella gran parte dei casi non rimaneva altro che dichiarare bancarotta e affidarsi alla magistratura per la liquidazione dei debiti.
Se durante il Quattrocento sino al periodo delle guerre d'Italia il governo richiese vari servizi ai banchieri veneziani, all'indomani della guerra turca del 1537-40 il coinvolgimento dei banchieri nei meccanismi della finanza statale si era notevolmente ridotto. I banchi di Rialto agli inizi del Cinquecento avevano fornito vari prestiti al governo: tra il 10 luglio e il 5 settembre 1510 i Banchi Pisani e Capello-Vendramin anticiparono almeno 30.000 ducati "per la satisfaction" dei mercenari svizzeri e "per far zente d'arme et fanti"; dei 13.500 ducati inviati al provveditore Capello nel marzo del 1511, 8.000 furono prestati dal Banco Capello-Vendramin e 5.500 da quello Priuli. Gerolamo Priuli, in qualità di titolare dell'omonimo banco, si "atrovava sempre in li consulti et deliberatione facevanno li Padri Veneti", annota nel suo diario, "perché haveanno grande de bisogno de l'opera mia per essere serviti molte volte di danari in uno puncto et di nocte, che ochorevano li bisogni grandi et importantissimi, come achade in tempo di guere" (159). Si trattava comunque di prestiti a breve termine che, solitamente, venivano garantiti dalle entrate tributarie dello Stato e che non minavano la situazione finanziaria del banco. Una ben altra situazione si riscontra dal terzo decennio del secolo: dalla documentazione del consiglio dei dieci e del senato non emergono significativi rapporti con i banchieri locali. Probabilmente l'apertura dei depositi in Zecca permetteva di finanziare il conflitto evitando il ricorso al denaro dei banchieri; tuttavia c'è da chiedersi se l'istituzione del debito pubblico in Zecca possa intendersi come la soluzione trovata dai governanti per superare i limiti denunciati dal sistema del prestito bancario. Far dipendere le sorti di una parte della finanza pubblica da pochi banchieri non rientrava certo nella mentalità del patriziato; gli esempi che i dirigenti avevano davanti ai loro occhi erano alquanto significativi. I destini della politica imperiale di Carlo V apparivano strettamente legati ai maneggi dei banchieri della Germania meridionale prima, e successivamente ai Genovesi. Sino alla metà del secolo i finanzieri fiorentini sostennero le finanze del re di Francia (160). Erano intrecci, quelli fra la grande finanza e la politica, pericolosi per entrambi i protagonisti: la crisi di uno avrebbe trascinato nel baratro anche l'altro. Ma non si trattava solo di rischi - più o meno calcolati -; il potere del denaro s'insinuava nei consigli di Stato, nelle corti, creava sensi d'obbligo e forti dipendenze; l'oro abbagliava e creava miraggi. Il potere della politica, dal canto suo, favoriva le ascese finanziarie, assecondava i desideri dei prestatori, appoggiava la formazione di gruppi d'interesse. Dalle diverse sedi gli ambasciatori veneziani riferivano della potenza dei Fugger, dei Welser, dei Lomellini, degli Strozzi; erano notizie che spingevano a meditare sul ruolo dei banchieri nella finanza dello Stato, e sui pericoli che la Repubblica poteva correre affidandosi al facile denaro messo a disposizione dai prestatori. Accanto a queste preoccupazioni d'ordine politico occorre altresì rilevare che il limitato disavanzo finanziario registrato alla fine delle prime guerre d'Italia può aver favorito l'allentamento dei rapporti fra la Serenissima Signoria e i banchieri lagunari.
L'interruzione degli stretti legami col governo tuttavia non scoraggiò i patrizi veneziani ad impegnarsi nei banchi di scritta. Nel 1530 Marin Sanudo registra la presenza di tre Banchi, gestiti dai nobili Bernardo, Capello e Priuli (161). Nel 1537 Silvano Capello e figli sono costretti a por termine all'attività e a chiedere al senato un anno di tempo per ripagare i creditori per le somme oltre i 50 ducati (162). Probabilmente il conflitto aveva inferto un duro colpo alle attività dei Capello, e l'accentuata domanda tributaria dello Stato aveva costretto i depositanti a ritirare il denaro dal Banco, provocando così la bancarotta dell'azienda. E forse si collega alla congiuntura bellica appena trascorsa anche il fallimento del Banco Priuli nell'ottobre del 1541 (163). Dopo qualche anno il numero dei banchi a Rialto sembra ridursi notevolmente, tanto che nel 1545 si dice che ne funzioni solamente uno (164). Nel volgere di un ventennio la situazione appare comunque mutata: nella piazza sono in attività i cinque Banchi di Giacomo Foscarini, Angelo Sanudo, Vettor Correr e fratelli, Andrea Dolfin e infine di Vettor Pisani con Gerolamo Tiepolo (165). Vien fatto di ritenere che il notevole numero di banchi operanti nel medesimo periodo sia da mettere in relazione all'accentuata domanda di servizi che il mercato veneziano richiedeva. L'arco del trentennio fra la fine della guerra del 1537 e Lepanto fu caratterizzato da una discreta vitalità della piazza veneziana: attraverso il porto transitavano numerosi navigli carichi di merci europee e levantine; la popolazione cittadina registrava un sicuro incremento; e i molti mercanti, veneziani e stranieri, necessitavano dell'opera dei banchieri in un quadro di crescita economica.
Una prosperità, questa, che certo non impediva ai banchieri di impegnarsi in azzardati investimenti rischiando i capitali dei depositanti; oppure di smettere l'attività prima d'incappare nel quasi immancabile rovescio finanziario. Così, il 22 novembre 1568 Giacomo Foscarini "fece la mostra d'oro et saldò il banco suo" (166) al suono dei pifferi, acquisendo "grande honorevolezza" presso la piazza (167). Di lì a poco tempo sarebbe stato seguito dai fratelli Correr, che riusciranno a liquidare il Banco restituendo tutto il capitale ai depositanti (168). Si tratterà di due casi fortunati: l'atmosfera oramai non sembrava più propizia ai banchieri. I Banchi Dolfin, Correr e Pisani-Tiepolo avevano fatto ricorso nel 1567 ad un prestito statale a breve termine di 40.000 ducati ciascuno (169). Nel 1568 il senato aveva deciso che i banchi esistenti avrebbero dovuto cessare l'attività entro tre anni; e nel giro di breve tempo si verificarono gravi fallimenti. Nel febbraio del 1570 il Banco di Angelo Sanudo, istituito appena quattro anni prima, chiudeva i battenti; la stessa sorte sarà condivisa da Andrea Dolfin e figli, che nell'estate del medesimo anno saranno costretti a dichiarar bancarotta (170). Il fallimento dei Dolfin fece notevole - scalpore in città poiché era un banco in attività da oltre vent'anni, e quindi - scrive un cronista "era in grandissimo credito e faceva pur assai facende"; anche il nunzio pontificio sottolineò il clamore della notizia: "è tutta sottosopra questa città essendovi infiniti interessati et in grosso" (171).
I Dolfin, pressati dai creditori, si rivolsero al senato per ottenere facilitazioni per far fronte agli impegni. Nella supplica rivolta alla Signoria esposero i motivi della crisi del loro Banco. Oltre 200.000 ducati erano stati prelevati in pochissimi giorni dai depositi, e le cause erano "ad ognuno chiare et manifeste": certo, la guerra col Turco aveva colpito i traffici marittimi, provocando una brusca interruzione dei commerci, ma soprattutto - sottolineavano i nobili Dolfin - i loro clienti si eran affrettati a ritirare il denaro attirati dall'alto tasso d'interesse offerto dai titoli del debito pubblico in Zecca (172). Conviene rilevare che questa giustificazione probabilmente non aveva il solo scopo di creare fra i senatori una sorta di complesso di colpa, in modo da accogliere le richieste dei Dolfin. In effetti l'accensione di un deposito in Zecca al 7%, decretato a fine maggio, suscitò una vera e propria corsa da parte dei sottoscrittori: la somma raccolta tra il giugno 1570 e il 6 marzo 1571 raggiunse i 468.190 ducati, e ben 408.181 (87,2%) furono raccolti in contanti (173). Il 28 luglio 1570 i dieci dichiaravano che il deposito di 100.000 ducati al 7% istituito il 20 giugno aveva già trovato collocazione fra i sottoscrittori (174). Se agli inizi del secolo i banchi avevano denunciato una crisi anche in seguito alla forte pressione fiscale esercitata sui depositanti, costretti a trovare denaro liquido per pagare le imposte, dopo qualche decennio è ancora lo Stato che ne aggrava le difficoltà, offrendo però un'alternativa all'impiego del denaro privato in tempo di guerra.
Com'era consuetudine, iniziarono le pratiche per la valutazione della ricchezza familiare dei Dolfin. La situazione patrimoniale prospettata da Andrea era la seguente:
A questo si potevano aggiungere 25.000 ducati forniti dal vescovo di Torcello e altri 40.000 a titolo di garanzie varie, per un ammontare quindi di 481.000 ducati (175). Il quadro fornito da Andrea Dolfin, al di là dello scopo di rassicurare i senatori e i creditori, assume un certo interesse per comprendere i diversi settori d'attività di un banchiere. I capitali investiti nel commercio, sebbene non chiaramente specificati, sembrano costituire un elemento importante della strategia economica familiare; al secondo posto si situano gli edifici e le terre, mentre i denari investiti nel credito fondiario rappresentano oltre il triplo del valore dei titoli del debito pubblico basato sui Monti. Probabilmente il forte coinvolgimento nelle imprese commerciali aveva fatto ritenere ai clienti del Banco Dolfin che prima o poi sarebbe giunto il dissesto con la guerra. Cause non diverse erano state alla base del fallimento di Angelo Sanudo. Le nubi che preannunciavano il conflitto con la Sublime Porta avevano indotto i depositanti a ritirare il denaro affidato al banchiere, che si sapeva aver investito grandi somme nei traffici levantini. Spezie, tessuti e preziosi a nome di Angelo si trovavano a Costantinopoli presso il fratello Marco; e impegni commerciali erano stati presi nel "negotio di Cipro". Certo, il Banco poteva vantare numerosi crediti, capitali nel debito statale, livelli, affitti di case, edifici e terre, ma ciò non era ritenuto sufficiente per assicurare la fiducia dei clienti (176). La sfiducia investì anche Andrea Dolfin e i suoi figli. Il 21 luglio 1571, ad un anno dalla bancarotta, il senato emanava l'ordine di arrestarli, di sequestrare tutti i loro beni e di porli presso la Zecca; e un mese dopo venivano privati della dignità nobiliare, non avendo soddisfatto i creditori (177). Ad un anno di distanza il numero di coloro che vantavano crediti dai Dolfin ammontava a 325: costoro erano rappresentati da Nicolò Franceschi, da Giacomo Lodovici e dagli eredi di Lorenzo Strozzi (178). E verosimile che Franceschi appartenesse al ceto cittadino, ad una famiglia che accanto alla pratica mercantile era votata al servizio della burocrazia statale. Giacomo Lodovici è un nome assai noto dell'ambiente realtino: a metà secolo era impegnato nei commerci nel Levante e nella Germania meridionale, ed è un assiduo frequentatore degli studi notarili veneziani per stipulare contratti, assicurazioni, livelli, acquisti fondiari (179). Gli eredi di Lorenzo Strozzi portavano un nome altisonante: l'azienda fiorentina, accanto alle imprese commerciali, aveva numerosi e cospicui interessi soprattutto nel mercato dei cambi.
I rappresentanti dei clienti del banco erano figure di eminenti mercanti; tuttavia non sarebbe corretto ritenere che il denaro depositato presso i banchieri appartenesse unicamente a questi operatori economici. Era uso corrente fra i Veneziani, infatti, affidare ad un banco le doti per le figlie (180). E lecito supporre che una certa quota dei circa 221.000 ducati dichiarati dal Banco Pisani-Tiepolo nel 1584 a titolo di "partite conditionate" fosse costituita da doti (181). Il nunzio di Padova, poi, si serviva dei Banchi Sanudo e Dolfin per effettuare depositi e pagamenti a nome della città (182). Anche taluni uffici finanziari e amministrativi dello Stato utilizzavano le possibilità offerte dai banchi di scritta. Francesco Roncadelli, che aveva assunto nel 1570 il partito del sale per Milano, risultava aver depositato presso il Banco Dolfin la cauzione a favore dei provveditori al sal; e nel 1579 i governatori alle entrate avevano un proprio conto iscritto nei registri del Banco Pisani-Tiepolo (183). Numerosi e diversi fra loro, per censo e per collocazione sociale, erano dunque quelli che affidavano il proprio denaro ai banchieri. È significativo che il senato, allorché decise l'istituzione di un banco pubblico, accennasse ai fallimenti bancari e all'"infinito disturbo di tanti poveri pupilli e vedove, e gente miserabile", a sottolineare l'estesa area sociale che il banco avrebbe servito (184).
All'indomani della guerra di Cipro l'unico banco in funzione a Venezia risultava quello a nome Pisani-Tiepolo, che nel frattempo aveva ottenuto una proroga, in seguito rinnovata, per continuare l'attività, grazie ad una situazione patrimoniale giudicata discreta (185). Tuttavia fra i patrizi stava crescendo sempre più l'ostilità nei confronti dei banchi di scritta; e non è un caso che, nel 1577, la richiesta dei banchieri di ritardare la chiusura dell'azienda fosse stata accolta dal consiglio dei dieci solamente alla terza votazione (186). Un anno dopo il senato respingeva la proposta di Alessandro Querini q. Marc'Antonio di aprire, vista la generale crescita dei "negoti" e commerci in città, un nuovo banco di scritta nonostante avesse offerto una garanzia di 100.000 ducati (187). Nel 1584 giunse anche l'ora del Banco Pisani-Tiepolo. La notizia di un rovescio del mercante pisano Andrea dell'Oste, che si sapeva in affari col Banco veneziano, seminò il panico in città, e il Banco fu costretto a dichiarare la bancarotta. Correva voce che il fallimento avesse comportato una somma superiore ad un milione di ducati (188). Con la chiusura del prestigioso Banco Pisani-Tiepolo si chiude l'epoca dei banchi privati a Venezia; il gruppo dirigente infatti appare fermamente deciso a vietare il sorgere di nuovi banchi di scritta. Poco dopo la bancarotta dell'ultimo banco veneziano il senato decise che eventuali denari potessero essere depositati in uno scrigno nella Zecca; e ciò testimoniava che si stava oramai compiendo il passaggio dai banchi privati al banco gestito dallo Stato.
C'è da chiedersi se l'atteggiamento avverso dei senatori nei confronti dei banchi, al di là dei motivi politici ed economici, sia il segno di un mutamento della considerazione sociale dei banchieri privati. La nascita di un banco di scritta assumeva un particolare significato nella vita cittadina; un significato che, nel cerimoniale seguito, oltrepassava il valore di un mero evento finanziario. Allorché nel 1559 Vettor Pisani e Gerolamo Tiepolo diedero vita al loro Banco l'avvenimento fu celebrato secondo certe regole che implicavano il coinvolgimento delle intere famiglie, della piazza di mercanti, nonché della comunità cittadina. Dopo aver ottenuto la licenza dal senato i titolari - racconta un cronista - "feceno mostra de monede d'oro e d'arzento in gran quantità, et feceno cantar una solenne messa in chiesa de San Zuan de Rialto, dove fureno tutti li parenti vestidi de cremesin, e feceno uno sontuoso desinar a più di 500 persone, parenti et mercanti, come si osserva in simil occasioni" (189). Conviene rilevare alcuni interessanti elementi che emergono da questa descrizione. Anzitutto i titolari ostentano un certo quantitativo di monete pregiate, a sottolineare le solide basi finanziarie della nuova impresa. La celebrazione della messa a Rialto - dove si svolgeva l'attività dei banchieri - probabilmente stava a dimostrare i buoni propositi dei banchieri e la solennità del momento; costoro inoltre erano accompagnati da tutti i parenti, che manifestavano così l'appoggio e la partecipazione della casata alle sorti dell'azienda. Da notare che i vestiti indossati nell'occasione erano di color scarlatto: un colore che sottolineava la solennità del momento e che rivestiva un particolare significato nella simbologia veneziana. Di scarlatto vestivano i ventidue patrizi che vegliavano sul feretro del doge, a significare che, nonostante la morte della massima autorità dello Stato, la Signoria era immortale. Il banchetto poi rappresentava il culmine delle cerimonie. Il banchetto costituisce il classico momento pubblico, dove i banchieri, i loro familiari, gli amici e i mercanti si ritrovavano, dove si rafforzavano le relazioni e s'intrecciavano nuovi reciproci legami. Chi partecipava a quel convivio dimostrava l'appoggio all'impresa. Per i nuovi banchieri far sedere alla propria tavola un influente patrizio o l'agente di una prestigiosa casa commerciale assumeva la medesima importanza, se non superiore, della mostra dei pregiati ducati d'oro e delle grosse monete d'argento.
Il banco di scritta, dunque, non solo si trovava al centro della complessa strategia economica della famiglia, ma veniva collocato, anche simbolicamente, nel quadro delle relazioni fra le parentele, gli operatori della piazza, il gruppo dirigente e la città. Probabilmente Giacomo Foscarini fu in grado di por termine all'attività del suo Banco "con grande honorevolezza" proprio grazie agli stretti legami con eminenti figure di Rialto e di palazzo Ducale. Fra i garanti del suo Banco figurano, fra gli altri, anche Giacomo e Alvise Ragazzoni, che portano un nome assai autorevole fra i mercanti, e che sono uniti da una profonda amicizia con Foscarini (190). Uno degli avversari più accesi di Giacomo Foscarini si era dimostrato il nobile Giulio Contarini, che nel 1565, in un'accesa discussione sui banchi privati, gli rimproverò di godere di certe agevolazioni concesse dal senato. Non era difficile immaginare che Contarini volesse così sottintendere gli appoggi goduti dal banchiere e dalla sua famiglia tra le file dei senatori (191).
Giulio Contarini nell'aspra arringa contro i banchieri voleva evidenziare - a veder suo il loro ruolo nefasto nel mercato monetario veneziano. Erano i banchieri che speculavano sulle valute, approfittando della possibilità di sfruttare le scritture di banco; ed erano ancora loro a diffondere la cattiva moneta incettando quella buona; ed inoltre non si facevano scrupolo di accettare le buone monete ad un prezzo e redistribuirle ad un costo assai maggiore. "Voi tutti banchieri", tuonava Giulio Contarini, "sete stati causa de incarognar questa città di questa sorte di valute, et non volete che hora si possa parlar di remediar alli inconvenienti introdotti per voi, ma volete con il sangue de poveri cittadini acquistarvi le possessioni a 80 et 100 ducati il campo, et farvi delle intrade per vie illicite, et che il principe sia fauttore di queste vostre operationi". Erano toni assai duri, quelli del patrizio veneziano; una severità che farebbe intendere quanto i banchieri stessero scendendo nella scala della considerazione sociale. Tuttavia sarebbe un errore prestar orecchio solo a questi giudizi negativi: accanto alle opinioni avverse alla professione bancaria troviamo pareri in senso nettamente opposto. Ancora nel 1623 alcuni Veneziani ricordano che gli avi di Zuanne e di Pietro Veruzzi erano stati banchieri "e sempre hanno avuto nome honoratissimo" (192). Del resto gli stessi dirigenti ammettevano che dei banchi di scritta efficienti davano lustro e "honorevolezza" alla città, oltre che assicurare un comodo strumento finanziario ai "negoti della mercatura". I motivi che spinsero il senato a concludere definitivamente l'epoca dei banchi privati vanno ricondotti perciò a questioni squisitamente economiche piuttosto che ad argomenti connessi al sistema di valori vigente a Venezia. I patrizi giunsero alla conclusione, all'indomani del rovinoso fallimento del Banco Pisani-Tiepolo, che solo un banco gestito direttamente dallo Stato avrebbe potuto evitare tutti quei "disturbi, disordini, e confusioni" che derivavano alla piazza dall'instabilità degli istituti bancari privati.
Il patriziato, ad ogni modo, si trovò ancora diviso sull'opportunità d'istituire un banco pubblico. Il 28 dicembre 1584 la proposta venne approvata con una maggioranza risicata, e appena dopo tre mesi di vita il banco statale venne chiuso in seguito alla scoperta di alcuni abusi (193). Già negli anni precedenti si erano levate voci in senato per l'istituzione di un banco statale: voci lontane, come quelle del 1356 e 1374, e voci più recenti, come quelle del 1565 (194). Ora sembrava che la proposta dovesse seguire il destino delle precedenti. Vi erano ancora numerose resistenze fra quei senatori che ritenevano che lo Stato non dovesse ingerirsi con un proprio banco nella vita della piazza commerciale. Tuttavia le ragioni del mercato alla fine prevalsero sulle perplessità: l'assenza di un organo regolatore dei pagamenti e delle valute minacciava di provocare la "ruina dei negotii" e di gettare la piazza nella confusione più disastrosa. Il senato, così, l'11 aprile 1587 approvava l'istituzione di un banco pubblico, che prese il nome di Banco della Piazza di Rialto. La gestione dell'istituto venne affidata ad un governatore privato, dietro presentazione di idonee garanzie, che rimaneva in carica per un periodo definito. Si trattava di una sorta di compromesso tra le istanze - per così dire - liberiste e le esigenze di controllo statale propugnate da una parte dei patrizi.
In sostanza il nuovo Banco assunse le funzioni che sino allora erano state svolte dai banchi privati. Accoglieva i depositi dei mercanti e svolgeva le consuete operazioni di giro tra le partite; la novità era data dal fatto che questa attività fosse tutelata e garantita in prima persona dallo Stato. Lo stretto controllo esercitato sull'istituzione probabilmente rassicurava i depositanti, tanto più che la Signoria non ricorse al Banco quale strumento creditizio nel quadro della finanza pubblica. Un ulteriore elemento di fiducia fu rappresentato dalla cospicua somma di denaro che lo Stato stava raccogliendo nel Deposito grande e che offriva una tranquillizzante immagine della capacità finanziaria della Repubblica. I primi anni di vita del Banco della Piazza di Rialto furono caratterizzati da un notevole fervore oltre che da esiti soddisfacenti: almeno sino agli anni Novanta l'istituto riuscì ad assicurare con la propria partita di banco un valido strumento monetario, effettuando le operazioni in buona valuta e di giusto peso. Nondimeno alle soglie del secolo successivo i torbidi monetari costrinsero il Banco ad accettare anche monete scadenti (195). Il ruolo nel mercato monetario veneziano non deve comunque far dimenticare che il Banco svolse una funzione importante anche nel settore dei traffici cambiari, poiché dal 1593 il senato decretò che i pagamenti delle lettere di cambio si effettuassero tramite il Banco pubblico. I forzieri dell'istituto inoltre rappresentavano una sede sicura per il denaro di quei Veneziani che non sapevano - o non volevano - investirlo. In un periodo in cui l'offerta dei titoli del debito pubblico in Zecca si - contrasse salvo i particolari momenti di crisi politico-militari -, una parte dei risparmiatori probabilmente preferì collocare i propri gruzzoli al sicuro, pur senza riceverne interesse.
Nel 1618 l'ammontare del denaro depositato presso il Banco pubblico veneziano raggiunse il milione e settecentomila ducati (196). Una cifra senza dubbio ragguardevole, che corrispondeva pressappoco alla metà delle entrate statali di un anno. Forse quell'anno segnò il culmine dell'attività del Banco; di lì a poco, infatti, il senato affiancherà al vecchio istituto il nuovo Banco giro, che si accollerà ulteriori funzioni e che nel volger di breve tempo assumerà una crescente importanza. Nel 1630 nelle casse del Banco della Piazza di Rialto rimanevano poche decine di migliaia di ducati appartenenti a persone "che per sola sicurezza et non per negotio quivi li tengono" (197). Poco sangue per un corpo agonizzante. Cosicché la soppressione del vecchio Banco pubblico, decretata nel 1637, apparve la sanzione ultima di un declino provocato dalla stessa politica finanziaria veneziana.
Il Banco giro in effetti non venne concepito come un doppione del Banco della Piazza di Rialto. Inizialmente a quest'ultimo erano riservate le funzioni specifiche dei vecchi banchi di scritta mentre al primo veniva assegnata la gestione dei rapporti finanziari tra lo Stato e i vari fornitori. Il Banco giro nacque proprio in occasione di un debito contratto nei confronti di Zuanne Vendramin per la consegna di un ingente quantitativo di paste metalliche destinate alla Zecca. Lo stesso Vendramin chiese che una parte del suo credito venisse registrata in una partita presso il Banco della Piazza oppure presso "un nuovo giro". Del resto questo sistema di pagamento era già stato impiegato in precedenza: l'officio del giro delle biave durante la seconda metà del Cinquecento s'interessò del giro dei debiti contratti verso i mercanti di grani (198).
Anche il Banco giro sorse da una contingenza ma, a differenza degli altri corrispettivi, ebbe una vita assai più lunga. Dopo il nome di Vendramin numerosi altri mercanti furono iscritti nei registri dei creditori del nuovo Banco. Il primo giugno 1619, a pochi giorni dall'apertura, il mercante fiammingo Pietro Vogher richiese che 12.000 ducati del suo credito complessivo di 25.000 per una fornitura di rame venissero accreditati nel Banco giro (199). Dopo qualche mese il senato poteva affermare che il nuovo istituto era sorto "con sodisfatione universale della piazza", e decideva di aumentare l'assegnazione destinata al suo finanziamento(200). È chiaro, dunque, che lo Stato si stava dotando di un organo creditizio a breve termine che gli consentiva di soddisfare i numerosi fornitori iscrivendo le loro partite nel Banco e consentendo la libera circolazione del titolo di credito. Il debito contratto dallo Stato verso il Banco si aggirò attorno ai 470.000 ducati nel 1620, si accrebbe con una certa regolarità sino al 1624, quando oltrepassò gli 800.000 ducati; l'anno successivo l'ammontare raddoppiò bruscamente in connessione con la guerra, e nel 1626 il debito sfiorò i due milioni; in seguito l'espansione del passivo crebbe sino ad arrivare oltre i 2.600.000 nel giugno del 1630, durante la terribile congiuntura di guerra e peste (201). Lo Stato non fece ricorso alle scritture del Banco unicamente per soddisfare i fornitori: nel 1629 fu deciso che gli interessi erogati dalla Zecca potessero essere pagati presso il Banco giro; analogamente, una parte delle serie di titoli di stato venne iscritta nei registri dell'istituto; e infine apparve oramai agevole che anche una quota delle imposte potesse essere versata tramite la partita di banco (202). Occorre comunque rilevare che l'area del debito fluttuante promossa dal Banco giro fu mantenuta dalle autorità in limiti abbastanza circoscritti. "Era meglio accrescer il banco del ziro a 2 e 3 millioni che aprir li depositi [in Zecca] alle 5 e 12% con paga d'interesse", si legge in un appunto finanziario del 1625, "perché li depositi hanno destrutto la piazza et li negotii" (203). Probabilmente l'estensore di questo giudizio guardava con preoccupazione alla scarsità di buon circolante che colpiva Venezia, e ne attribuiva la causa al costante flusso di denaro che si dirigeva verso i titoli del debito pubblico in Zecca. E inoltre, nell'ottica dello Stato, i debiti contratti tramite il Giro non erano certo onerosi in termini d'interessi da pagare quanto quelli dei depositi in Zecca. D'altro canto il settore in cui agiva il Banco giro - per lo più quello commerciale - era particolarmente delicato, ed il governo preferì basarsi prevalentemente sul sistema dei depositi in Zecca piuttosto che sul Banco, che ancora in quegli anni veniva concepito dal governo come un istituto finanziario transitorio. Un'eccessiva espansione debitoria del Banco, inoltre, avrebbe causato un'alterazione del rapporto fra la moneta corrente e la valuta di banco, a scapito di quest'ultima, e con rilevanti conseguenze sul mercato veneziano (204).
Oltre alle funzioni di tesoreria statale il Banco giro, in seguito alle pressanti richieste dei privati, iniziò ad accettare depositi, spodestando così definitivamente il Banco della Piazza di Rialto. Rimaneva nella piazza veneziana un istituto estremamente importante, la cui attività e il volume creato di moneta fiduciaria davano il tono alla vita economica della città e costituivano un modello per analoghi organi finanziari che stavano sorgendo nell'Europa del primo Seicento.
La moneta
Zecchini, lire, grossi, gazzette, soldi, bezzi, quattrini, reali, ongari, scudi, bagattini, mocenighi, marcelli, mezzi scudi, mezzi ducati, lirazze, denari, talleri; valuta corrente, buona valuta, valuta di banco. Anche a Venezia, come nelle altre principali piazze d'Europa, diverse e innumeri specie monetarie affollavano i canali della circolazione. Era un turbinio di monete, reali e fittizie, veneziane e straniere, che procurava lo sconcerto, non solo tra coloro che non erano affatto addentro alla materia, ma anche tra gli stessi che erano considerati degli esperti. Tuttavia ad ognuno era ben chiara la differenza fra i pregiati conii d'oro e d'argento e quelli mediocri, di rame e di vili misture a scarso valore intrinseco.
Tutte queste valute trovavano un'espressione comune nella moneta di conto, che rappresentava un'ideale unità di misura che non aveva riscontro nella realtà. A Venezia il sistema di conto era costituito dalla lira di piccoli, suddivisa in venti soldi o 240 denari. Una seconda unità di conto era data dal ducato corrente, suddiviso in 24 grossi ognuno dei quali costituito da 32 piccoli. Il lungo periodo di stabilità del ducato d'oro effettivo, pari a sei lire e quattro soldi, fra il 1472 e il 1517 aveva abituato i Veneziani a identificare in un ducato qualsiasi genere di monete corrispondente a 124 soldi. Allorché il corso del ducato effettivo ricominciò a salire oramai la consuetudine gli assegnava il valore di 124 soldi, cosicché il ducato corrente, a base argentea, divenne un'altra moneta di conto che aveva abbandonato le sue radici reali. Il ducato d'oro distaccandosi nella sua corsa dal riferimento del ducato teorico assunse il nome di zecchino. Se nella contabilità dello Stato si trovano usualmente la lira e il ducato come unità di conto nella documentazione privata è possibile imbattersi in un'ulteriore moneta di conto: la lira di grossi - suddivisa anch'essa in 20 soldi di 12 denari ciascuno con un ulteriore sottomultiplo di 32 piccoli - ed equivalente a dieci ducati (205). La lira di piccoli conobbe una progressiva erosione del suo contenuto argenteo, che fra il 1517 e il 1635 registrò una diminuzione del 43,9%, come risulta dalla tabella 3 (206).
Anzitutto occorre rilevare come la quantità d'argento fino rappresentata dalle unità di conto (lira e ducato) sia diminuita del 37% fra il 1525 e il 1635. Una delle varie implicazioni di questo fenomeno riguarda il rapporto fra debitori e creditori. Un credito, contratto per esempio nel 1544 ed espresso in moneta di conto, e saldato nel 1562 avrebbe portato nelle mani del creditore una quantità di monete minore di quella che aveva concessa. Conviene inoltre notare come la crescita del corso dello zecchino in rapporto alla lira segua un andamento abbastanza lineare - salvo il periodo del conflitto per Cipro - sino ai primi anni del Seicento; dopodiché il rialzo del prezzo dell'oro rispetto all'argento - affluito in misura massiccia dalle Americhe - fu considerevole. Fra il 1608 e il '35 il corso del ducato d'oro crebbe del 50%, mentre quello dello scudo d'argento si limitò ad un aumento del 10,7% (207).
La maggior parte dei cambi che abbiamo esposto erano fissati dalle autorità, che ovviamente tendevano a mantenerne costante il livello per ricevere maggiori quantità di denaro dai contribuenti, mentre dilatavano il prezzo delle valute allorché si dovessero pagare beni e servizi ai fornitori. Nel 1572 il condottiero Prospero Colonna - incaricato di arruolare delle truppe per la guerra contro il Turco - si lamentò con il governo di aver ricevuto in prestito una somma di lire versatagli in zecchini valutati a lire 9 s. 15 ciascuno. Quando il militare romano dovette restituire il denaro gli zecchini gli furono conteggiati a lire 8 s. 12 - secondo il loro corso legale -, con una perdita dunque per Colonna di 23 soldi (11, 7 %) per ogni zecchino (208). Nel gennaio del 1606 il corso legale del ducato d'oro era fissato in 10 lire contro un valore di piazza di 11 lire e 10 soldi (15%); e due anni dopo la differenza risultava del 14%; nel 1635, all'indomani di un adeguamento deciso dal governo, lo scarto era limitato al 6,7% (209). In effetti la condizione della piazza spingeva le autorità a ritoccare, talvolta sensibilmente, il corso delle monete grosse. Un'eccessiva sottostima dello zecchino non invogliava certo i Veneziani a versare il loro denaro nei forzieri dei depositi in Zecca. Il provvedimento del 17 aprile 1619, che portava la parità dello zecchino a 12 lire e 8 soldi, venne attuato proprio per favorire il flusso di denaro a prezzi correnti per non sfavorire i prestatori (210).
La lira e il ducato di conto veneziani non erano le sole unità monetarie vigenti nei territori della Repubblica. La varietà dei Domini di San Marco, per tradizioni, per istituzioni, per cultura, si rispecchiava anche nel sistema monetario. Nella provincia veronese la contabilità privata come pure, in taluni casi, quella pubblica era tenuta in lire veronesi, che valevano un terzo in più di quelle veneziane: gli appalti dei dazi della Camera di Verona, ad esempio, nei registri contabili sono espressi in lire veronesi. Nelle zone d'Oltremincio, poi, vige la lira imperiale - che peraltro costituisce la moneta di conto dello Stato di Milano -, e che vale pressappoco il doppio della lira di Venezia. A Bergamo la locale Camera fiscale concede in gestione taluni dazi in base alla lira imperiale. Nei territori d'oltremare la principale unità di conto è rappresentata dal perpero - che trae origine dall'area monetaria bizantina -, formato da 32 soldini di quattro bagattini (o tornesi) ciascuno. A Cipro troviamo il bisante, suddiviso in 24 carati (211). Le diverse monete avevano differenti quotazioni all'interno degli stessi confini della Repubblica. Al ritorno dal reggimento di Brescia nel dicembre 1619, il nobile Antonio Mocenigo avvertiva dei disordini monetari riscontrati nella locale Camera fiscale "per occasione della diversità dei prezzi delle monete dal corrente di qua [Venezia] al valsente di là [Brescia]" (212). Analoghi problemi sussistevano nello Stato da mar. Nel 1595 l'ex capitano di Candia Filippo Pasqualigo rilevava come la conversione delle paghe dei fanti in moneta cretese arrivasse a diminuire di un quinto l'ammontare della paga (213). Agli inizi del Seicento la situazione a Creta si era fatta drammatica: lo zecchino veniva quotato ben 14 lire, ad un valore dunque assai superiore al cambio legale e a quello del mercato veneziano. La scarsezza di buona valuta in realtà aveva spinto i cambi nell'isola greca ad un livello elevato, e nello stesso tempo si stava verificando un pericoloso afflusso di monete piccole "per la maggior parte di pessima condizione". Il provveditore generale Gerolamo Capello fissò nel settembre del 1609 la quotazione a 11 lire e 10 soldi per zecchino, legalizzando uno scarto del 15% rispetto al corso legale di Venezia (214). Del resto il mercato cretese non era certo paragonabile a quello della capitale: erano due aree economiche diverse; diverse per capacità imprenditoriale, per volume di capitali, per risorse. L'alta quotazione del ducato d'oro testimoniava la posizione in subordine di Creta nei confronti di Venezia.
Oro, argento, vili misture generalmente marcavano diversi ambiti economici, distinti circuiti finanziari. Alle monete d'oro e d'argento erano riservati i grandi commerci, le correnti di traffico che solcavano l'Europa e il Medio Oriente, le transazioni fra lo Stato e i principali fornitori. Quest'area comunque non risultava certo impermeabile: alla morte di Alessandro Moron, "biavariol" veneziano all'insegna di S. Giacomo, nella sua dimora furono trovati vari sacchetti contenenti zecchini, doppie d'Italia, ongari, scudi d'argento, talleri, doppie di Spagna. Viceversa, il mercante Alessandro Riccobello, abitante nella parrocchia di S. Cassian, lasciò ai propri eredi ben poca moneta: otto talleri, quattro scudi d'argento e spiccioli per un valore di sei lire e undici soldi (215). Invece i forzieri del procuratore di S. Marco Lodovico Priuli, aperti alla sua morte, contenevano numerosi pezzi d'oro e d'argento; e altrettante valute pregiate furono registrate dal notaio nel redigere i beni di Federico Mussolino (216). Del resto la stessa scarsezza di specie monetarie riscontrate fra i beni del mercante Riccobello induce a ritenere che la sua ricchezza fosse rappresentata piuttosto dalle scritture commerciali, dalle lettere, dalle polizze, dagli accrediti registrati sulla carta, che non dalla moneta sonante. Tuttavia si può anche sospettare che gli eredi, o alcuni di essi, si fossero mossi con la necessaria tempestività per occultare il denaro del defunto. Non desterebbe sorpresa scoprire fra i materassi o i cassetti di artigiani, di lavoratori della lana, di piccoli bottegai, di operai dell'Arsenale, alcune preziose monete. Quel che contraddistingue l'atteggiamento di queste persone dai mercanti sta nel valore attribuito agli zecchini o agli scudi d'argento: i popolani infatti tendono alla tesaurizzazione di queste monete proprio a causa della scarsa possibilità di poterle abitualmente maneggiare. Probabilmente lo scudo d'oro che ricevette in compenso un tale Nicolò dal nobile veronese Ludovico Nogarola fu gelosamente conservato dal servitore (217). L'oro insomma riveste un'attrazione del tutto particolare. Ed è all'oro che talvolta lo Stato deve ricorrere per assicurarsi i servizi dei soldati. Non solo all'autorevole condottiero Prospero Colonna fu consegnata una somma in zecchini per arruolare degli uomini nel 1571, ma anche gli umili fantaccini della guarnigione di Cattaro ricevettero nel 1573 zecchini e "moneda bianca"; e quarant'anni dopo i soldati arruolati in Corsica avranno in mano analoghe monete preziose (218). Spinta dalle necessità della guerra Venezia cerca di soddisfare le richieste dei soldati di essere pagati con una moneta forte; una richiesta, questa, che forse venne esaudita più facilmente anche per la disponibilità di valuta pregiata, la cui esportazione verso il Levante fu presumibilmente frenata dal conflitto. Una volta superata l'emergenza, comunque, nelle tasche dei fanti ritornavano gli spiccioli di bassa lega. I pezzi d'oro tuttavia dovevano essere cambiati con le piccole monete, che permettevano di effettuare i pagamenti concernenti la vita quotidiana. Gli zecchini ricevuti dai soldati non consentivano di acquistare agevolmente un po' di pane, del vino, del formaggio: occorreva procurarsi gli spiccioli. E nell'effettuare la permuta i cambiavalute locali ne approfittavano per conseguire ampi margini di guadagno a scapito dei militari. È a causa di ciò che nel febbraio del 1571 il consiglio dei dieci ordina di far stampare a Candia 5.000 ducati in tornesi da distribuire alle truppe (219). Le valute ad alto valore in realtà creavano dei problemi allorché si trovavano in un ambito inferiore a quello loro riservato. Thomas Coryat nelle pagine del suo diario di viaggio esorta calorosamente il turista inglese a non portare con sé monete d'oro, ma di procurarsi lettere di cambio in moneta di banco da usare una volta giunto nella città lagunare. "Perché se tu dovessi fare di Venezia la tua residenza per un periodo di tempo abbastanza lungo", avverte il viaggiatore inglese, "quando avessi bisogno di comperarti qualche piccolo oggetto di poco valore, subiresti una perdita con l'oro, ma non con le lire: tutti accetteranno le tue lire senza perdita per te, ma nessuno accetterà il tuo oro senza un profitto per sé e un danno per te, a meno che tu non comperi qualcosa d'un certo valore" (220).
La tendenza fra i ceti inferiori alla tesaurizzazione delle grosse monete non trova forse una spiegazione anche negli indubbi svantaggi a cambiarle?
I pagamenti in oro alle truppe costituiscono un'eccezione nel quadro della circolazione monetaria: l'oro - come s'è detto - è il protagonista dei grandi commerci. È significativo che l'andamento delle emissioni auree della Zecca veneziana, almeno sino ai primi anni del Seicento, si colleghi più alla domanda levantina che ai flussi dell'oro americano che giunge in Europa. Una produzione di moneta aurea, quella di Venezia, che nel trentennio a cavallo fra il 1580 e il 1610 era superiore alla quantità del prezioso metallo che giungeva a Siviglia dalle Indie orientali; che rappresentava il doppio delle monete emesse da Genova; che superava di nove volte il prodotto lavorato dalla zecca londinese; e che, infine, corrispondeva a circa un quinto della produzione mondiale (220). Il ducato d'oro veneziano in effetti era una moneta particolarmente richiesta, non solo in Europa ma soprattutto nei mercati orientali. Il suo peso di 3,49 grammi d'oro fino fu mantenuto costante dalle autorità veneziane sino al crollo della Serenissima nel 1797. La stabilità di questa moneta doveva incarnare agli occhi della gente la solidità della Repubblica di San Marco, e nello stesso tempo assicurava il prestigio veneziano e dei suoi mercanti in tutte le piazze.
A fronte della stabilità dell'intrinseco dello zecchino la maggior parte delle monete circolanti a Venezia era sottoposta ad una progressiva diminuzione del proprio contenuto. Da una parte lo Stato operava al momento di battere i conii svilendo l'intrinseco e lasciando immutato il valore nominale; dall'altra le monete subivano l'usura del trasporto e del maneggio, nonché la "tosatura" di coloro che volevano ricavare un po' di materiale prezioso. Inoltre il dislivello tra i pezzi pregiati e le monete divisionali causava un aggio tra valuta buona (per peso e conio), o di zecca, e corrente (di bassa lega e in progressivo svilimento) (222). Solitamente lo Stato esigeva che le imposte venissero pagate in buona valuta, costringendo i contribuenti a ricercarla sul mercato. Probabilmente il mondo rurale denunciava una maggior difficoltà rispetto alla città a versare grandi somme in monete grosse. Tuttavia in particolari momenti anche le autorità si rendevano conto che occorreva far fronte alle difficoltà dei sudditi, poiché i disagi di questi creavano intoppi anche alla riscossione fiscale. Tale preoccupazione sta alla base del provvedimento deliberato nel luglio del 1572, che permetteva ai contribuenti e agli appaltatori dei dazi di soddisfare il fisco con valute correnti, aggiungendo un'addizionale di un grosso per ducato (223). Col trascorrere degli anni e in conseguenza delle gravi perturbazioni sul mercato monetario il senato dovette concedere in varie occasioni la possibilità dei versamenti in valuta corrente, o perlomeno con le stesse monete direttamente riscosse dai contribuenti. Così accadde per i dazieri di Bergamo, e per talune tasse riscosse nel Bresciano, Veronese e Vicentino. Conviene sottolineare, comunque, che le monete correnti venivano spesso redistribuite in loco tramite i pagamenti effettuati dalle Camere fiscali al personale e ai soldati (224). Gli stessi Veneziani nel 1624 e nel '30 poterono corrispondere una decima e una tansa in valuta corrente con un aggio del 20% (225).
"I prezzi in moneta di zecca delle specie auree ed argentee, prezzi invariabili", ha scritto Giulio Mandich, "cedono il posto ai prezzi in moneta corrente delle stesse specie: prezzi mutevoli, questi, e più conformi degli altri alle mutevoli condizioni del mercato". Un mercato, quello veneziano, che alla vigilia della grande peste si era notevolmente complicato: il denaro che ne tonificava l'atmosfera assumeva un diverso significato rispetto ad un secolo prima. I segni delle difficoltà commerciali si erano fatti sempre più preoccupanti, e il gioco dei cambi - allettante e pericoloso - aveva attirato molti capitali veneziani. In questo quadro il governo cercava nuovi strumenti di politica fiscale che non provocassero traumi sul delicato organismo della piazza e che, nello stesso tempo, sostenessero una finanza statale sottoposta a duri colpi. Il progressivo spostamento verso la valuta corrente può essere considerato un segno della politica finanziaria del gruppo dirigente: una politica talvolta elastica, che si piega alle esigenze della congiuntura. Le vicende monetarie e l'atteggiamento assunto a tal riguardo dal governo veneziano possono essere considerati infatti un elemento fra i molti che costituiscono il quadro finanziario della storia della Repubblica. Un quadro in cui agiscono, più o meno legati da vicendevoli rapporti, il gruppo dirigente della capitale, le élites del Dominio, i sudditi veneziani e dello Stato, nel contesto dell'economia locale e internazionale e delle necessità della politica di Venezia in Italia e nel Mediterraneo.
1. A.S.V., Miscellanea codici, IV, Codici Papadopoli, 12, cc. 127v-128r.
2. Cf. Michael Knapton, Guerra e finanza (1381-1508), in Gaetano Cozzi-Michael Knapton, La Repubblica di Venezia nell'età moderna. Dalla guerra di Chioggia al 1517, in Storia d'Italia, diretta da Giuseppe Galasso, XII, 1, Torino 1986, p. 302 (pp. 275-353); Bilanci generali della Repubblica di Venezia, I, 1, a cura di Fabio Besta, Venezia 1912, pp. 173-176; Paris, Bibliothèque Nationale, Fonds italiens, 1411, cc. 147r-150v.
3. Thomas Coryat, Crudezze. Viaggio in Francia e in Italia 1608, a cura di Franco Marenco-Antonio Meo, Milano 1975, pp. 303 s. Dati sul bilancio inglese del primo Seicento in Frederick C. Dietz, English Public Finance 1558-1641, London 19642, p. 113.
4. A.S.V., Senato Terra, reg. 30, cc. 14r-I5r, 32v, 37r (11 aprile, 20 luglio e 29 agosto 1538), 67v-68r (8 marzo 1539); ivi, Consiglio dei Dieci, Comuni, reg. 12, passim.
5. Ivi, Consiglio dei Dieci, Zecca, f. 3, scrittura di Zuan Francesco Priuli del 14 giugno 1577.
6. Bilanci generali, p. 444.
7. A.S.V., Archivio privato Correr, 263, relazione di Alvise Grimani, c. 7v. Il nobile veneziano esercitò il suo mandato tra marzo del 1583 e dicembre del 1585.
8. Ivi, Senato Zecca, reg. non numerato, cc. 88r, 91r (10 giugno e 3 ottobre 1615).
9. Bilanci generali, pp. 222 ss., 236-242, 264-278, 365-374, 419 ss., 471-475, 486-491, 500-510; A.S.V., Archivio privato Correr, 187, 189; Luciano Pezzolo, L'oro dello Stato. Società, finanza e fisco nella Repubblica veneta del secondo '500, Venezia 1990, pp. 96, 121; Frederic C. Lane, Storia di Venezia, Torino 1978, p. 495; Michael Knapton, City Wealth and State Wealth in Northern Italy, 14th-17th Centuries, in La ville, la bourgeoisie et la genèse de l'état moderne (XIIe-XVIIIe siècles), a cura di Neithard Bulst-Jean Philippe Genet, Paris 1988, p. 203 (pp. 183-209).
10. Per tale questione cf. oltre.
11. Per queste percentuali si vedano le fonti documentarie della tab. 1.
12. I dati delle entrate in L. Pezzolo, L'oro dello Stato, pp. 336-339.
13. Ibid., pp. 120-121; Bilanci generali, pp. 476, 493; A.S.V., Archivio privato Correr, 187, 189.
14. Le percentuali si basano su L. Pezzolo, L'oro dello Stato, pp. 123-124; A.S.V., Archivio privato Correr, 187, passim e 189, c. 52 per il dato del 1618; Bilanci generali, pp. 474-475.
15. Cf. i dati che riporta Ruggiero Romano, Aspetti economici degli armamenti navali veneziani nel secolo XVI, "Rivista Storica Italiana", 66, 1954, pp. 39-67.
16. Ibid., e L. Pezzolo, L'oro dello Stato, pp. 123, 137.
17. Cf. ad esempio A.S.V., Senato Terra, reg. 43, cc. 22v-23r (13 novembre 1560); Frederic C. Lane, Navires et constructeurs à Venise pendant la Renaissance, Paris 1965, pp. 203 ss.
18. L. Pezzolo, L'oro dello Stato, p. 147.
19. Percentuale elaborata in base a Venezia, Museo Correr, Morosini-Grimani, 302, cc. 110v-111v.
20. Bilanci generali, pp. 471-473. Le cifre proposte qui e in precedenza differiscono in una certa misura dal quadro fornito da Richard T. Rapp, Industria e decadenza economica a Venezia nel XVII secolo, Roma 1986, specie pp. 184-188, a causa dei diversi criteri d'elaborazione delle fonti.
21. L. Pezzolo, L'oro dello Stato, pp. 327-328; A.S.V., Procuratori di San Marco, Misti, b. 225, fasc. 3; ivi, Archivio Tiepolo, I consegna, b. 227, fasc. "Badoer".
22. Michael E. Mallett-John R. Hale, The Military Organization of a Renaissance State. Venice c. 1400 to 1617, Cambridge 1984, pp. 476-480, 483.
23. A.S.V., Senato Terra, reg. 29, cc. 160v-161 r, 173r-v.
24. Ibid., reg. 30, c. 113v (22 luglio 1539).
25. V. i dati forniti da Domenico Sella, Commerci e industrie a Venezia nel secolo XVII, Venezia-Roma 1961, Appendice E, p. 118.
26. A.S.V., Senato Terra, reg. 30, cc. 60r, 62r (3 e 14 febbraio 1539).
27. Ibid., reg. 29, cc. 130v-131r, 135r, 138r-v (4, 14 e
29 giugno 1537). V. anche alcuni dati, seppur diversi, ivi, Archivio proprio Balbi, 6, c.n.n.
28. F.C. Lane, Storia di Venezia, pp. 385-386.
29. A.S.V., Miscellanea codici, I, Storia veneta, 66, c. 232V.
30. Ivi, Consiglio dei Dieci, Comuni, reg. 12, cc. 106v-107r, 129v-130r, 227v-228r.
31. Ibid., cc. 221 r, 222r.
32. Ivi, Senato Terra, reg. 30, cc. 47v, 55r, 61r (21 ottobre e 14 dicembre 1538, 7 febbraio 1539); ivi, Consiglio dei Dieci, Comuni, reg. 12, cc. 184v, 199v-200r, 203v-204r, 215v-216r. Per la decima, Daniele Beltrami, La penetrazione economica dei veneziani in terraferma. Forze di lavoro e proprietà fondiaria nelle campagne venete dei secoli XVII e XVIII, Venezia-Roma 1961, p. 51.
33. Bilanci generali, pp. 210-212 (28 aprile 1528).
34. A.S.V., Consiglio dei Dieci, Comuni, reg. 12, cc. 5v, 18r, 35v-36r (8 marzo, 18 aprile e 20 maggio 1537).
35. Per tutto questo cf. ibid., regg. 12 e 13; ivi, Senato Terra, reg. 30.
36. Ho provato a calcolare la frequenza della domanda di denaro da parte dello Stato tramite l'emissione di titoli del debito pubblico. Ho considerato gli anni 1538-39, suddividendo il totale della somma richiesta (1.400.000 ducati) per trimestre. Il risultato è il seguente: novembre, dicembre e gennaio 300.000 ducati (21,4%); febbraio, marzo e aprile 400.000 ducati (28,6%); maggio, giugno e luglio 330.000 ducati (23,6%); agosto, settembre e ottobre 370.000 ducati (26,4%). A titolo comparativo fornisco alcuni dati per gli anni di guerra 1571-72. Le rispettive percentuali sono: 30,5% per il primo trimestre; 31,6 per il secondo; 17,9 per il terzo; e infine 20% per il periodo agosto-ottobre.
37. Ivi, Consiglio dei Dieci, Zecca, reg. i, passim.
38. V. la parte in Bilanci generali, pp. 583-584 (20 dicembre 1544).
39. Luciano Pezzolo, Istituzioni e amministrazione in Valpolicella nel Cinquecento e primo Seicento, in La Valpolicella nella prima età moderna (1500 c.-1630), a cura di Gian Maria Varanini, Verona 1987, p. 306.
40. Per un quadro sintetico v. i dati che offre il bilancio statale del 1550 in Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, ms. it. cl. VI. 80 (= 5767), cc. 165 ss.; nonché Venezia, Museo Correr, Morosini-Grimani, 302.
41. Bilanci generali, pp. 593-594, 596-599.
42. A.S.V., Notarile, Atti, b. 14046, cc. 24r ss. (3 febbraio 1569). Pare che i termini del contratto, comunque, non siano stati rispettati, se ancora nel 1582 l'ambasciatore francese Hurault de Maisse doveva giustificare di fronte al governo veneziano il mancato saldo del prestito (Paris, Bibliothèque Nationale, Fonds italiens, 314, c. 5r, 17 dicembre 1582).
43. A.S.V., Secreta, Archivio proprio Contarini, 6, c.n.n.; ivi, Miscellanea codici, I, Storia veneta, 66, c. 245v; Paris, Bibliothèque Nationale, Fonds italiens, 323, cc. 470v ss.
44. Sull'approntamento delle forze per la guerra di Cipro v. John R. Hale, From Peacetime Establishment to Fighting Machine: the Venetian Army and the War of Cyprus and Lepanto, in Il Mediterraneo nella seconda metà del '500 alla luce di Lepanto, a cura di Gino Benzoni, Firenze 1974, pp. 163-184; nonché M.E. Mallett-J.R. Hale, The Military Organization, pp. 480-482. I dati sui costi militari sono il frutto di ricerche personali ancora inedite.
45. A.S.V., Senato Terra, reg. 48, cc. 15r-v (11 aprile 1570), 93r-v (6 aprile 1571).
46. Ibid., reg. 49, cc. 93r-94r (7 gennaio 1573).
47. Ivi, Notarile, Testamenti, b. 344 (marzo 1595). Il calcolo del versamento è stato effettuato in base al tasso dell'8 e del 7%.
48. Ivi, Consiglio dei Dieci, Zecca, f. 3 (14 giugno 1577). Cf. anche Daniele Beltrami, Un ricordo del Priuli intorno al problema dell'ammortamento dei depositi in Zecca del 1574, in AA.VV., Studi in onore di Armando Sapori, II, Milano 1957, p. 1079 (pp. 1073-1087).
49. Priuli era nato il 25 novembre 1515 (Marco Barbaro, Arbori de patritii veneti, VI, ms. in A.S.V., Misc. codici, I, Storia veneta). Il suo piano è stato pubblicato da D. Beltrami, Un ricordo del Priuli, pp. 1081-1087. Nelle citazioni sono intervenuto con qualche modifica rispetto alla trascrizione di Beltrami.
50. La citazione di Nicolò Contarini è tratta dai brani delle Historie venetiane pubblicati da Gaetano Cozzi, Il doge Nicolò Contarini. Ricerche sul patriziato veneziano agli inizi del Seicento, Venezia-Roma 1958, p. 313. Per la nomina di Priuli, A.S.V., Segretario alle voci, Elezioni in Senato, reg. 4, c. 79v (19 ottobre 1574). Riguardo alcune cariche ricoperte in precedenza cf. ibid., reg. 3, cc. 19v, 50r. Egli fu anche varie volte membro del consiglio dei dieci.
51. Cf. A.S.V., Senato Terra, reg. 30, cc. 70r-74r (12 e 17 marzo 1539). I termini della discussione sono stati riportati anche da Samuele Romanin, Storia documentata di Venezia, VI, Venezia 1857, pp. 43-51.
52. A.S.V., Senato Terra, reg. 47, c. 4r (29 marzo 1568); reg. 48, cc. 115r-116v (17 luglio 1571), e passim.
i3. Frederic C. Lane, Public Debt and Private Wealth: Particularly in Sixteenth Century Venice, in AA.VV., Mélanges en l'honneur de Fernand Braudel, I, Toulouse 1973, p. 322 (pp. 317-325).
54. Cf. Giuseppe Del Torre, La politica ecclesiastica della Repubblica di Venezia nell'età moderna: la fiscalità, in Fisco religione e Stato nell'età confessionale, a cura di Hermann Kellenbenz-Paolo Prodi, Bologna 1989, pp. 387-426.
55. La scrittura di Zorzi si trova in A.S.V., Misc. Gregolin, b. 14, fasc. 2 (20 febbraio 1575). Egli fu capitano a Padova, provveditore generale a Corfù, e nel febbraio del 1592 venne eletto procuratore di S. Marco, proprio per sostituire Zuan Francesco Priuli, scomparso da poco tempo. Morirà l'anno successivo, all'età di 88 anni. Cf. M. Barbaro, Arbori, VII, cc. 400, 424.
56. Per le misure di carattere finanziario prese dalle autorità cf. Paolo Preto, Peste e società a Venezia nel 1576, Vicenza 1978, pp. 131 ss.
57. A.S.V., Consiglio dei Dieci, Zecca, f. 3, scrittura di Zuan Francesco Priuli del 14 giugno 1577.
58. Oltre alla già cit. scrittura di Priuli cf. Ugo Corti, La francazione del debito pubblico della Repubblica di Venezia proposta da Gian Francesco Priuli, "Nuovo Archivio Veneto", 7, 1894, pp. 331-364.
59. N. Contarini, Historie venetiane, in G. Cozzi, Il doge Nicolò Contarini, pp. 313-314.
60. Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, ms. it. cl. VII. 110 (= 8612), Memorie di Francesco Molin, c. 70r.
61. Bilanci generali, pp. 339-340; Simancas, Archivo General, Estado, leg. 1337, disp. di Cristóbal de Salazar (27 maggio e 30 luglio 1580).
62. A.S.V., Notarile, Testamenti, b. 1244, n. 368 (25 luglio 1599).
63. Ibid., b. 1262, prot. I, c. 23r-v (21 settembre 1558).
64. Cf. D. Beltrami, La penetrazione economica dei veneziani in terraferma, pp. 53-54; Gigi Corazzol, Livelli stipulati a Venezia nel 1591. Studio storico, Pisa 1986, pp. 31, 62-63.
65. Alberto Tenenti, Luc'Antonio Giunti il Giovane stampatore e mercante, in AA.VV., Studi in onore di Armando Sapori, II, Milano 1957, pp. 1048-1050, 1053, 1055 (pp. 1021-1060).
66. A.S.V., Notarile, Atti, b. 3350, cc. 56r ss. (8 aprile 1579).
67. Per numerose testimonianze riguardo l'attività dei Genovesi e dei Fiorentini a Venezia cf., ad esempio, ibid., bb. 3350 ss., protocolli di Zuan Andrea Catti dal 1579 in poi. Ulteriori elementi anche in Renzo Pecchioli, Uomini d'affari fiorentini a Venezia nella seconda metà del Cinquecento: prime ricerche, in Id., Dal "mito" di Venezia all'"ideologia americana". Itinerari e modelli della storiografia sul repubblicanesimo dell'età moderna, Venezia 1983, pp. 74-90; Ugo Tucci, Il Banco della Piazza di Rialto, prima banca pubblica veneziana, ora in Id., Mercanti, navi, monete nel Cinquecento veneziano, Bologna 1981, specie pp. 244-248 (pp. 231-250).
68. A.S.V., Notarile, Testamenti, b. 1244, n. 368 (13 marzo 1602).
69. Giulio Mandich, Le Pacte de Ricorsa et le marché italien des changes au XVIIe siècle, Paris 1953, pp. VIII, 69 ss.; U. Tucci, Il Banco della Piazza di Rialto, pp. 245-246; A.S.V., Archivio privato Contarini in Arch. priv. Marcello Grimani Giustinian, b. 5.
70. A.S.V., Archivio Labia, b. 1, c. 178r. I luoghi del Monte (ogni luogo corrispondeva al valore nominale di cento scudi d'oro) costituivano delle quote del debito pubblico pontificio. Il Monte d'Ungheria venne eretto proprio nel 1595. Cf. Enrico Stumpo, Il capitale finanziario a Roma fra Cinque e Seicento. Contributo alla storia della fiscalità pontificia in età moderna (1570-1660), Milano 1985, pp. 247 ss.
71. A.S.V., Misc. Gregolin, b. 44, fasc. circa l'affrancazione dei Monti (18 marzo 1579).
72. Bilanci generali, pp. 339-340 (15 giugno 1584).
73. Jean Delumeau, Vie économique et sociale de Rome dans la seconde moitié du XVIe siècle, 11, Paris 1959, pp. 766-767.
74. F.C. Dietz, English Public Finance, pp. 25, 34, 47-48.
75. Giuliano de' Ricci, Cronaca (1532-1606), a cura di Giuliana Sapori, Milano-Napoli 1972, p. 256, cit. da Carlo M. Cipolla, La moneta a Firenze nel Cinquecento, Bologna 1987, p. 118.
76. Un cenno, tuttavia, ad opinioni contrarie da parte dei provveditori in Zecca si trova in A.S.V., Provveditori in Zecca, reg. 41 bis, c. 46v.
77. Henry Lapeyre, Une famille de marchands: les Ruiz. Contribution à l'étude du commerce entre la France et l'Espagne au temps de Philippe II, Paris 1955, p. 454.
78. Ugo Tucci, Gli investimenti assicurativi a Venezia nella seconda metà del Cinquecento, in Id., Mercanti, navi, monete, p. 147 (pp. 145-160).
79. G. Corazzol, Livelli stipulati a Venezia, pp. 13-15.
80. Venezia, Museo Correr, Donà dalle Rose, 161, c. 56r (9 aprile 1597); A.S.V., Senato Zecca, f. 11 (2 maggio 1609). Cf. L. Pezzolo, L'oro dello Stato, p. 208.
81. Parere dei Clarissimi Antonio Bragadin e Jacopo Foscarini procuratori di San Marco e savi del consiglio intorno al trattato tra Venezia e Spagna sul traffico del pepe e delle spezie dell'Indie Orientali (1585), a cura di Federico Stefani, Venezia 1870. Su Foscarini cf. Bartolomeo Ridolfi Sforza, Vita di Giacopo Foscarini, Cavaliere e Procuratore di S. Marco, Venezia 1624. All'indomani della sua morte il rappresentante spagnolo a Venezia scrisse che Foscarini era "el sujetto mas capaz que tenian" (Simancas, Archivo General, Estado, leg. 1349, I febbraio 1603).
82. Cf. Zvi Ankori, Giacomo Foscarini e gli ebrei di Creta. Un riesame con una edizione degli "ordini" sugli ebrei, "Studi Veneziani", n. ser., 9, 1985, pp. 67-183.
83. Si vedano, per esempio, le critiche implicite di Alvise Grimani nella sua intelligente relazione come provveditore generale a Candia dal 1583 al 1585, in A.S.V., Archivio privato Correr, 263.
84. B. Ridolfi Sforza, Vita di Giacopo Foscarini, p. 116.
85. Heinrich Sieveking, Studio sulle finanze genovesi nel Medioevo e in particolare sulla Casa di S. Giorgio, "Atti della Società Ligure di Storia Patria", 35, pt. II, 1906, pp. 224-225 (pp. 1-392).
86. A.S.V., Senato Zecca, reg. 1, cc. 174v- 175r (10 agosto 1595); ivi, Savio Cassier, b. 649, fasc. 2 (28 ottobre 1595); ivi, Compilazione leggi, I, b. 230, c. 191v; F.C. Lane, Public Debt, p. 323.
87. A.S.V., Procuratori di S. Marco, Supra, b. 48, fasc. 1.
88. Ivi, Senato Terra, reg. 70, cc. 123v- 124v (16 novembre 1600). Il decreto fu approvato con 124 voti favorevoli, 13 contrari e 51 astenuti. Nel gennaio successivo venne respinta una prima volta una parte circa le modalità dell'ammortamento (ibid., c. 159r-v, 30 gennaio 1601).
89. Ivi, Revisori e regolatori delle entrate pubbliche in Zecca, b. 1070, fasc. "Affrancatione de Monti"; F.C. Lane, Storia di Venezia, p. 375.
90. U. Corti, La francazione del debito pubblico, p. 338.
91. Nel 1590, per esempio, il cardinale Montalto aveva depositato in Zecca 25.000 scudi ad un interesse del 5%: cf. A.S.V., Senato Zecca, reg. i, cc. 93r (24 ottobre 1591), 97r, 104r (14 marzo e 3 settembre 1592), 111v (23 marzo 1593). Cf. anche F.C. Lane, Public Debt, p. 323.
92. Brian Pullan, La politica sociale della Repubblica di Venezia, 1500-1620, I, Roma 1982, p. 156.
93. A.S.V., Senato Zecca, reg. n.n., c. 77r-v (7 marzo 1614).
94. M. E. Mallett-J.R. Hale, The Military Organization, p. 484.
95. Enrico Stumpo, Gli aiuti finanziari di Venezia al duca Carlo Emanuele I di Savoia nella guerra contro la Spagna (1616-1617), "Rassegna degli Archivi di Stato", 34, 2-3, 1974, pp. 428-461.
96. A.S.V., Senato Zecca, reg. n.n., cc. 95r-96v (g marzo 1616).
97. Ibid., reg. n.n., cc. 100v- 101v, 102v (15 settembre, 16 novembre e 10 dicembre 1616).
g8. Bilanci generali, pp. 473-474.
99. A.S.V., Senato Zecca, reg. n.n., cc. 104r-v, 105v- 106r (2 maggio e 25 ottobre 1617). Nella parte sul deposito vitalizio non è specificata la somma globale.
100. Ivi, Archivio Labia, b. 1, cc. 168r-v.
101. Alberto Cova, Il Banco di S. Ambrogio nell'economia milanese dei secoli XVII e XVIII, Milano 1972, pp. 53-55; Aldo De Maddalena, "Pecunia pecuniam parit": anche nella Milano del Seicento. Debiti monetari e tassi d'interesse (1620-1720), ora in Id., Dalla città al borgo. Avvio di una metamorfosi economica e sociale nella Lombardia spagnola, Milano 1982, pp. 199-250; E. Stumpo, Il capitale finanziario, p. 251; Carlo M. Cipolla, Note sulla storia del saggio d'interesse. Corso, dividendi e sconto dei dividendi del Banco di S. Giorgio nel secolo XVI, ora in Id., Saggi di storia economica e sociale, Bologna 1988, pp. 51-67; Richard Bonney, The King's Debts. Finance and Politics in France 1589-1661, Oxford 1981, p. 19; Robert Ashton, The Crown and the Money Market, 1603-1646, Oxford 1960, p. 69.
102. Alberto Tenenti, Naufrages, corsaires et assurances maritimes à Venise, 1592-1609, Paris 1959, p. 62; Giorgio Doria, Conoscenza del mercato e sistema informativo: il know-how dei mercanti finanzieri genovesi nei secoli XVI e XVII, in La repubblica internazionale del denaro tra XV e XVII secolo, a cura di Aldo De Maddalena - Hermann Kellenbenz, Bologna 1986, pp. 90-91 (pp. 57-121); G. Mandich, Le Pacte de Ricorsa, p. 95. Un interessante documento sulla propensione genovese ad investire a Venezia in Genova, Archivio di Stato, Archivio segreto, Lettere consoli, b. 2704, lett. del 3 agosto 1601.
103. A.S.V., Compilazione leggi, I, b. 230, c. 203r; ivi, Senato, Dispacci Genova, f. 3 (12 agosto 1618); Giuseppe Felloni, Gli investimenti finanziari genovesi in Europa tra il Seicento e la Restaurazione, Milano 1971, p. 143.
104. G. Felloni, Gli investimenti finanziari, p. 145
105. A.S.V., Senato Zecca, reg. n.n., c. I29r (30 gennaio 1623).
106. Bilanci generali, p. 550.
107. A.S.V., Senato Terra, f. 224 (6 e 23 maggio, 29 giugno 1617); Bilanci generali, pp. 455-456.
108. Ugo Tucci, Convertibilità e copertura metallica della moneta del Banco Giro veneziano, "Studi Veneziani", 15, 1973, P. 368 (pp. 349-448).
109. G. Corazzol, Livelli stipulati a Venezia, p. 8.
110. Ibid., pp. 25, 47 n. 40. Per il calcolo circa la popolazione adulta, Daniele Beltrami, Storia della popolazione di Venezia dalla fine del secolo XVI alla caduta della Repubblica, Padova 1954, p. 82.
111. Cf. i dati forniti da Brian Pullan, Wage-Earners and the Venetian Economy, 1550-1630, in Crisis and Change in the Venetian Economy in the 16th and 17th Centuries, a cura di Id., London 1968, p. 173 (pp. 146-174); e per lo stipendio del sergente, M. E. Mallett-J.R. Hale, The Military Organization, p. 499.
112. A.S.V., Archivio privato Correr, 189, c. 7.
113. Ibid., c. 53.
114. Ivi, Dieci Savi alle decime in Rialto, reg. 2, c. 210r (13 giugno 161g).
115. Ivi, Archivio privato Correr, 189, cc. 7, 11.
116. Circa i dati sulla produzione tessile cf. D. Sella, Commerci e industrie, pp. 111-112, 118, 125, 127; per l'attività marittima, Frederic C. Lane, La marina mercantile della Repubblica di Venezia, in Id., Le navi di Venezia fra i secoli XIII e XVI, Torino 1983, pp. 30, 38 (pp. 24-44). Per questo momento cruciale dell'economia, non solo veneziana, cf. Ruggiero Romano, Tra XVI e XVII secolo. Una crisi economica: 1619-22, ora in Id., L'Europa tra due crisi (XIV e XVII secolo), Torino 1980, pp. 76-147; e Giovanni Vigo, Manovre monetarie e crisi economica nello Stato di Milano (1619-1622), "Studi Storici", 17, 1976, pp. 101-126.
117. Relazioni dei rettori veneti in Terraferma, IX, a cura di Giorgio Borelli, Podestaria e capitanato di Verona, Milano 1977, pp. 268-269 (26 giugno 1626).
118. Ivo Mattozzi, Crisi, stagnazione e mutamento nello Stato veneziano sei-settecentesco: il caso del commercio e della produzione olearia, "Studi Veneziani", n. ser., 4, 1980, pp. 208, 228-232 (pp. 199-276).
119. Bilanci generali, pp. 473-474.
120. A.S.V., Archivio Tiepolo, I consegna, b. 227, fasc. "Badoer".
121. G. Corazzol, Livelli stipulati a Venezia, p. 8.
122. A.S.V., Senato Terra, reg. 103, cc. 107r-108r.
123. Ivi, Archivio Tiepolo, I consegna, b. 227, fasc. "Badoer".
124. Ivi, Revisori e regolatori delle entrate pubbliche in Zecca, b. 640, c. n.n.; Bilanci generali, pp. 478-483.
125. A.S.V., Senato Giro, f. 3 (7 marzo 1630).
126. Ivi, Dieci Savi alle decime in Rialto, reg. 2, c. 215r-v. Qualche confusione circa il carattere di questa imposta in Bilanci generali, p. CLXI.
127. A.S.V., Dieci Savi alle decime in Rialto, reg. 2, cc. 215v-216r.
128. Ivi, Senato Terra, reg. 104, c. 506r (28 dicembre 1630); reg. 105, cc. 6r-v, 31r (8 e 18 marzo 1631), 117r (13 maggio 1631).
129. Ivi, Senato Zecca, reg. n.n., c. 131r-v (20 agosto 1624). I limiti imposti alla consultazione dei documenti conservati presso l'Archivio di Stato di Venezia, e in particolare riguardo i fondi del senato e della Zecca, mi hanno impedito di fornire, tra l'altro, un quadro più preciso della finanza veneziana dal 1627 al 1630. A chi scrive non resta che scusarsi con il lettore ed augurarsi che in futuro le condizioni di lavoro presso taluni archivi e biblioteche possano divenire accettabili.
130. Ibid., cc. 131v-132r (20 dicembre 1624), 133r-v (8 aprile 1625).
131. Ibid., c. 144v (11 novembre 1626).
132. Pierre Beltrame, L'impôt, Paris 1987, pp. 47-50.
133. Bilanci generali, p. 455.
134. Hubert Jedin, Papst Pius V., die heilige Liga und der Kreuzzugsgedanke, in Il Mediterraneo nella seconda metà del '500 alla luce di Lepanto, a cura di Gino Benzoni, Firenze 1974, pp. 193-213.
135. A.S.V., Senato Terra, reg. 30, c. 70r-v (12 marzo 1539).
136. Ibid., reg. 43, cc. 126r ss. (25 novembre 1561).
137. Sulle profonde connessioni tra il sistema concettuale religioso e la nascita degli Stati cf. il magnifico libro di Ernst Kantorowicz, I due corpi del Re. L'idea di regalità nella teologia politica medievale, Torino 1989, in particolare per le questioni legate alla fiscalità pp. 202, 243-249.
138. A.S.V., Notarile, Testamenti, b. 344, n. 370.
139. G. Cozzi, Il doge Nicolò Contarini, p. 266.
140. Ibid., pp. 3, 24.
141. A.S.V., Senato Terra, reg. 105, c. 35r (22 marzo 1631).
142. Ivi, Notarile, Testamenti, b. 1249, c. 7.
143. Ibid., b. 195 (13 settembre 1576).
144. Ibid., b. 1249, c. 50; anche per quanto segue, salvo diversa indicazione.
145. Ivi, Senato Terra, reg. 29, c. 169r (11 ottobre 1537).
146. Jean Meuvret, Comment les Français du XVIIe siècle voyaient l'impôt, in Id., Etudes d'histoire économique. Recueil d'articles, Paris 1971, p. 295 (pp. 295-308); Geoffrey R. Elton, Taxation for War and Peace in Early-Tudor England, in War and Economic Development. Essays in Memory of David Joslin, a cura di Jay M. Winter, Cambridge 1975, p. 34 (pp. 33-48).
147. Gasparo Contarini, Della Republica et Magistrati di Venetia, Venezia 1650, p. 125.
148. D. Beltrami, Un ricordo del Priuli, pp. 1086-1087.
149. A.S.V., Miscellanea codici, I, Storia veneta, 128; L. Pezzolo, L'oro dello Stato, p. 312 n.
150. La supplica è riportata da Agostino Zanelli, Una petizione di Bresciani al Senato veneto sulle gravezze imposte alla città e al Territorio, "Archivio Storico Lombardo", 56, 1929, p. 311 (pp. 297-322).
151. A.S.V., Senato Terra, reg. 13, c. 170v (13 gennaio 1501); Marino Sanuto, I diarii, IV, a cura di Nicolò Barozzi, Venezia 1880, coll. 189, 234-235, 641.
152. Nunziature di Venezia, IX, (26 marzo 1569 - 21 maggio 1571), a cura di Aldo Stella, Roma 1972, p. 97 (20 luglio 1569). Cf. anche A.S.V., Senato Secreta, reg. 76, c. 14v (18 luglio 1568); Senato Terra, reg. 48, cc. 1151- 116v (17 luglio 1571).
153. J. Meuvret, Comment les Français du XVIIe siècle voyaient l'impôt, p. 299.
154. A.S.V., Compilazione leggi, b. 221, cc. 529-531 549, 558, 56o, 562; ivi, Senato Terra, f. 279 (4 maggio 1626).
155. Ivi, Compilazione leggi, b. 221, cc. 529-530 (29 febbraio 1636) .
156. Cf. i dati in Bilanci generali, pp. 235, 585-586.
157. Cf. L. Pezzolo, L'oro dello Stato, pp. 308-309.
158. Reinhold C. Mueller, The Role of Bank Money in Venice, 1300-1500, "Studi Veneziani", n. ser., 3, 1979, pp. 47-96.
159. Per i prestiti del 1510, A.S.V., Consiglio dei Dieci, Misti, reg. 33, cc. 47r e 66v; per quelli del 1511, Felix Gilbert, The Pope, His Banker, and Venice, Cambridge (Mass.)-London 1980, pp. 34-35. La frase di Priuli in Girolamo Priuli, I diarii, in R.I.S.2, XXIV, 3, vol. IV, a cura di Roberto Cessi, 1939, p. 369.
160. Richard Ehrenberg, Le Siècle des Fugger, Paris 1955, pp. 53 ss., 136-148.
161. Marin Sanudo Il Giovane, De origine, situ et magistratibus urbis Venetae ovvero la città di Venetia (1493-1530), a cura di Angela Caracciolo Aricò, Milano 1980, p. 57.
162. A.S.V., Senato Terra, reg. 29, c. 171r (28 ottobre 1537).
163. La data del fallimento in Elia Lattes, La libertà delle banche a Venezia dal secolo XIII al XVII, Milano 1869, p. 98.
164. A.S.V., Consiglio dei Dieci, Zecca, reg. 1, c. 40v (17 dicembre 1545).
165. Paris, Bibliothèque Nationale, Fonds italiens, 1411, cc. 43v-45r; Francesco Ferrara, Gli antichi banchi di Venezia, Palermo 19702, pp. 53-59.
166. Paris, Bibliothèque Nationale, Fonds italiens, 1411, c. 43v.
167. A.S.V., Misc. codici, I, Storia veneta, 66, c. 245v.
168. Venezia, Museo Correr, Cod. Cicogna, 2853, c. 168v.
169. A.S.V., Consiglio dei Dieci, Comuni, reg. 27, c. 174v (15 gennaio 1567).
170. Ivi, Misc. codici, I, Storia veneta, 66, cc. 245v, 248r, 251v. Per vari fallimenti accaduti in altre piazze fra gli anni Sessanta e Settanta cf. J. Delumeau, Vie économique et sociale de Rome, pp. 894 ss.
171. A.S.V., Misc. codici, I, Storia veneta, 66, c. 251v; Nunziature di Venezia, IX, p. 326 (9 agosto 1570).
172. A.S.V., Senato Terra, f. 55 (9 agosto 1570).
173. Venezia, Museo Correr, Donà dalle Rose, 26, libriccino rilegato alla fine del volume; A.S.V., Consiglio dei Dieci, Zecca, reg. 3, cc. 91 v-92r.
174. Ibid., cc. 92v-93r, 94r.
175. Ivi, Senato Terra, f. 55 (9 agosto 1570). Cf. anche Brian Pullan, The Occupations and Investments of the Venetian Nobility in the Middle and Late Sixteenth Century, in Renaissance Venice, a cura di John R. Hale, London 1973, pp. 390-391 (pp. 379-408).
176. L'elenco dei beni di Angelo Sanudo è riprodotto da Arturo Magnocavallo, Proposta di riforma bancaria del banchiere veneziano Angelo Sanudo (secolo XVI), in AA.VV., Atti del congresso internazionale di scienze storiche, IX, Roma 1904, pp. 413-417 (pp. 403-417); B. Pullan, The Occupations and Investments, p. 384.
177. A.S.V., Senato Terra, reg. 48, c. 114r; Nunziature di Venezia, X, (26 maggio 1571 - 4 luglio 1573), a cura di Aldo Stella, Roma 1977, pp. 65, 75.
178. A.S.V., Notarile, Atti, b. 8290, cc. 277r ss. (22 maggio 1572); ibid., b. 8293, cc. 192v-193r (1 aprile 1574).
179. Sull'attività di questo mercante numerose informazioni si possono trarre da ibid., bb. 8277-8293, notaio Pier Giovanni Mamoli; un cenno sugli interessi di Lodovici in Levante in Lettres d'un marchand vénitien. Andrea Berengo (1553-1556), présentées par Ugo Tucci, Paris 1957, pp. 94-95 (16 novembre 1555).
180. Cf., ad esempio, A.S.V., Notarile, Atti, b. 3350, c. 58r (8 aprile 1579).
181. B. Pullan, The Occupations and Investments, pp. 384-385.
182. Padova, Archivio di Stato, Nunzi e ambasciatori, b. 9 (10 e 11 marzo 1569, 14 aprile 1570).
183. A.S.V., Provveditori al sal, reg. 51, c. 9r (25 agosto 1570); ivi, Senato Terra, reg. 52, c. 236r (28 dicembre 1579).
184. Cf. la parte istitutiva riportata in E. Lattes, La libertà delle banche a Venezia, p. 109.
185. A.S.V., Senato Terra, reg. 48, c. 169r-v (5 gennaio 1572).
186. Ivi, Consiglio dei Dieci, Zecca, reg. 3, c. 217v (4 dicembre 1577): il Banco doveva depositare in Zecca 35.000 ducati a titolo di prestito senza interesse.
187. Ivi, Senato Terra, reg. 52, cc. 92v-93r (1 settembre 1578); Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, ms. it. cl. VII. 811 (= 7299), c. 11r-v.
188. B. Pullan, The Occupations and Investments, pp. 384-385; U. Tucci, Il Banco della Piazza di Rialto, p. 232.
189. A.S.V., Misc. codici, I, Storia veneta, 66, cc. 242v-243r.
190. Ivi, Senato Terra, reg. 43, c. 149r (20 gennaio 1562).
191. L'interessante discussione si trova ivi, Memorie per servire ai vacui dei Commemoriali, III, cc. 464r ss.
192. Ivi, Avogaria di Comun, b. 374, fasc. 54 (3 luglio
1623).
193. Ivi, Senato Terra, reg. 55, cc. 107v-110v (28 dicembre 1584); reg. 56, cc. 20v-21r (8 aprile 1585); Simancas, Archivo Generai, Estado, leg. 1341, disp. del 19 gennaio 1585; E. Lattes, La libertà delle banche, pp. 101 ss.; U. Tucci, Il Banco della Piazza di Rialto, p. 238.
194. Per la discussione trecentesca, Gino Luzzatto, Les banques publiques de Venise. Siècles XVI-XVIII, in Id., Studi di storia economica veneziana, Padova 1954, pp. 226-229 (pp. 225-258); per il dibattito del 1565, A.S.V., Memorie per servire ai vacui dei Commemoriali, III, cc. 470 ss.
195. U. Tucci, Il Banco della Piazza di Rialto, pp. 240-241.
196. Ibid., p. 248.
197. Cit. da G. Luzzatto, Les banques publiques, p. 233.
198. Ibid., pp. 236 ss.; U. Tucci, Convertibilità e copertura metallica, pp. 354-357.
199. A.S.V., Senato Giro, f. 1.
200. Ibid. (24 gennaio 1620).
201. Cf. i dati in U. Tucci, Convertibilità e copertura metallica, p. 370; G. Luzzatto, Les banques publiques, p. 239; e A.S.V., Senato Giro, f. 2 (26 dicembre 1624 e 25 settembre 1626).
202. A.S.V., Senato Zecca, reg. n.n., cc. 91v, 103v-104r (28 giugno e 13 ottobre 1629); U. Tucci, Convertibilità e copertura metallica, p. 365.
203. A.S.V., Archivio privato Correr, 189, cc. 40-41.
204. Cf. Ugo Tucci, Miti e realtà di Venezia negli scritti degli economisti, in AA.VV., Storia della cultura veneta, 5/II, Il Settecento, Vicenza 1986, pp. 447-448 (pp. 435-458).
205. F.C. Lane, Storia di Venezia, pp. 376-377; Giulio Mandich, Formule monetarie veneziane del periodo 1619-1650, in AA.VV., Studi in onore di Armando Sapori, II, Milano 1957, pp. 1154-1156 (pp. 1145-1183).
206. La tab. è ripresa da Reinhold C. Mueller, Monete coniate e monete di conto nel Trevigiano, in Due villaggi della collina trevigiana: Vidor e Colbertaldo, a cura di Danilo Gasparini, II, Il Medioevo, Vidor 1989, pp. 334-335 (pp. 325-335).
207. La quotazione dello scudo d'argento passò da lire 8 s. 8 a lire 9 s. 6 (A.S.V., Compilazione leggi, b. 230, c. 208v). Si vedano anche i dati sul corso dei cambi delle principali monete a Bassano nel primo Seicento in Gabriele Lombardini, Pane e denaro a Bassano. Prezzi del grano e politica dell'approvvigionamento dei cereali tra il 1501 e il 1799, Vicenza 1963, pp. 44-49, 83, 92-93, 103-104. Per chiarire il ruolo dei fattori monetari nel quadro dell'economia cf. Carlo M. Cipolla, Mouvements monétaires dans l'Etat de Milan (1580-1700), Paris 1952, pp. 13 ss.
208. A.S.V., Senato Terra, f. 58 (20 febbraio 1572). In seguito alla protesta del prestigioso capitano il senato decise di donare a Prospero Colonna mille ducati (ibid., reg. 48, cc. 177v-178r).
209. Per le quotazioni del 1606 e 1608, ibid., f. 172 (30 gennaio 1606), e ivi, Archivio privato Contarini, in Archivio privato Marcello Grimani Giustinian, b. 5, c. 15 del reg. Maria Ragazzoni; il dato del 1635 è esposto in tab. 3.
210. Ivi, Senato Zecca, reg. III, cc. 11v-12r; Nicolò Papadopoli Aldobrandini, Le monete di Venezia, I-III, Venezia-Milano 1893-1919: III, p. 97. Cf. anche A.S.V., Senato Zecca, reg. n.n., cc. 115V (17 aprile 1619), 124v-125v (9 settembre 1621).
211. Notizie circa le monete di conto in Levante si trovano in N. Papadopoli Aldobrandini, Le monete di Venezia, II, pp. 484, 495.
212. Relazioni dei rettori veneti in terraferma, XI, a cura di Amelio Tagliaferri, Milano 1978, p. 243.
213. A.S.V., Collegio, Relazioni, b. 81 (16 febbraio 1595).
214. N. Papadopoli Aldobrandini, Le monete di Venezia, III, pp- 945, 947-948.
215. A.S.V., Giudici di petizion, b. 346, fasc. 59 e 65 (I maggio e 27 luglio 1616).
216. Ivi, Notarile, Atti, b. 14046, fasc. II (2 ottobre 1571) per Lodovico Priuli; fasc. I, c. 11r (14 maggio 1568) per Mussolino.
217. Pavia, Biblioteca Universitaria, Manoscritti Aldini, 83, c. 22v (24 dicembre 1554).
218. A.S.V., Senato Terra, f. 58 (20 febbraio 1572); ivi, Misc. Gregolin, b. 34 (23 e 24 ottobre 1573); Genova, Archivio di Stato, Archivio segreto, Lettere consoli, b. 2704, lett. dell'8 novembre 1614. Sulla domanda d'oro delle truppe spagnole cf. Fernand Braudel, L'Italia fuori d'Italia. Due secoli e tre Italie, in AA.VV., Storia d'Italia, II, 2, Dalla caduta dell'Impero romano al secolo XVIII, Torino 1974, pp. 2163-2164 (pp. 2091-2248), nonché le osservazioni di René Quatrefages, Los tercios españoles (1567-1577), Madrid 1979, pp. 184-185.
219. A.S.V., Consiglio dei Dieci, Zecca, reg. 3, c. 104r (15 febbraio 1571); N. Papadopoli Aldobrandini, Le monete di Venezia, II, p. 741.
220. T. Coryat, Crudezze, p. 305.
221. Ugo Tucci, Le emissioni monetarie di Venezia e i movimenti internazionali dell'oro, in Id., Mercanti, navi, monete, pp. 306-308, 311 (pp. 257-316). Il confronto con la zecca di Londra si basa sui dati forniti da Harry Miskimin, Money and Money Movements in France and England at the End of the Middle Ages, in Id., Cash, Credit and Crisis in Europe, 1300-1600, London 1989, p. 95 (pp. 79-96).
222. Enrico Magatti, Il mercato monetario veneziano alla fine del secolo XVI, "Nuovo Archivio Veneto", n. ser., 27, 1914, p. 252 (pp. 245-323); G. Mandich, Formule monetarie, pp. 1156-1157.
223. Bilanci generali, pp. 601-602 (23 luglio 1572).
224. A.S.V., Senato Terra, reg. 70, cc. 28v, 78r-v (16 maggio e 19 agosto 1600).
225. G. Mandich, Formule monetarie, p. 1176.
© Istituto della Enciclopedia Italiana - Riproduzione riservata