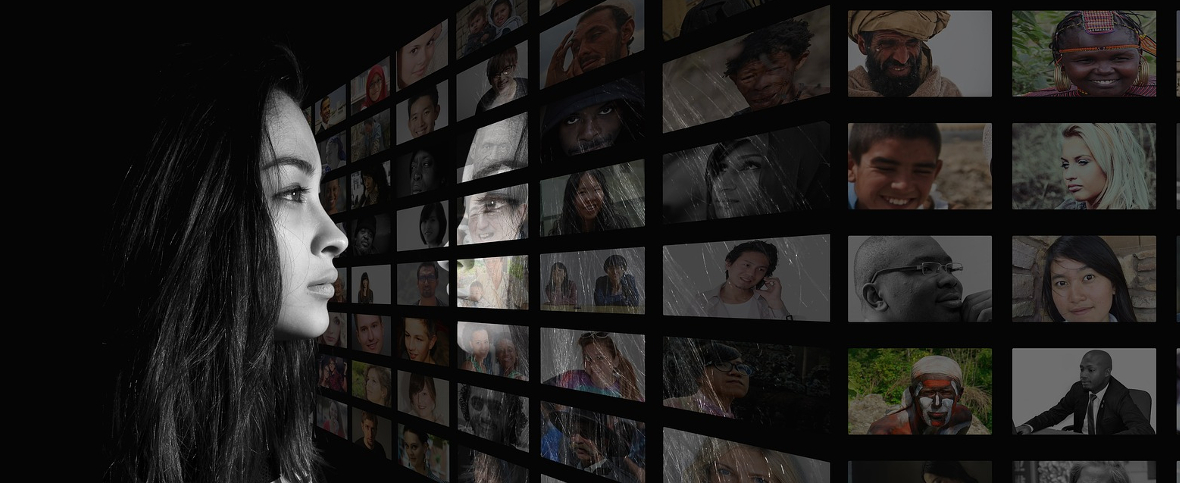La parete della camera da letto è abbattuta e nulla sarà più uguale a prima, dopo il selfie pubblicato da Elisa Isoardi per annunciare la rottura del legame amoroso con il ministro degli Interni Matteo Salvini. Ciò che un tempo ci era stato imposto di immaginare soltanto, il corpo erotico del capo, l’ultima intimità, viene ora esibito e rivendicato. Gli indizi che sarebbe avvenuto c’erano tutti. Le seguitissime pagine social di Salvini somigliano a quelle di una persona qualunque, e il suo corpo morbido, normale, è già apparso in decine di foto balneari estive. Il senso di vicinanza alla quotidianità della comunità di riferimento è sottolineato anche dalla pervasiva presenza del cibo: piatti della tradizione o junk food, fino allo spot per i prodotti di una pescheria pugliese. Il leader leghista fa uso sapiente del senso di identità culturale e di condivisione offerto dal cibo; i fan apprezzano, consigliano ricette e si preoccupano addirittura per la sua digestione.
«La cosiddetta politica pop è una tendenza dei politici, leader o candidati, a rendere popolare la loro immagine, ricorrendo ai formati tipici dei mass media e dei social media per pubblicizzare il loro privato, i loro gusti, le loro vite». A parlare è Gianpietro Mazzoleni, docente di Sociologia della comunicazione e autore di testi di riferimento come La comunicazione politica e Politica pop (con Anna Sfardini, entrambi editi da il Mulino), secondo cui «la vera rivoluzione è stata la mediatizzazione televisiva della politica. La strategia della spettacolarizzazione ha imposto tra le sue regole la visibilità del privato: il non detto, le emozioni o l’intimità della propria vita familiare e privata».
Lontani i tempi della politica discreta: François Mitterrand nascose ossessivamente per anni la sua seconda famiglia, storia che venne alla luce in prossimità della morte nel 1996; Aldo Moro vestiva la giacca persino in spiaggia, perché come rappresentante del popolo italiano sentiva di dover essere sempre dignitoso; Angela Merkel per consumare street-food si nasconde come la madre di Portnoy nel celebre Lamento di Philip Roth.
Il fenomeno fa parte della creazione di quel marketing politico i cui fondamenti sono stati teorizzati dal politologo Walter Lippman: i media sarebbero gli strumenti utilizzati da una élite di specialisti e burocrati per dominare la popolazione senza ricorrere alla coercizione fisica; la costruzione del consenso passerebbe attraverso la manipolazione della massa dei cittadini, non qualificati sui grandi temi ma il cui coinvolgimento è necessario in democrazia.
La legittima domanda è dunque se il politainment, la comunicazione politica diluita e contaminata con altri tipi di spettacolo, sia capace di suscitare interesse e partecipazione nei cittadini, o se questo tipo di comunicazione produca solo divertimento ed emozioni. Secondo Mazzoleni, «la ricerca sociologica in Italia non ha ancora dato risposta certa a questi interrogativi. Una serie di studi internazionali ha tuttavia messo in luce che il matrimonio tra politica e cultura popolare può paradossalmente rappresentare una scialuppa di civismo per quei cittadini distanti dal mondo della politica. Programmi televisivi che sembrano alieni alla sfera della comunicazione politica, come il Grande Fratello, possono essere delle scuole di partecipazione civica. È quanto alcuni studiosi come John Street e Stephen Coleman sostengono, ravvisando nei rituali di televoto» – così come nell’interazione di una pagina social – «uno stimolo a convincersi dell’efficacia del proprio voto anche in altre arene, come quella delle elezioni politiche».
D’altra parte, però, non possiamo non riflettere sul fatto che, come sottolineava Guy Debord nella Società dello spettacolo, lo spettatore più contempla, meno vive; più accetta di riconoscersi nelle immagini dominanti del bisogno, meno comprende la propria esistenza e il proprio desiderio.
© Istituto della Enciclopedia Italiana - Riproduzione riservata