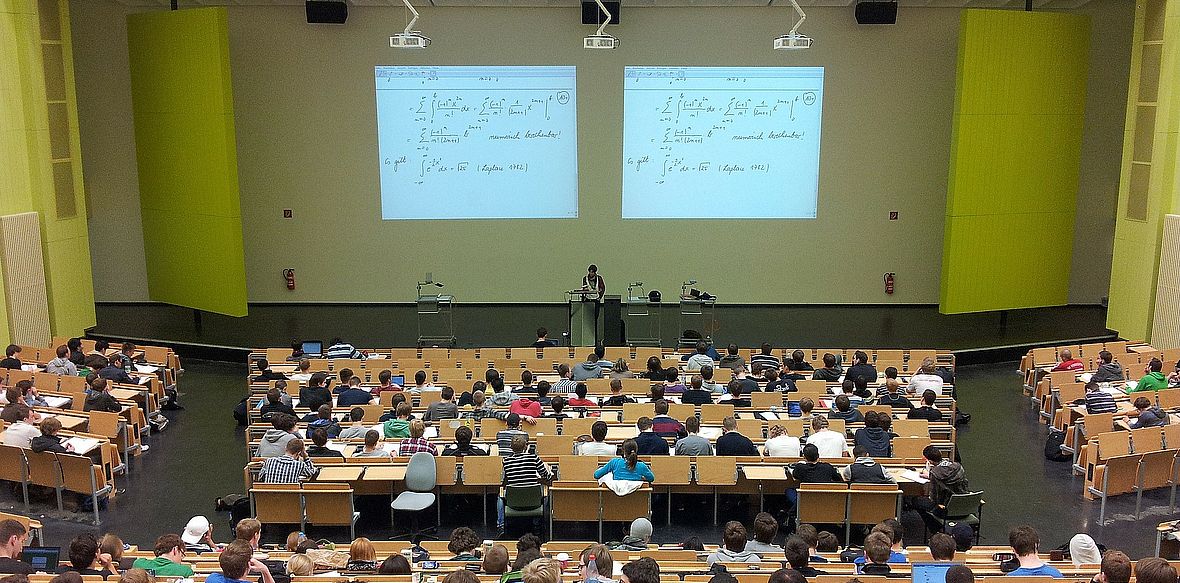Qualche giorno fa, nel commentare il bilancio degli aiuti europei in arrivo, Roberto Perotti illustrava su Repubblica “l’errore diffuso” secondo cui l’Italia riceverà «un regalo di 82 miliardi dagli altri Paesi europei» chiarendo che i fondi non saranno un omaggio: la cifra verrà erogata grazie al debito europeo che i paesi membri ripagheranno con “tasse percepite direttamente dall’Ue”»; a questa, poi, si aggiungeranno altri 91 miliardi emessi come prestito al nostro Paese che andrà restituito integralmente e con gli interessi. Cifra complessiva al momento stimata: 170 miliardi (la Repubblica, 28/05/2020).
Perotti affianca alla sua analisi un provocatorio interrogativo: siamo certi che avremo modo di spendere tanto denaro? «Quanti miliardi servono – scrive – per mettere in sicurezza le scuole o per regalare un computer ad ogni studente? O per completare la rete 5G su tutto il territorio nazionale? O per assumere 10.000 medici? Quando avremo fatto tutto questo, ci avanzeranno molto più di cento miliardi». Conclude dunque con un condivisibile timore: «Non basta l’etichetta di “investimento pubblico” per rendere una spesa automaticamente virtuosa. Il rischio è che gran parte di quei 170 miliardi vada a finire non solo in spesa improduttiva, ma addirittura dannosa, perché un tale fiume di denaro può scatenare gli appetiti, la corsa a finanziare i progetti più inutili soltanto per assicurarsi una fetta della torta, perché “tanto i soldi ci sono”».
Per non sprecare l’eventuale esubero (e per scongiurare il plausibile rischio di un utilizzo a opera di mani sbagliate), ci si potrebbe avvalere di un antidoto semplice quanto efficace: dopo avere provveduto alle emergenze – dalla sicurezza delle scuole all’assunzione dei medici – si potrebbe destinare la rimanenza a un soggetto in grado di farla fruttare producendo utili con cui coprire gli interessi debitori e generare valore a vantaggio della collettività; inoltre, per prevenire ogni possibile tentazione, sarebbe meglio si trattasse di un soggetto che normalmente affida le proprie risorse non a un organismo decisionale centralizzato ma a una collettività decentralizzata, ricca di intelligenze, composta da attori non legati da interessi economici lobbistici o privati.
L’ipotesi sembra ragionevole. Ma esiste un simile soggetto in Italia?
Si consolino i disfattisti in ansia per assenza di risposte: esiste e si chiama università.
Il denaro in prestito ha due tradizionali utilizzi: o lo si usa per coprire spese improrogabili, oppure lo si adopera per fare impresa, di modo da produrre nuovo capitale e guadagno. Da cui l’interrogativo: risolte a opera dello Stato le spese improrogabili, che capitale potrebbe produrre l’università per ripagare gli interessi della cifra ricevuta e generare guadagno a vantaggio del Paese?
Beh, se stanno pensando al portafoglio, gli ansiosi disfattisti possono rasserenarsi: c’è da essere ragionevolmente certi che l’università produrrebbe valore economico. Lo sviluppo di idee, materiali, soluzioni, tecnologie, sapere medico e così via si traduce in breve in impresa e in sviluppo, attivando il virtuoso ciclo del bisogno di forza-lavoro con relativa creazione di occupazione e ricavi per il tessuto sociale. Ma l’università avrebbe il vantaggio di produrre anche un altro valore: quello che con un termine che oggi suona forse troppo deja entendu venne definito da Gary Becker il capitale umano.
Come si lega il capitale umano alla produzione di valore economico?
Un movimento sempre crescente sostiene che il benessere di una intera società non può essere affidato a un solo parametro, a un solo numero, quale per esempio il PIL. Nel suo Why governments should prioritize well-being, la primo ministro scozzese Nicola Sturgeon ha dichiarato che «l’obiettivo della politica economica dovrebbe essere il benessere collettivo della società». Sono parole che vengono da una nazionalista nordica, non da una corista dell’Internazionale che intona le sue note da qualche altipiano dell’America Latina. Il desiderio di una nuova economia è diffuso, prescinde dall’appartenenza politica. Intervenendo ai microfoni di NPR, la National Public Radio statunitense, Kate Raworth, economista che lavora per le Università di Oxford e Cambridge, ha affermato di recente: «la crescita è entusiasmante: è facile da misurare, è facile da ammirare; ci hanno venduto questa idea che la crescita è il percorso verso la prosperità. Non è male, non necessariamente. Ma c’è un momento in cui si cresce cresce cresce e si scopre che c’è un sacco di gente che è rimasta indietro. La crescita è importante, ma non risolve tutti i problemi».
Su questioni non lontane da queste, l’economista e banchiere Muhammad Yunus ha rivelato un dato etologico di straordinario interesse: «Gli esseri umani nascono imprenditori, non cercatori di un posto di lavoro». In un articolo di qualche settimana fa, insisteva sull’importanza di un ripensamento della relazione cultura/economia in un momento storico come questo: «La vicenda del coronavirus ha improvvisamente cambiato il contesto e le misure del mondo. Ha aperto la via a possibilità audaci che non erano mai esistite prima. All’improvviso, siamo alla tabula rasa. Possiamo andare in qualsiasi direzione vogliamo: un’incredibile libertà di scelta. Prima di riavviarla, dobbiamo stabilire quale tipo di economia globale vogliamo» (“No going back”, The Kathmandu Post, 13/05/2020).
I valori di una impresa sociale – aperta al benessere delle persone e attenta a un progresso che non sia esclusivamente economico e appannaggio di poche oligarchie imprenditoriali – potrebbero trovare nell’università un teatro ideale dove sperimentare i modi di una ripensata crescita. E perché mai questo non dovrebbe accadere (anche) in Italia, fazzoletto del mondo la cui trama fu filata dal pregiato lavorìo di culture, arti e intelletti?
L’università potrebbe farsi luogo di incontro tra le risorse che nel nostro contesto sociale contribuiscono a coltivare questa rosa di valori. Non solo l’educazione e la ricerca, ma anche la cultura lato sensu e l’attivismo sociale. Penso ai teatri, penso all’arte, ai musei, alla danza, alla musica, alle esperienze di recupero e al grande patrimonio culturale e umano tenuto in piedi da talentuose speranze (di ogni età e provenienza) spesso sottovalutate, dimenticate, sottopagate nel nostro Paese.
Certo, anche l’università avrebbe bisogno di ripensarsi. Ma sono certo che, se fosse lasciata libera di farlo, ne avrebbe le risorse. Ciò che la ha danneggiata in anni recenti è stata proprio l’assunzione di un modello aziendalista votato al PIL. Bisognerebbe invertire la tendenza, operare una rivoluzione copernicana come quella che folgorò i contemplatori di cieli del Cinquecento e i pensatori europei entusiasti del kantismo: non l’università dovrebbe seguire (e inseguire) i modi di una economia che ha lasciato indietro molte, troppe vite; semmai l’economia – il cosiddetto mercato del lavoro – dovrebbe apprendere dal laboratorio universitario nuovi modi di produrre valore.
Al potere politico spetta il compito d’incoraggiare questo processo, consapevole che la sua università non è un luogo di perdizione i cui adepti vanno tenuti al ceppo; è invece un luogo pieno di creatività, idee e desideri per un futuro più giusto, ecologico e inclusivo. Bisognerebbe incentivare e finanziare quei ricercatori che promuovono progetti volti al benessere diffuso del Paese, che promuovono cultura, arte e bellezza, che aiutano le persone a credere nei propri sogni, nei propri progetti, che fanno rete con le altre risorse culturali, artistiche e sociali, nazionali e internazionali. Ci sarebbe spazio per pensare al restauro e al consolidamento del patrimonio artistico e naturalistico; ci sarebbe impulso per aprire musei all’aperto che tutelino le nostre valli, i borghi, le coste, la natura; ci sarebbe modo di creare dialogo con le realtà artistiche, editoriali e del terzo settore; andrebbero moltiplicati i festival, i centri culturali, le produzioni artistiche ispirate agli studi; si dovrebbe incentivare le migliaia di realtà che attendono solo un po’ di risorse e di incoraggiamento per ridare fiato al proprio entusiasmo e alle proprie idee.
Se sogneremo insieme questa università – al limite anche ricorrendo a un briciolo d’ingenuo utopismo – non ci sarà debito da temere. Perché avremo scoperto di avere nel cuore una ricchezza che tutto il mondo per secoli ci ha invidiato.
Crediti immagine: Foto di Nikolay Georgiev da Pixabay
© Istituto della Enciclopedia Italiana - Riproduzione riservata
Argomenti